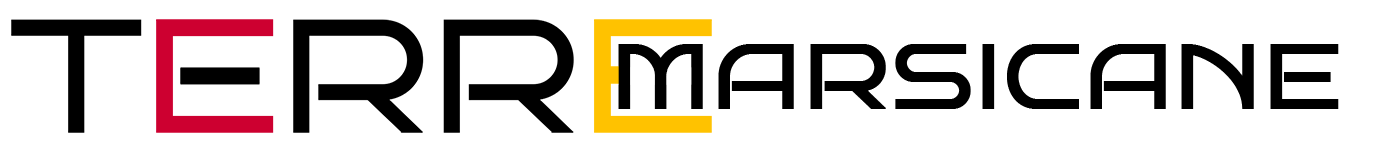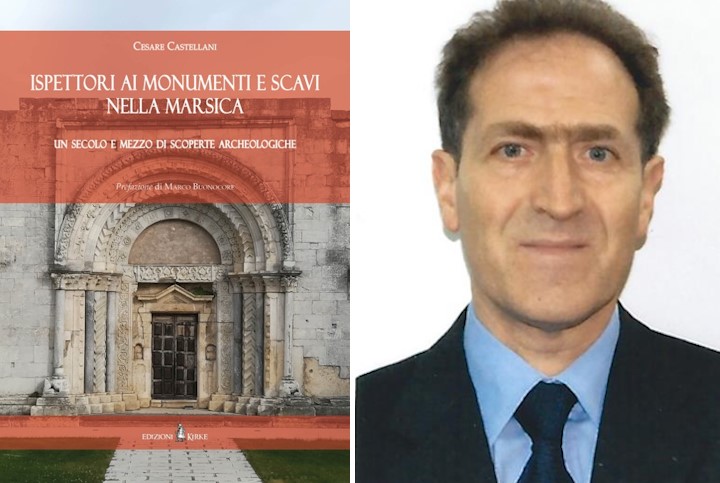


Liberati dal terremoto: i detenuti di Avezzano prestano i primi soccorsi
Avezzano – A 35 anni di distanza, il terremoto della Marsica sembra essere dimenticato, mentre la portata ed il danno non furono inferiori al maremoto del 1908 di Messina. La data del 13 gennaio 1915, fu fatale per migliaia e migliaia di abitanti e di paesi della conca del Fucino nella provincia dell’Aquila. Il Fucino era un lago, ed in esso si versavano parecchi torrenti che, aumentandone il vo-lume, causavano frequentemente inondazioni alle terre circo-stanti. Fin dai tempi dell’Imperatore Claudio, fu costruito un canale sotterraneo per scaricare le acque del Liri, ma questo emissario col tempo si ostruì. Il prosciugamento del lago è opera recente del principe Torlonia.
Avezzano, 13 gennaio Il paese, nel grigio mattino ancora era immerso nel silenzio. Tutta la notte c’era stata una sarabanda infernale: la fu-ria degli elementi scatenati, lo incessante latrato dei cani, il nitrito dei cavalli, l’inquieto be-lare degli armenti. I lampioni, nelle strade, erano ancora acce-si e solo pochi contadini s’era-no alzati e alcuni erano già in cammino per le strade della campagna. I 16 mila abitanti dormivano ancora tranquilli, quando, alle 7,56, preceduto da rabbiose fo-late di vento, sì udì venire da un lontano punto imprecisato un boato sotterraneo, che esplose con fragore spaventoso.
La terra si gonfiò e sobbalzò tanto violentemente che i gabinetti sismici segnarono il 7 grado nella scala Mercalli. Le case traballarono: i tetti si aprirono e si chiusero col movimento istantaneo delle palpebre, ed attraverso quelle aperture momentanee, si potè vedere la danza macabra delle case che, sollevate di peso, ricaddero ammassate a terra come una gigantesca frana. Le strade si torsero e si spaccarono ed in pochi secondi il paese fu un cumulo di macerie. Le poche persone che erano riusciti a fuggire dalle case in crollo, si videro seminude, smarrite e sfigurate dallo spavento, vagare fra montagne di macerie. Ai loro richiami disperati rispondevano gli urli, i lamenti dei parenti rimasti sepolti. Si chiamavano come per ritrorarsi, come per confortarsi ad ogni successiva scossa di assestamento della terra. Avezzano non c’era più. Il movimento tellurico di cui era stato l’epicentro, si era esteso per un raggio di 160 chilo-metri distruggendo tutti i paesi circostanti. Ridotto ad un ammasso di macerie che cancellava strade e piazze, restava solo in piedi qual-che metro di muro maestro, miracolosamente scampato. La Chiesa era stata anch’essa squarciata e, dalle crepe profonde scavate tra le arcate massiede delle navate, si vedevano le sacre immagini sparute, co-me in una scena di apocalisse. Una pesante cortina di polvere gravava su quella scena desolata. I pochi superstiti, come per ironia, furono vecchi, donne, bambini. Uno storpio, seduto su un masso, agitava rabbiosamente le grucce e imprecava contro la morte che l’aveva risparmiato. Quasi tutti erano feriti. Ognuno cercò di raccogliere qualcosa affiorata sul cumulo di macerie della propria casa: una coperta, un cappotto, un materasso; altri si tirava dietro la capra o la mucca da latte.
Si raccolsero attorno ad un fuoco all’aperto Le donne piangevano e vociavano: chi chiamava le persone care, chi allibita dal dolore taceva, gli occhi fissi nel vuoto: qualcuna pregava, molte imprecavano come i loro uomini. I bimbi sorpresi nel sonno, intirizziti dal freddo e spaventati, non cessavano di lamentarsi. Una donna impazzita sulle macerie della propria casa, urlò un nome, s’abbattè su un piccolo corpo esanime dagli occhi vitrei sbarrati come la morte l’aveva lasciato. L’urlo crebbe in potenza, si mutò in gemito, poi si smorzò nella gola stessa della donna che cadde svenuta sulla sua creatura. Il capostazione fu ritrovato carbonizzato ed appeso al palo del telegrafo.
Un’altra donna, con un bimbo in braccio ed un altro afferrato alla sua veste, rimasero aggrappati ad un pezzo dí muro e sospesi all’altezza del secondo piano. Alle grida disperate qualcuno accorse, ma, nella manovra difficile del salvataggio, la donna precipitò a terra sfracellandosi il cranio. Dei bimbi uno soffocò, l’altro rimase miracolosamente illeso. Le autorità del paese erano virtualmente morte, l’ospedale distrutto, le comunicazioni interrotte e, pertanto, era impossibile organizzare un pronto soccorso.
Va segnalata l’opera prestata dai detenuti, riusciti a fuggire e il carcere e la morte. Essi lavoravano senza tregua con pale e picconi prima e dopo l’arrivo delle squadre di soccorso. Nessuno li aveva comandati, ma i poveri disgraziati, forse perchè privati per tanti anni della libertà, viste aperte le loro celle capirono com’è grande il dolore di chi non può muovere i passi per soccorrere i propri familiari che muoiono. Io stessa fui salvata da loro. I superstiti, la notte, si serrarono più compatti attorno al fuoco che illuminava sinistramente quei visi disfatti, come in un quadro fiammingo. Consunti nei panni e nel viso, erano vivi solo negli occhi. Intanto i feriti a uno, a due, a tre, portati a spalla, continuavano ad affluire. La notte fu un ininterrotto lamento.
Alle grida soffocate di quelli che, ancora non soccorsi, perivano miseramente sotto le macerie rispondevano, nella notte, gli ululati famelici dei lupi che, attratti dall’odore di carne umana in decomposizione, scesero al macabro banchetto, dai circostanti monti coperti di neve. Soltanto alle prime luci del giorno seguente, giunsero auto-mezzi con uomini, viveri e l’o-pera di salvataggio incominciò. Gli uomini addetti concentrarono ogni sforzo per salvare le vite umane che ancora palpita-vano sotto le macerie e casi tutti difficili di salvataggio si operarono con mirabile eroismo.
I feriti furono caricati sulle ambulanze e su autocarri per es-sere trasportati agli ospedali di Roma. I morti (circa 11 mila) dagli occhi sbarrati, denti stretti, mani irrigidite, dicevano il medesimo strazio di una morte di terrore. L’asfissia aggiungeva qua e là il colore paonazzo e l’assideramento quello bianco cera. Furono dapprima allineati nudi o seminudi, poi caricati alla rinfusa sui carri per essere sepolti in una fossa comune, poichè la loro decomposizione era ormai in stato avanzato, dato che erano rimasti esposti alla pioggia, al nevischio e al vento. E mentre l’opera e la pietà degli uomini era accorsa verso quei miseri e si stava dando mano ai lavori di ricostruzione, un altro cataclisma avanzava: la guerra ’15-’18.
Danni e lutti allora si estesero e moltiplicarono e la fiducia nella vita, a stento riaffiorata nell’animo di quei derelitti, soffocò, e l’angoscia dei giorni vissuti tornò per altre vie, a torturare lo spirito.
Annunziata De Santis
PROMO BOX

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Avezzano (AQ) n.9 del 12 novembre 2008 – Editore web solutions Alter Ego S.r.l.s. – Direttore responsabile Luigi Todisco.
TERRE MARSICANE È UN MARCHIO DI WEB SOLUTIONS ALTER EGO S.R.L.S.