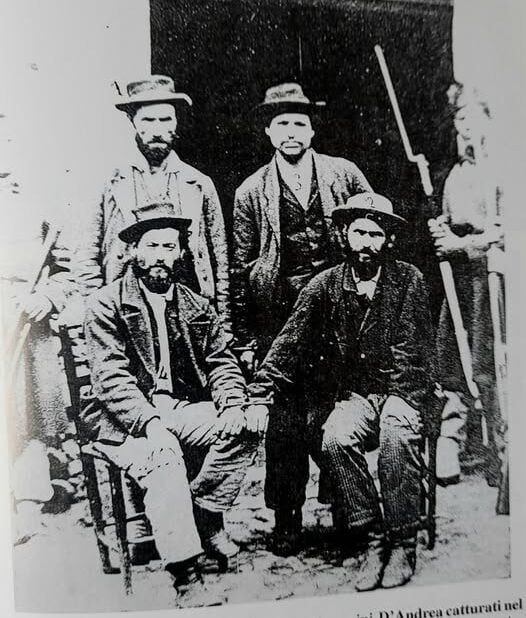“La storia musicale di Cerchio e Aielli: dai graduali del XV secolo ai grandi personaggi ecclesiastici”
n occasione della stesura del volume “ La musica sacra nella provincia dell’Aquila la Marsica”, lavoro scritto a più mani e pubblicato nel 2009 per la benemerita Casa Editrice Ianieri Editore di Pescara ho partecipato scrivendo “ I codici musicali di Cerchio e la loro importanza per la storia locale “. Qui mettevo in evidenza sia i tre graduali ( di cui due manoscritti ascrivibili alla prima metà del XV secolo e l’altro a stampa pubblicato a Venezia nel 1548 ) sia, giocoforza, i vari personaggi che furono attori in quel preciso lasso di tempo : Mons. Janitella di Aielli vescovo di S. Angelo dei Lombardi e gli abati generali dell’Ordine dei Celestini: i cerchiesi Pietro Capocitto, il Vecchio, pronipote di Mons. Janitella e zio dell’altro Pietro Capocitto, il Giovane, a sua volta, quest’ultimo, zio dell’altro abate generale sempre dello stesso ordine, Pietro di Aielli, figlio della propria sorella ( al momento, non conosciamo come si chiamasse ) e questi, a sua volta, zio dell’altro generale dell’Ordine dei Celestini Francesco Macerola ( o Maceroni) di Aielli.
Pietro Capocitto il Vecchio, era il pronipote di Mons. Pietro Janitella, “ex nepta pronepos”, cioè figlio del figlio ( o della figlia) della propria sorella che al momento nessuno, di questi, conosciamo. Mons. Janitella il 4 Luglio 1431, partecipò ufficialmente in qualità di vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, all’elezione del nuovo vescovo dell’Aquila Monsignor Amico Agnifili di Rocca di Mezzo : tre paesi limitrofi sono legati fra loro dalla storia umana di questi grandi personaggi che tanto onore e gloria riuscirono a conquistarsi nel mondo ecclesiastico di allora grazie alla loro vivida e fervida intelligenza.
Nel sopra menzionato lavoro, il mio intervento era rivolto quasi esclusivamente alla descrizione dei tre citati preziosi graduali esposti nel locale Museo Civico di Cerchio (AQ) ed avevo appena tratteggiato, quasi en passant, le figure di questi personaggi. Mi ero ripromesso di affrontare in modo più ampio e approfondito la storia e le vicissitudini di questi illustri protagonisti ed eroi dei piccoli centri dell’entroterra abruzzese mettendo in evidenza, per quanto mi era possibile, il loro operato , il periodo in cui questi vissero e descrivere anche altri attori più o meno noti degni di essere ricordati e menzionati in questo mio modesto scritto che nulla pretende né, nel modo più assoluto, vuole essere esaustivo.
Attraverso l’attenta lettura dei 10 volumi di Ludovico Zanotti editati dal 1995 al 1999 dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria ( 1 ), di Muzio Febonio, di Pietrantonio Corsignani, di Andrea Di Pietro, di Giacinto Marinangeli, di Francesco Russo, di Antonio Manfredi e di Maria Rita Berardi e altri abbiamo appreso molte ed importanti notizie riguardanti l’operato dei Nostri personaggi.
Prima, però, di parlare dei sopraccenati personaggi è doveroso portare all’attenzione dei lettori le notizie dell’altro prelato aiellese Mons. Gentile d’Aielli che apre questa speciale carrelata degli “ Homines Novi “ appartenenti a tre paesi limitrofi ubicati a Nord della conca fucense e sicuramente legati da una comune storia civica e, anche, molto probabilmente, forse, da vincoli parentali o amicali.
Alla fine del XIV secolo, Gentile di Aielli, canonico della chiesa di S. Sebastiano, ubicata nell’omonimo paese di San Sebastiano, ed “ in iure civili peritum “, viene eletto, il 28 Luglio 1384, da papa Urbano VI ( 1318-1389), alla carica di Vescovo della diocesi dei Marsi che governò per 14 anni fino al 4 Novembre 1398 cioè fino a quando il Nostro non venne trasferito da papa Bonifacio IX (1350?-1404) nella diocesi di Nicastro dove rimase fino al 1418 e da questa data fu, successivamente trasferito, da papa Martino V, alla diocesi di Sessa Aurunca:
“[…]133[…]GENTILE del Vescovado di Nicastro fu trasferito a questo di Sessa a 23 Gennaio 1428 dal mentovato Martino V nel mentr’era in Costanza. Quindi si trova nominato in uno strumento rogato per Not.[aio] Antonio Corbo di Sessa à 19 Decembre 1419, con cui si riassume per decreto della Corte Vescovile un privilegio conceduto da Gregorio Som.[mo] Pontefice a’ Frati del Monistero di S. Croce Massico, qual’istrumento si conserva nell’Archivio di S.Agostino di Sessa. Egli era morto, o era stato altrove trasferito prima dell’anno 1425; poiché in tal anno si trova esser Commendatario della sua Chiesa il Cardinal Tarentino(a)[…](a) Ughelli loc. cit[…]” (2)
( vedi anche pp. 241, 242 di P. Francesco Russo: “ La Diocesi di Nicastro “, C.A.M. Napoli, 1958 e cronotassi della Diocesi di Lamezia Terme e cronotassi della Diocesi di Sessa Aurunca).
Nell’archivio della Diocesi dei Marsi in Avezzano, si conservano del Nostro Gentile, 9 documenti pergamenacei che abbracciano un arco di tempo che va dal 1384 al 1403.Tali documenti sono stati egregiamente pubblicati dall’attenta ricercatrice Maria Rita Berardi nel suo ottimo lavoro : “ Una diocesi di confine tra Regno di Napoli e stato Pontificio “(3) ( p. 26, 29, 32, 34,35, 36, 37, 39,41, 44, 45 ) che qui, data la loro innegabile importanza si riportano:
“[…]VII
1384 luglio 28, pont. Urbano VI a. 7
Nocera
Papa Urbano VI dà mandato al capitolo della chiesa Marsicana/affinché presti obbedienza e reverenza a Gentile di Aielli, cano-/nico della chiesa di S. Sebastiano in San Sebastiano, esperto di/diritto civile, nominato al governo della diocesi per la vacanza/verificatasi in seguito alla morte del predecessore Giacomo[…]
VIII
1384 luglio 28, pont. Urbano VI a. 7
Nocera
Papa Urbano VI dà mandato al clero della sede e della diocesi dei/Marsi di prestare obbedienza e riverenza al nuovo vescovo Gen-/tile di Aielli, canonico della chiesa di S. Sebastiano in San Seba-/stiano, al quale ha affidato il governo della diocesi che si è resa/vacante per la morte del predecessore Giacomo[…]
IX
1384 luglio 28, pont. Urbano VI a. 7
Papa Urbano VI chiede a re Carlo di Sicilia che conceda il favo-/re regale al nuovo vescovo dei Marsi Gentile di Aielli, già cano-/nico della chiesa di S. Sebastiano della stessa/diocesi, il cui governo gli è stato conferito in seguito alla morte/del predecessore vecovo Giacomo […]
X
1397 luglio 15, ind. V, pont. Bonifacio IX a. 8
Aielli
Il vescovo dei Marsi Gentilis, in premio dei meriti acquisti da/Angelutius Ferrucie e dalla moglie di lui per i servizi resi maiori/ecclesie Marsicane, concede due terreni in loco et territorio pertinen-/tiarum civitatia Marsie, uno posato in lu loco vecchiu, l’altro in campu Sancte Marie, devoluti alla diocesi Marsicana per la morte di nota-/rius Ciccus de Lictio, per i quali terreni i predetti coniugi hanno/già versato alla camera diocesana certa somma e pagheranno un/censo annuo di due soldi[…]
XI
1397 agosto 25, pont. Bonifacio IX a. 8
Aielli
Il vescovo dei Marsi Gentile, d’intesa col capitolo, ratifica in/favore di Antonio, Giovanni e Guglielmo, figli ed eredi di Cola/ di Giovanni della Rocca di Pescina, l’acquisto fatto dal padre, per/ducati trentasette, di due vigne e di una canapina sita in Marsia,/al “campo di S. Giorgio “, inscritte nel censuale tra i possessi della/chiesa cattedrale di S. Sabina e ne riceve ducati sette quale quin-ta solita ad esigersi[…]
XII
1398 novembre 4, pont. Bonifacio IX a. 9.
Roma, San Pietro
Papa Bonifacio IX esorta le popolazioni della diocesi Marsicana/all’obbedienza e alla riverenza verso il nuovo eletto vescovo Filip-/po, il quale vi è stato trasferito dalla diocesi di Pozzuoli, allo/scopo di sanare la vacanza verificatasi dal trasferimento del pre-/decessore vescovo Gentile alla diocesi di Nicastro[…]
XIII
1398 novembre 4, pont. Bomnifacio IX a. 9
Roma, San Pietro
Papa Bonifacio IX comunica al vescovo Filippo che lo ha trasfe-/rito alla diocesi Marsicana da quella di Pozzuoli essendosi verifi-/cata la vacanza della diocesi dei Marsi per il trasferimento del suo vescovo Gentile a quella di Nicastro[…]
XIV
1398 novembre 4, pont. Bonifacio IX a. 9
Roma, San Pietro
Papa Bonifacio IX dà mandato ai vassalli della chiesa Marsicana di/prestare i dovuti onori e la consueta fedeltà al nuovo vescovo Filip-/po, trasferitovi dalla diocesi di Pozzuoli per succedere al predeces-/sore vescovo Gentile trasferito a sua volta alla diocesi di Nicastro[…]
XV
1403 gennaio 17, pont. Bonifacio IX a. 1
Roma
Filippo vescovo dei Marsi consente all’istanza di Luigi, abate/secolare della chiesa di S. Giovanni di Ozanello e rettore della/chiesa di S. Maria di Vivizio (loc. Novizio), presso Aielli, che sia/edificato un ospedale per i poveri nel sito della chiesa di S. Maria/di Vivizio e che sia soggetto a detta chiesa. Concede l’indulgen-/za di giorni 40 sia per i penitenti che per coloro che sovvenzio-/nino la costruzione dell’ospeddale e del suo sostentamento. L’in-/dulgenza sarà lucrata nelle festività singolarmente enunciate e/l’ospedale e il rettore offriranno annualmente, nella festa di S./sabina, un paio di polli alla chiesa Marsicana. Il vescovo tra-/smette la concessione al collegio competente presso la santa sede/perché sia concessa una ulteriore indulgenza e il collegio dei/vescovi al testo della concessione del vescovo accompagna la cor-/roborazione con la data della concessione di altra indulgenza di/giorni 40 (…)”. Fra i vescovi sottoscrittori compare anche il vescovo di Nicastro Gentile di Aielli : “[…] Nos Gentilis episcopus Neucastrensis de consensu et [vo]luntate/predicti reverendi patris domini Marsicani episcopi concedimus/iuxta formam predictarum litterarum quatraginta dies de vera/indulgentia[…]”.
Il 12 ottobre 1399 “ Gentile Vescovo di Nicastro dichiara di aver consacrato quattro altari in Santa Scolastica ( Subiaco n.d.r.) e ne descrive due […]” e il 18 novembre 1406 “[…] Gentile Vescovo di Nicastro dichiara di aver consacrato un altare in Santa Scolastica ( Subiaco n.d.r. )[…]” ( Federici V. “ La biblioteca e l’archivio”, p. 214 )
Nei sopracitati documenti apprendiamo l’importanza e la grande considerazione che aveva il prelato Gentile di Aielli presso i suoi contemporanei.
Chiaramente si evince l’alto consenso che il vescovo Gentile e, sicuramente, la sua famiglia riscuoteva nel panorama politico non solo della nostra subregione marsicana. Consenso che venne premiato dal menziomnato papa Urbano VI che resse la soglia di Pietro dal 1378 al 1389 il quale, molto probabilmente, conosceva da vicino l’operato del Nostro essendo infatti, entrambi nativi del regno di Napoli dove, papa Urbano VI, al secolo Bartolomeo Frignano, era nato a Napoli intorno al 1318.
Sicuramente la scelta di eleggere un vassallo del conte di Celano, in un periodo così burrascoso ed instabile fu dettata da motivi squisitamente politici essendo la nostra subregione marsicana un territorio cerniera posto fra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Il 20 Settembre 1378 infatti, ad appena 5 mesi dalla elezione al soglio pontificio di Urbano VI, fu eletto a Fondi , da cardinali scismatici, l’antipapa Clemente VII ( Roberto da Ginevra 1342-1394 ): episodio questo che diede il via al Grande Scisma d’Occidente che divise il mondo cristiano per quasi quarant’anni. E un anno dopo, nel 1379, la regina Giovanna I ( 1326 -1382 ) di Napoli parteggiò per l’antipapa Clemente VII che vide, di conseguenza, il papa legittimo, Urbano VI, andare con un agguerrito esercito contro Giovanna e, in seguito a ciò, incoronò re di Napoli Carlo III di Durazzo ( 1345-1386 ).
.
Anche la classe dirigente della Marsica si vide costretta a fare le proprie scelte : Rainaldo Orsini ( 1347-1390 ) andò in favore dell’antipapa Clemente VII ed il conte Pietro II di Celano invece, scelse il legittimo pontefice. Il figlio primogenito di quest’ultimo, Ruggero III, fu nominato da Urbano VI, nel 1389, rettore delle province della Marca Anconetana con la facoltà di revocare prelati, persone ecclesiastiche e nobili, ad parlamenta convocandi, di detta provincia (4).
Il sunnominato conte di Celano, Pietro II, come segno indelebile della sua crescente importanza diede forte impulso, nel 1392, alla costruzione del castello di Celano già iniziato nel 1352 dal padre conte Ruggero II della potentissima famiglia dei Berardi . Tale importante e strategica costruzione fu continuata nel successivo secolo prima dal conte Leonello (o Lionello) Acclozamorra ( o Acclocciamuro, o Accrocciamuro [ ? – 1451] ) e poi definitivamente compiuta da Antonio Todeschini Piccolomini d’Aragona I Duca d’Amalfi ( 1435 -1493 ). Anche gli altri centri della contea di Celano furono muniti, come segno distintivo della loro acquisita potenza ed importanza, di torri e castelli. Nel 1356, infatti, fu edificato, per volere del soprannominato conte di Celano Ruggero II, la torre cilindrica ancora esistente in Aielli ( ora trasformata in osservatorio astronomico dal suggestivo nome “Torre delle stelle” ) recante la seguente epigrafe: I[N]/N[OMINE]/[DEI]/A[MEN]/A[NNO]/D[OMINI]/M/ CCC L/VI/ROGERIUS C[OMES] C[ELANI] F[IERI] F[ECIT]/HO[C]/OP[US] ( Nel Nome del Signore Amen Anno del Signore 1356 Ruggero conte di Celano fece fare quast’opera ) incorniciata da motivi floreali recante al centro, uno scudo sannitico con l’emblema dei Berardi rappresentato da una fascia obliqua (5). Così come pure, nel 1362, sempre per volontà dello stesso conte Ruggero II viene edificata la chiesa dedicata alla Santissima Trinità. Il 7 gennaio 1403, a ulteriore dimostrazione del relativo benessere raggiunto dalla classe dirigente di Aielli si inizia l’iter per costruire un ospedale infatti, come abbiamo detto sopra, dietro istanza del “venerabilis viri Loysii “ abate secolare della chiesa di S. Giovanni di Ozanello e rettore della chiesa di S. Maria di Vivizio, il vescovo dei Marsi Filippo acconsente acche sia costruito un ospedale per i poveri e concede l’indulgenza di 40 giorni sia per i penitenti sia per coloro che sovvenzionano la costruzione dell’ospedale e del suo sostentamento. Fra i sottoscrittori della concessione vescovile e collegiale di indulgenza vi è anche il Nostro Gentile :
“[…]Nos Gentilis episcopus Neucastrensis de consensu et [vo]luntate predicti reverendi patris domini Marsicani episcopi concedimus iuxta formam predictarum litterarum quatraginta dies de vera indulgentia […]”.
Precisa è l’analisi che l’attenta ricercatrice Maria Rita Berardi riporta nel suo fondamentale studio : “ Poteri centrali e poteri locali nella Marsica in età angioina “ (AA.VV. : “ La Terra dei Marsi cristianesimo, cultura, istituzioni a cura di Gennaro Luogo, Viella Libreria editrice, Roma, 2002, per i tipi della Tibrgraph s.r.l. di Città di Castello) :
“[…]Nell’ultimo ventennio del Trecento, sullo sfondo delle guerre per lo scisma e della crisi dinastica napoletana, la regione divenne di nuovo un territorio chiave negli scontri di potere fra corona, papa e poteri locali. Anche la diocesi marsicana fu coinvolta nello scontro. Nell’aprile del 1380 la situazione divenne difficile: il vescovo Pietro seguì l’antipapa Clemente VII e in sostituzione fu nominato Giacomo[…]Alla sua morte, nel luglio del 1384, papa Ubano VI, appoggiandosi al potere locale più forte ed incisivo della Marsica, nominò vescovo dei Marsi Gentile di Aielli, vassallo del conte di Celano: nei suoi quattordici anni di servizio nella diocesi, presubilmente, ridisegnò la geografia ecclesiastica dividendo quest’ultima in tre vicarie[…]non va sottovalutato il fatto che il Vescovo, Gentile esperto sia in diritto canonico sia in quello civile, fosse vassallo del conte di Celano, e pertanto buon conoscitore della realtà marsicana: secondo l’ipotesi sopra formulata, sarebbe sato colui che riprendendo il controllo delle finanze con la definizione delle decime avrebbe messo mano alla ristrutturazione della diocesi dividendo quest’ultima in tre vicarie. Nello stesso periodo, in cui fu probabilmente redatto il Quaternus relativo alla diocesi [ante 1397], anche il conte Roggero di Celano, che, per rafforzare il suo dominio, aveva acquistato alcuni paesi della baronia di Pescina, tolti a Francesco Del Balzo, nemico di Giovanna I, fece redigere nel 1387 un Quaternus inventarii contenente tutti i suoi beni stabili siti nel contado di Celano e in altri luoghi extra comitatum, nel quale erano descritti i diritti, le collette, i redditi, le prestazioni e ius patronatus ecclesiarum[…](6) Affidando ad un vassallo del conte di Celano, Gentile d’Aielli l’amministrazione della chiesa marsicana in spiritualibus et temporalibus, Urbano VI aveva tentato di controllare la Marsica. Ritengo che questa politica di controllo della geografia religiosa e politica della Marsica abbia favorito la riorganizzazione giuridica e amministrativa della diocesi, come testimonierebbe il Quaternus […]” (7).
Non c’è che dire una perfetta sinergia fra potere comitale e potere ecclesiastico come, d’altronde, era in uso nell’Italia d’allora.
L’ipotesi della Berardi è molto convincente infatti vediamo, per esempio, essendo il Nostro Gentile originario di Aielli, porre la sua residenza vescovile in Aielli da dove “ in Camera nostra ” diramava i suoi ordini come chiaramente si evince nei due sopraccitati documenti membranacei relativi uno, ad una enfiteusi perpetua recante la data del 15 luglio 1397 e l’altro, relativo ad una ratifica di vendita recante la data del 25 agosto 1397.
Questi, pose, nel territorio del paese natìo una pieve: l’importante pieve di Santa Cristina in Alafrano ( territorio ubicato nei pressi del paese di Aielli Stazione ) sotto la cui giurisdizione ecclesiastica ricadevano ben 10 chiese ubicate negli attuali territori comunali di Cerchio ed Aielli (8) segno tangibile dell’importanza raggiunta dall’Universitas di Aielli in quel lasso di tempo ciò, naturalmente, è il frutto non solo del vescovo Gentile ma anche dell’intera classe dirigente aiellese che fu partecipe di questi grandi cambiamenti che proiettarono l’umile centro marsicano ad essere attore di quegli sconvolgimenti socio-politici che caratterizzarono fortemente la Marsica tra la fine del XIV secolo ed inizio del nuovo secolo.
In quest’ottica sicuramente bisogna intendere anche l’elezione dell’altro vescovo di Aielli Mons. Pietro Janetella avvenuta il 13 Agosto 1427 quando si trovava a Roma in qualità di priore del Monastero celestiniano di Sant’Eusebio: “[…] res. Antonn Petrus de Agello, prior eccl.[esie] S Eusebii de Urbe 1427 Oct[ober] 13 […]” (9). Fu creato vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi ( dove rimase per vent’anni fino al 27 Novembre 1447 quando rinunciò, non sappiamo i motivi, a tale incarico : “[…]ren.[unciatio] Petri Pogalus (Possulus Ursoni) ca[nonicus] Surrentin[i] 1447 Nov.[ember] 27 […]”) (10) da papa Martino V ( al secolo Ottone o Oddone Colonna, eletto al soglio pontificio l’11 novembre 1417 e deceduto il 20 Febbraio 1431 ) il pontefice che costrinse l’ultima erede della contea di Celano Covella (o Jacovella) ad unirsi in matrimonio con il nipote Odoardo Colonna per rinsaldare ancora maggiormente l’intesa fra lo stato pontificio e la limitrofa contea di Celano. Il 29 Aprile 1425 i sindaci di Aielli e di Cerchio giurarono fedeltà, tramite un proprio funzionario delegato, ai soprannominati Odoardo Colonna e Jacovella di Celano da come chiaramente si evince dal documento [citato la prima volta dallo storico Pietro Antonio Corsignani (1686-1751) nella sua “ Reggia Marsicana” edita a Napoli nel 1738 (11)], conservato nell’archivio del monastero di Subiaco (12) segnalatomi dall’amico editore Antonio Socciarelli che ne ha fatto la seguente veloce trascrizione: “
“ In Dei nomine, amen. Anno Domini millesimo qradragentesimo vigesimo quinto, die penultimo mensis aprilis, tertie indictionis. Apud Agellum, in platea publica ante ecclesiam Sancte Trinitatis dicta Agelli, Regnante serenissima domina nostra, domina Iohanna secunda, Dei gratia inclita Hungarie, Ierusalem et Siciliae, Dalmatie, Croatie, Rame, Serve, Galitie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerija ac Pedemontis comitissima, rengrorum vero eiusdem anno undecimo feliciter, amen. Nos Antonius Surgentis dictus Casaronus (13) de Circulo de districtu er per (…)annalis ratus acin licterarus iudex ad contractus predicte terre Agelli et pertinentiarum esiusdem, Nicolaus Macthei Baroni de Capistrano regia auctoritate puplicus in toto regni Sicilie notarius et testes subscripti licterati ad hec vocati specialiter et rogati, ideo que dompnus Lisu(…) abbas ecclesie Sancti Iohannes de Ozanello, dompnus Berardus Pauli Pucciacchi, dompnus Nicolaus Iohanni Iacobus[.] Philippi Vurici(…) Antonius Berardi Iohannus de Agello presenti scripto puplico de claram notum facimus et testamur quod in nostrum qui supra iudicem, notarium et testes presentia costituti Carnassale Cole Andreae,Paulus Rubey de Agello, et Petrocchus et Rossalia de Circulo massarii quorum Agelli et Circuli ad requisitionem Amici Iohanni Petri bauli Agelli et Antonio Galli baiuli Circuli, et Antonius Petruczoli, Iacobus Pistacchy, Maninus, Iacobus Berardi, Iohanni Pasqualis Berardi, Iacobus Miocza, Petraccha, Cola Rubey, Antonius Agelini Gizii, Cola Pinti, Angelonus Lect[i], Berardus Masi Iannettelle (14), Petracchia, Cecatus et Iacobus Petri Cicci de Agello, Antonutius Mario Rubei, Petrus Cicci, Iohannes Sta(…), La zanda, Cola Iohanni Ruffoli, Antonutius Tuccery (15), Piscis, Colecta Butii (16), Iohannes Petri Melioris (17), Mactheus Gualtieri, Gerardinus, Paulus Cola (Berardoni) et Colecta Martelli (18) de Circulo nec non maior et saniorum pars predictarum Universitatuum Agelli et Circuli et nomine Universitatum predictarum. Item unum more solito congregati ad honorem et fidelitatem sacre regionali maiestatis honorem, laudem, statum fidelitatem et reverentiam excellentium dominorum, domini Adohardi de Columpna, et domine Cobelle de Celano Comitis et comitissime Celani eorumque heredum et successoribus, ac de mandato et licentia nobilis viri Hectoris del Maczacolle de Interamne, vicarii generalis comitatus Celani, in loco predictu ubi (partalibus) congregari solebant sponte et volontarie eorum nemine discrepante (per scriptos) eorumque heredum et successoribus in perpetuum fixi de fide prudentia et legalitate providorum Petri Angeli Amici de Agello et Mey Cappuccipti (19) de Circulo (***) in solitum et in contrarie ibi[d]em presente set honus infrascripti s(…)tis sindacati in se sponte suscipientis eorum sindicos vera procuratores, factores, negotiorum gestores et si quo alio nomine (…)et de iure acapitus dici et conseri (potere et debere) et certos nuptios speciales fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordinaverunt, ad (*) et se ipsos nomine quo supra presentandum si expedierit coram summo pontefice ed in Christopatre et domino nostro, domino papa Martino seu eandem (*) commissario nec non coram mangnificus et(*) dominis, domino Adohardo de Columpna et domina Cobella de Celano comitis et comitissima Celani seu eorum commissariis in hoc specialiter deputatis seu forte aliquo alio comissario (pro) reginalem magestatem et hoc etiam specialiter deputato ad presentandum debite fidelitatis (saccam???) et homagii lilium in manibyus prefati regionali comissarii(…) et per parte prefat(…) domine nostre regine et successive ad prestandum debite fidelitatis (sacramento) et homagii lilium in minibus prefatorum dominorum domini Adohardi de Columpna et domine Cobelle de Celano comitis et comitisse Celani seu alterius here(…) et Success(…vedi sopra) debita membrorum captiomne corporum suorum terreno honore, sollempniter permictendo(:::) consilium quod dicti domini comes et comitissima suique” (20)
In questo periodo di grandi fermenti non solo socio-politici ma anche urbanistici assistiamo al potenziamento dell’assetto urbano dei vicini centri di Aielli, Cerchio e Collarmele che raggiunse il suo acme nella prima metà del ‘400 proprio quando il re di Napoli Alfonso d’Aragona, detto il Magnanimo, il 2 Agosto 1447 istituì la “ Dogana menae pecundum Apulie “, l’importante rete dei tratturi che dall’Abruzzo conducevano alla Capitanata stabilendone anche i principali : L’Aquila-Foggia; Celano-Foggia e Pescasseroli-Candela rafforzando, così facendo, l’antica transumanza e di conseguenza anche l’agguerrito ceto dei proprietari di armenti. Infatti nelle importanti e notissime fiere di Lanciano del mese di maggio del 1447; dei mesi di maggio ed agosto del 1453; dei mesi di maggio ed agosto del 1454; dei mesi di maggio ed agosto del 1456 e del mese di maggio del 1470 sono presenti vari mercanti della nostra subregione marsicana fra i quali vi furono anche uno di Cerchio ed uno di Collarmele (21). Così come altri mercanti marsicani sono presenti nelle fiere di Albe del 1454; in quelle di Castel di Sangro del 1453, 1454, 1456, 1457, 1469 e 1470; in quelle di Celano del 1453 e 1454, in quella di Pescina del 1454 ed in quella di Tagliacozzo del 1453 (22). Il 31 Marzo 1473 erano presenti nelle dogane di alcune Università molte migliaia di animali appartenenti a proprietari dei vari paesi marsicani: Cerchio era presente con 14.000 pecore, Aielli con 6.000 e, Collarmele anche con 6.000 pecore (23). Segno eloquente di un relativo benessere raggiunto dalla classe dirigente locale. Nella seconda metà del Quattrocento, infatti doveva esistere a Cerchio un’agguerrita classe di mercanti rappresentata anche da “ Angelo Ciofano de Circhio mercante d’olio “ che viveva a Sulmona. E’ questi il padre di Antonio (vivente nel 1492) e nonno di Giovanni (1490-1581) genitore dell’ultimo grande umanista Hercole Ciofano ( 1545-1591) (24). Anche nei secoli successivi la classe mercantile marsicana è ben rappresentata infatti, nelle tabelle riassuntive poste nell’ottimo lavoro di Luigi Piccioni dal titolo: “ Marsica vicereale Territorio, economia e società tra Cinque e Settecento “ apprendiamo il numero dei capi ovini dei locati marsicani registrati nella dogana di Foggia in quegli anni (25).
Alfonso il Magnanimo fece elaborare nel 1443, la prima rilevazione fiscale dei fuochi e da questo preziosissimo documento pubblicato dal valente storico Fausto Cozzetto dal titolo : “ Mezzogiorno e demografia nel XV secolo “ (26) apprendiamo anche la numerazione di Cerchio ( il nostro centro è riportato in modo erroneo come “Cerrulum” da leggersi senz’altro “Cerculum” o “Circulum” ), di Aielli e di Collarmele :
“[…] Comes Celani[…] Agellum Foc. LXXXIIII est foc. LXXXXII duc 1 […] Cerrulum foc. LXXIII est foc. LXXVII (sic)/Collis Armella foc. LXXII est foc. LXXI duc. 21 (…)”,
la seconda numerazione si riferisce al 1443 e la prima al 1447 quindi se moltiplichiamo il numero dei fuochi per 5 convenzionalmente usato per determinare la consistenza di ogni nucleo familiare abbiamo per Cerchio 385 abitanti nel 1443 e 365 abitanti per il 1447; per Aielli abbiamo 460 abitanti per il 1443 e 420 per il 1447 e per Collarmele abbiamo 355 abitanti per il 1443 e 360 per il 1447.
E’ questo il secolo in cui vissero il grande pittore marsicano Andrea De Litio nato in Lecce nei Marsi (1420-1481?), vanto non solo della nostra sub-regione marsicana e dell’Abruzzo bensì dell’intero mondo delle belle Arti ed i poeti Giovanni da Tagliacozzo (fine ‘300-1467), Paolo Marso da Pescina ( 1440 – 1484 ) e Antonio Marso detto l’Epicuro Napoletano ( 1472-1555).
Il 12 Febbraio 1463, il paese di Cerchio così come Aielli e Collarmele, insieme agli altri centri della grande contea di Celano, apparteneva ad Antonio Todeschini Piccolomini d’Aragona I Duca d’Amalfi (1435-1493) (27), nipote di papa Pio II ( al secolo Enea Silvio Piccolomini [1405-1493] ) e fratello del cardinale Francesco Nanni Todeschini Piccolomini (1439-1503), quest’ultimo eletto al soglio pontificio con il nome di Pio III , il 22 Settembre 1503 e morì il 18 Ottobre dello stesso anno, dopo appena ventisei giorni di pontificato. (28) Undici anni dopo, il 20 Febbraio 1484 furono nuovamente confermati ad Antonio Piccolomini i vasti possedimenti della contea di Celano. Nello stesso anno, tre procuratori della chiesa matrice di Cerchio Santa Maria dell’Annunziata volgarmente detta “dentro” oppure “daventro” o “dendro le mura”, commissionarono ad un valente artista di Sulmona ( inequivocabile il marchio del punzone recante la sigla cittadina “SUL”) la grande croce d’argento sbalzato che ancora oggi si conserva a Cerchio. I committenti a ricordo di tale evento fecero apporre nel verso una targhetta recante la seguente scrittura:
“ + ANNO D[OMINI] M[ILLESIM]O CCCCLXXXIIII/FO FACTA QUESTA CROCE/P[ER] LIMOSINA
D[OMIN]O ANTONO/D[I] COLA D[I] PETRI D[I] CIC/CO E COLA D[I] ANGELU/ D[I] ANTONO ZA[NNA] ET M/ACTEO D[I] ANTONU/D[I] MACTEO PROCU/RATURI D[I] S. MARIA D[I] CIRCHIU P[ ER] POPULU ”.
Chissà se i menzionati procuratori fecero realizzare la grande croce come speciale ex voto per essere stata l’intera popolazione (“P[E]R POPULU”) di Cerchio preservata dalla terribile pestilenza accaduta proprio quell’anno all’Aquila. A testimonianza di ciò sappiamo che, nel 1484, non furono eletti i mastri di fiera nel maggio, e la fiera non fu celebrata “acciocchè da’ forestieri non fosse introdotta peste nell’Aquila” (29). Al momento non sappiamo nulla circa una epidemia di peste avvenuta in quell’anno a Cerchio ( o nel comprensorio marsicano ) , se fosse accaduta forse, la croce, in futuro doveva essere usata come valido simbolo apotropaico per preservare gli abitanti dal pestifero morbo (30).
Sicuramente a questa data è ascrivibile anche la pisside d’argento ( misura mm. 90×85), da me scoperta il primo aprile 2013 nell’abitazione del parroco di Cerchio padre Emmanuel Essiet ( grazie ad una segnalazione di Dennis Paneccasio) e da lui attualmente in custodia, recante impresso il bollo del punzone sulmontino “SUL” e le seguenti due scritture una sul coperchio:
“ + EGO SUM PANIS VIVUS QUI DE CELO DESCENDIT “
e l’altra intorno alla pisside:
“ + SIQUIS MANDUCAVERIT EX HOC PANEM VIVET IN ETERNUM “ ( Giovanni cap. VI, 50,51 n.d.r. ).
Il 24 marzo1492 il vescovo dei Marsi, Gabriele Maccafani ( 1481-1511 ) concedeva altri 40 giorni di indulgenza a chi visitava la chiesa di S. Bartolomeo di Cerchio apponendo tale concessione in fondo alla famosa “ Bulla Indulgentiarum” inviata nel 1300 da 16 vescovi riuniti in Roma, nell’anno sesto del pontificato di papa Bonifacio VIII, alla chiesa si S. Bartolomeo ( ancora oggi esistente) sicuramente in occasione del primo Anno Santo (31):
“ Noi Gabriele Vescovo Marsicano e Diocesano per grazia di Dio e della Sede Apostolica apponiamo per quanto ci riguarda quaranta giorni di indulgenza[…] e apponiamo il nostro sigillo attuale. Dato in Cerchio in casa di Don Antonio di Cola di Pietro di Cicco (32) il giorno 24 Marzo 1492 nell’VIII anno del pontificato di Sua Santità Innocenzo VIII”. (33)
Non sappiamo quando Gentile di Aielli morì nè sappiamo dove fu tumulato né sappiamo a quale clan familiare appartenesse (34). Il canonico Andrea Di Pietro ( 1806-1874) afferma che il Nostro morì a Nicastro (vedi appendice ) senza però citare la data di morte, né il lugo dove fu sepolto. Molto probabilmente, secondo le notizie degne di nota, tratte dall’ottimo citato lavoro dello storico Francesco Russo : “ La Diocesi di Nicastro”, Gentile d’Aielli fu trasferito dal 1398 al 1418 da Marsico ( è da intendersi dalla Marsica n.d.a. ) a Nicastro e da questa data fu trasferito nella diocesi di Sessa Arunca e lì forse, il condizionale è d’obbligo, lo colse la morte (vedi pag. 3).
Nella citata cronotassi della Diocesi di Sessa Aurunca il Nostro figura come : Gentile Maccafani (?!) e resse tale diocesi dal 1417 fino al 1425 sottintendendo, forse, il redattore di tale cronotassi, la data di morte del Nostro. Al momento purtroppo non abbiamo altre notizie utili a tratteggiare la forte, interessante ed importante figura del vescovo Gentile se non quelle ricavate dal “Compendiolo della vita dei vescovi Maccafani” a cura di Massimo Basilici ( Museo Civico di Cerchio, Quaderno n. 105, Anno XIII, 2010) ( vedi nota 23 ) e le pagine 241 e 242, che qui integralmente si riportano, del più volte menzionato “La Diocesi di Nicastro”:
“[…] 31. – 1398-1418. Gentile.- Fu trasferito da Marsico (sic) a Nicastro,/alla morte di Giacomo. L’Ughelli ne assegna la data ai 14 ottobre/1398, con riferimento al libro delle Obligazioni di Bonifa-/cio IX. Ma il detto libro delle Obbligazioni accenna alla sua/promessa di versare il comune servizio, ma non alla sua promozione,/che precede il versamento del comune servizio. Egli si obbligò per-/sonalmente ancora una volta a versare i 300 fiorini il 13 gennaio/1399 per sé e per i suoi immediati predecessori./Egli prese parte al Concilio di Pisa del 1409./Ma lo scisma aveva creato una enorme confusione nella supre-/ma direzione della Chiesa. Il Concilio di Pisa, riunito per mettere/fine allo Scisma, aumentò il disorientamento dando un terzo Papa,/che venne ad aggiungersi ai due competitori. La situazione al ver-/tice si riflette nelle diocesi, dove i vescovi delle diverse obbedienze/lottavano tra di loro per il possesso della chiesa./Il Concilio di Pisa fu dichiarato illegittimo da Gregorio XII;/per questo rimosse dalle proprie sedi i vescovi che vi avevano parte-/cipato. Anche Gentile fu destituito da vescovo di Nicastro e, al suo/posto fu nominato Angelo di Benevento, il quale, nel giorno stesso/della sua nomina, 9 maggio 1409, versò personalmente al Papa 800/fiorini, 300 per sé e 500 per i suoi immediati predecessori, Gentile,/Roberto, Giacomo, Angelo e Manfredi./Forse nemmeno Angelo di Benevento riuscì a prendere pos-/sesso della diocesi, sia per le difficoltà dei tempi sia per i pochi/mesi, che sopravvisse alla sua promozione. Difatti nei primi mesi/del 1410 egli fu sostituito da Paolo, il quale il 9 marzo di quell’anno/a Gaeta, si obbligò personalmente a Gregorio XII per i 300 fiorini/del servizio comune. Ma neppure egli riuscì a prendere pos-/sesso della Chiesa, poiché dopo più di un anno e mezzo, era ancora/semplicemente “eletto”, come si rileva dal Registro Camerale, dove/al 16 novembre si legge : “ Paulus, electus Neocastren, loco pecuniae/pro communi servitio promisit se adductum ed delaturum suis/expensis ad civitatem Gaetam usque ad festum Resurrectionis Do-/mini proxime futurae, tombulos 400 grani boni, 60 ordei et 40 fa-/barum, qui sibi in parti bus Calabriae consignari, debent per Bartho-/lomeum, archiepiscopum Rassanen”./Sembra tuttavia che Paolo non potè mai accostarsi a Nicastro,/dove Gentile si sentiva abbastanza forte per respingrerlo. Questi nel/1415 partecipò al Concilio di Costanza, dove l’8 ottobre di quell’an-/no firmò, come teste, il testamento del Card. Landolfo. Il suo nome/ricorre anche nei Registri vaticani del 1416 e del 1417./La rinunzia di Gregorio XII e di Giovanni XXIII nel 1415, se-/guita dall’elezione di Martino V l’11 novembre 1417, segna la fine/dello Scisma./Il nuovo papa dovette incominciare col risanare l’anormale si-/tuazione delle diocesi, turbata dalle contese dei vescovi delle diverse/obbedienze. Nicastro era contesa da Gentile e da Paolo. Il Papa,/uomo di concretezza, anziché perdersi in dispute inutili sulla legit-/timità dell’uno o dell’altro, rimediò, trasferendo Gentile a Sessa e la-/sciando Paolo a Nicastro[…]”.
Da come chiaramente si evince il Nostro partecipò come vescovo e come dottore in “utroque iure”, essendo lui un grande esperto nel campo giuridico, nei sopramenzionati concili tenutisi a Pisa, dal 24 Marzo al 7 Agosto 1409:
“[…]126. R.[everendus] P.[ater] D.[ominus] Gentilis episcopus Neocastrensis[…]126-M 339,V141.C.990. Gentilis d’Ajello evéque de Marsi (Italie, prov. L’Aquila);(Eubel p. 328)[…]” (35)
e nella città tedesca di Costanza, dal 5 Novembre 1414 al 22 Aprile 1418, in difesa della Chiesa.
Partecipò, al concilio di Pisa, anche il vescovo dei Marsi Giuliano Tommasi:
“[…]1929- R[everendus].P.[ater] D.[ominus] Julianus episcopus Marsicanus […]129- M 353, V 198,C. 100v, Julianus Tomasi, eveque del Marsi (Italie, prov. L’Aquila), (Eubel, p. 328)[…]” (36)
Durante il concilio di Costanza tra le altre cose furono dichiarate eretiche le idee di John Wiclif ( 1324 – 31.12.1384) e di Jan Hus ( 1371- 1415 ) entrambi condannati, il 6 Luglio 1415, al rogo: per eseguire tale sentenza fu ordinata, addirittura, la riesumazione del corpo di John Wiclif facendo cremare, dopo 41 anni dalla sua morte, i resti mortali e, quasi un anno dopo, per gli stessi motivi, il 30 Maggio1416, fu condannato al rogo Girolamo da Praga ( 1370- 1416 ).
In questo stesso concilio: l’11 novembre 1417 fu eletto al soglio pontificio il Cardinale romano Oddo Colonna che, in onore del santo del giorno della sua elezione, scelse il nome di Martino V.
Sarebbe interessante sapere e conoscere il pensiero del Nostro Gentile durante lo svolgimento dei sopramenzionati concili e sapere pure se il suo animo rimase scosso da tali singolari ed esemplari condanne e, di conseguenza, conoscere, se vi furono, quali interventi fece il Nostro.
Non sappiamo infine perché i maggiori storici marsicani, Muzio Febonio ( 1596-1663), Pietrantonio Corsignani ( 1686-1751 ) e Andrea Di Pietro ( 1806 – 1874), che pure avevano letto ed avevano avuto a disposizione non solo i documenti sopracitati da Maria Rita Berardi, riportano in modo erroneo, nelle loro maggiori opere, la data del 1385 anziché quella del 1384 come anno di elezione a vescovo del Nostro Gentile. Addirittura lo storico Federico Ughelli nella sua monumentale “ ITALIA SACRA “ (37) riporta : “[…] GENTILIS Marsorum Eposcopus 1387 c. ad/Ecclesiam Neocastrensem fuit translatus 1398 2./Idus Novembris[…]” ( al margine destro riporta : “ c 1385 Ex/Phoebonio “ ).
Muzio Febonio (38) nella sua opera postuma “ Historia Marsorum ecc.“ descriveva e metteva in evidenza sia l’amenità dei luoghi dei limitrofi paesi di Aielli e Cerchio sia la notorietà dei suoi illustri figli:
“[…] sulla cima di un colle ci si presenta Aielli/centro piccolo, ma noto per la fama di personaggi illustri che generò. Vi nac-/quero, infatti, Gentile. Vescovo dei Marsi, ed il Signor Pietro Iannetella, Ve-/scovo di S. Angelo dei Lombardi, che fu uno di quei vescovi che conferirono/ad Amico Agnifili, cardinale di Santa Romana Chiesa, preconizzato come/vescovo dell’Aquila, nella sua sede propria, la dignità episcopale. Degnissi-/mo prelato, cui si accompagnano altri due che raggiunsero la suprema carica/ nell’Ordine dei celestini, pari a lui, se non per dignità, almeno per fama. Il/primo di questi è il Signor Pietro di Aielli, nipote, per parte di madre, di un/altro Pietro: Capocitti. Ma egli fu nobilitato più dal suo proprio valore che/dai meriti di questo zio. Ai monaci francesi, infatti che lamentavano che i/monaci cacciati dall’abate generale francese venissero accolti dall’abate ro-/mano e, per questo motivo, chiedevano alla Santa Sede che la loro provincia/non obbedisse ad abate italiano, egli si oppose in modo tale, con ogni sua/energia, da ottenere dal Sacro Supremo Senato dei porporati questa delibe-/razione: gli Italiani e Francesi ubbidissero ugualmente all’abate italiano e/ne eseguissero gli ordini. In seguito amministrò l’una e l’altra provincia e,/carico di anni, dopo aver espletato il suo mandato di Generale dell’Ordine,/passò a miglior vita ed ebbe sepoltura nella Chiesa di Santa Maria di Coll-/maggio, all’Aquila, dove era spirato il 13 novembre 1606./L’altro non secondo al primo per bontà di costumi, per esemplare discipli-/na e dinamicità di azione, è Francesco di Aielli, della famiglia Macerola, la/più eminente del posto. Egli, dopo che nell’anno 1614 aveva esercitato l’uffi-/cio pastorale con tanta energia e diligenza che le doti dell’animo suo erano or-/mai ben conosciuto e da tutto l’Ordine, nel 1636, a Roma, con favorevole una-/nime consenso di tutti i Padri, meritò di essere chiamato a far parte del Con-/siglio Generale dell’Ordine e depose, in pari tempo, la carica e la vita.[…]/Procedendo di altre due miglia, quando il colle degrada in pianura,/si incontra Cerchio, anch’esso non grande centro, i cui abitanti/per rendersi di antica origine, si vantano di avere una favolosa discendenza/da Circe, mentre sono derivati dalle rovine di Cerfennia o da quelle di/Valeria[…]/ Non poco decoro conferiscono a questo centro due personaggi che porta-/no entrambi, il nome di Pietro Capoccitti, pervenuti alla suprema carica di/Generale dei Celestini.[…] ”
A differenza del sopramenzionato Francesco di Aielli ( il quale effettivamente fu tumulato, come lo è tuttora, nella menzionata chiesa di Santa Maria di Collemaggio, il suo sacello infatti, si trova a pari del pavimento chiuso con una lastra di pietra recante un’epigrafe elogiativa, posto a sinistra di chi entra, prima dell’altare maggiore [vedi in seguito]) non siamo riusciti, al momento, a rinvenire, invece, la tomba di Pietro di Aielli; dobbiamo arguire, quindi, che la sua tomba si trovi nel cimitero dei frati. La data di morte, 1640, del menzionato Francesco Macerola (o Maceroni), si evince dal volume “ ESSEQUIE FUNERALI. Fatte nella Regia Chiesa di Collemaggio In morte del Reverendissimo Padre DON FRANCESCO D’AIELLI. Vicario Generale de Celestini, e Co-Abbate nel detto Monasterio, Nel dì 17. d’Aprile 1640. Nell’Aquila, Per Francesco Marino, 1640 Con licenza de’ Superiori” e non come affermò Muzio Febonio ( 1597-1663) o forse è meglio dire i curatori della sua “ Historia Marsorum “, nel 1636.
Anche dell’altro vescovo aiellese Mons. Pietro Janitella non sappiamo né quando nacque né quando morì né dove fu tumulato.
Le notizie più antiche in nostro possesso che parlano di lui sono quelle tratte dalla sopramenzionata lodevolissima opera di Ludovico Zanotti .
Il 7 Aprile 1422 “ Petrus de Agello “ è priore del Monastero di Collemaggio (vedi appendice) e, il 12 Luglio 1424 “fr’ Petrus de Agello “ è Priore di Sant’Eusebio “de Urbe” (Roma), ed Amministratore Apostolico del Monastero di Montecassino per volontà di papa Martino V ( Ottone [o Oddone] Colonna- 1417-1431 ) deputato “speciali(ite)r .“ Il 6 Gennaio 1426 dall’abate di Monteccasino è nominato commendatario della prepositura di Santa Maria di Luco dei Marsi che, con apposito mandato apostolico, governò e agì bene e poi, finalmente, fu eletto vescovo di Sant’Angelo ( dei Lombardi ):
“[…] F.ri Mag.[ist]ri Petro de Agellis Priori S[anc]ti Euseby de Urbe, q[ua]le Mand[ata]rius Cassinense de Mand:[a]to Ap[osto]lico gubernavit, et bene se gessit. Vid Stim[atio]nis postea fuit Ep[iscop]us S.[anc]ti Angeli “
ed il 15 Gennaio sempre dello stesso anno 1426 il Nostro prende possesso corporale della chiesa di Santa Maria di Luco (dei Marsi) :
“[…] 1426. 15. January Corporalis possessio Ecc.[lesi]a S.[anct]a Marie de Luco capta p[er] Proc[uratio]nes F.[atri] Mag[ist]ri/Petri de Agello, cui p[er] D. Abbate[s] Cassinen[sis] collata fuerat[…]”( vedi appendice).
Lo storico Mons. Pietro Antonio Corsignani nella sua “Reggia Marsicana ” oltre a citare ‘en passant’ la sua figura ci informa quando descrive la chiesa matrice di Aielli che :
“[…] E quivi anche vedemmo attaccato un’antico cap-/pello verde Prelatizio in memoria di Monsignore/Giannetelli dell’istessa terra nativo, il quale fu Ve-/scovo di Sant’Angelo de’ Lombardi.[…]”(39)
Sicuramente il giudice “ Masio Janitelle de Agello” che compare nell’atto della “ Corporalis possessio Prepositura Ecc[lesi]a S[anc]te Maria de Luco capta p[er] Proc[urato]res Mag[ist]ri/Petri de Agello, cui p[er] D. Abb[at]es Cassine[si]s collata fuerat […]” redatta il 15 Gennaio 1426, doveva essere sicuramente un congiuno (fratello ?) di Mons. Janitella (40) (non sappiamo se avesse altri fratelli né sappiamo il nome del padre né quello della madre o di altri parenti ). La famiglia Janitella faceva parte a pieno titolo delle famiglie egemoni non soltanto di Aielli peccato che al momento non ci sovvengono altri documenti per meglio descrivere la figura del Nostro sia, cosa più ardua, la storia del suo clan familiare. Non sappiamo quando tale casato scomparve.
Nel “Liber Matrimoniorum “ ( 1567- 1705) conservato prima nell’Archivio Parrocchiale di Cerchio ed ora nell’Archivio della Diocesi dei Marsi in Avezzano apprendiamo che una certa “Alfo(n)zina de ian(n)itella de ayello “ , il 12 Agosto 1571, convola a giuste nozze con Andrea della ciotta : “
[…]Adi 12 de Agosto 1571
Andrea della ciotta de circhio piglio p[er] sua leg.[iti]ma moglier[a]
Alfo[n]zina de ian[n]itella de ayello co[n] le debitj sollen[n]ita precedentj
Seco[n]do ordina il Sacro co[n]cilio tridentino in casa d[e] d[et]to andrea
p[rese]ntj li Sotto Scritti testimonij
Bartolome de capello
Santo de carosono de circhio
Mario de m[es]s[ere][…]”.
Il più volte menzionato Pietro Antonio Corsignani, parlando di Aielli ci porta alla conoscenza che :
“[…] Una delle sue Porte si dice Jannatella, dalla/vicina casa del soprallodato Monsignore Jannitelli […]” (41).
Alcuni anni fa, nel 2003, in occasione del 50° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Aielli partì, da parte di questi, una lodevole iniziativa, in collaborazione con il comune di Aielli, di una raccolta fondi per la ricostruzione dell’antica “porta Jannetella” attraverso la vendita di 8 cartoline riproducenti le bellezze artistiche del territorio del citato comune. (42) Tale scopo è stato realizzato: porta Janitella è stata ricostruita. Sarebbe bello individuare se non il palazzo del Nostro almeno il sito dove era fabbricato.
Il 29 Aprile 1425, i massari di Cerchio, come abbiamo detto sopra, unitamente con quelli di Aielli giurarono fedeltà al rappresentate del conte della contea dei Marsi Odoardo Colonna ( figlio di Lorenzo e Sveva Gaetani e nipote, come sopra riportato, di papa Martino V, primo marito di Covella [o Iacovella] della quale non sappiamo con precisione né la data di nascita né quella della sua morte, figlia ed erede del conte di Celano, Nicola [ o Cola] II, conte dal 1400 al 1418 ) e della contessa Covella:
“[…] Nell’Archivio de’ Colonnesi in Roma osserva/to abbiamo una carta di procura fatta ad un Cittadi/no Romano co i Sindaci di Cerchio per giurare Fe/deltà nell’A.(nno) 1425 a Odoardo Colonna […].” (43)
“[…] Nella divi-/sione dei beni fatta da Martino V con atto 1 febbraio/1427 toccarono a lui ( Odoardo n.d.r.) Alba e Celano, Civitella, Fragiano,/Monte della Guardia ed i diritti sopra Monterano. Fu/compreso negli anatemi fulminati da Eugenio IV (maggio/1431) contro i Colonnesi e gli fu tolta la contea di Ce-/lano che riebbe nel 1432 allorchè con atto 21 febbraio/Giovanna II glie ne riconfermava il possesso concedendo-/gli anche la città de’ Marsi col titolo e dignità di ducato./La concordia tra i Colonnesi ed Eugenio IV non durò/lungo tempo; Antonio ed Odoardo uniti al Fortebraccio/ai 25 agosto 1433 si avvicinarono a Roma occupando i/ponti Fomentano, Salario, Milvio; ricacciati a Genazzano/ da Giovanni Vitelleschi tornarono poco dopo a minac-/ciare Roma. Il papa non credendosi sicuro in Vaticano si/trasferì ai Ss. Apostoli sino che l’anno appresso, travestito da monaco cassinese, evase in Toscana. Nella con-/tesa tra il duca d’Angiò, e Ferdinando d’Aragona (1452)/Antonio e Odoardo Colonna sostennero le parti del/primo, gli Orsini dell’altro. Si combattè in Abruzzo ed i/Colonnesi perdettero varie terre, tra le quali sembra esservi/stata Celano. Pio II tornato in Roma nel 1460 favorì lo/Aragonese ed indusse i Colonnesi ed Orsini a pacificarsi/tra loro.Il trattato venne firmato ai 25 marzo 1461, vi/intervennero i ministri di re Ferdinando che promisero/far ricuperare ai Colonna Salerno e Celano, ma questa/promessa restò lettera morta. Salerno non fu restituita, e/nel 1463 Ferdinando I diede la contea di Celano ad An-/tonio Piccolomini nipote del pontefice che nel 1461 aveva/di già creato duca d’Amalfi e gran giustiziere del regno./Odoardo fu fondatore di una nuova linea: compreso/nell’infeudazione, fatta da Martino V al di lui fratello An-/tonio, di Paliano e Serrone tolto ai Conti, sposò, dopo il divorzio con la Covella, Filippa di Grato Conti. Nel 1463/fece testamento dal quale risulta che da questa seconda/moglie ebbe sei figli maschi e due femmine. Non si cono-/sce l’epoca di sua morte, ma certo avvenne circa il 1465 […] “(44)
Covella :
”[…]visse con Edoardo soltanto tre anni. Alla morte di papa Martino V, nel 1431, all’età di circa trenta anni fuggì di casa[…]Si tramanda che Edoardo pur essendo giovanissimo, fosse impotente ed affetto di gozzo, per cui mai Icobella riuscì a nutrire verso di lui l’affetto di sposa[…]Edoardo allo scopo di fugare l’ignominia di essere tacciato di impotenza sposò altra donna di nome Filippa Grato, dalla quale ebbe, infatti, più figli (sei n.d.r. )[…] “(45)
Covella contrasse altri due matrimoni con valentissimi uomini d’arme: nel 1439 con Giacomo Caldora ( 1369-1439 ): memorabile fu, nel 1424, la sua vittoria durante la battaglia dell’Aquila dove rimase ferito a morte il celebre capitano di ventura Braccio da Montone ( Andrea Fortebracci, 1368-1424 ) e furono presi prigionieri altri due celebri capitani quali Niccolò Piccinini ( 1380-1444) ed il Gattamelata ( Erasmo da Narni, 1370-1443 ) e l’altro matrimonio contratto, nel 1441, con Leonello Acclozamora ( o Accrocciamuro ) (46).
Si deve a quest’ultimo un forte e quasi definitivo impulso per la realizzazione del castello di Celano che sarà completato, nella seconda metà del XV secolo, da Antonio Todeschini Piccolomini nell’elegante e superba struttura rinascimentale che ancora oggi noi possiamo ammirare, attualmente sede del Museo della Marsica e sede di uffici distaccati delle Sovrintendenze B.A.P. e P.S.A.E.
In quegli anni sicuramente l’accorta classe dirigente di Cerchio, per meglio difendersi, fece costruire, sopra antichi resti , un castello, come riporta nella sua lodevole opera il medico, scrittore nonchè sindaco di Cerchio, Benedetto D’Amore (47) :
“ […] Secondo alcuni, giusta ci riferisce Febonio, Cer-/chio edificata venne dalle rovine dell’antica Cer-/fennia, o di Valeria, che dagli antichi storici/veniva appellata Marrubio, secondo altri che/fiorisse anche prima di questa Città, portando/tal nome da Circe Incantatrice per un tempio/quivi alla stessa eretto; secondo ci rapporta Monsignor Corsignani ( Reg.a Mars. V. 2.°)./Soggiunge il surriferito Febonio a lib. I.° stor./Mars.a esservi chi creda, che i Romani scelto/avessero quel sito, come un forte cerchio e ro-/tondo, onde starvi a diporto per godere i giuo-/chi navali di Claudio e la battaglia di Laco; e/di esservi anche opinione, che lo stesso Impe-/ratore Claudio lo avesse addetto ai giuochi Cir-/cesi, costruendovi all’oggetto il Circo. Quest’ul-/tima congettura è la più plausibile, si perché/era costume dei Romani clelebrare questi giuochi/ovunque si trovavano[…], si perché nel fatto/l’additano gli avanzi di forti e largi(sic) muri che/circolarmente al detto Colle girano nella parte/così detta dietro i Fossi, a’ quali corrispondono/le mura esteriori delle abitazioni antichissime, dei Ciofani, dell’antica Chiesa Matrice/sotto il titolo dell’Annunziata, dell’Orto Ci-/mini ecc., e vi è tradizione che dentro il cre-/duto Circo esisteva una Torre, per la quale ivi/è rimasto il nome di Castello, confirmato dal-/l’esistenza, a piè di detto Colle di due porte/antiche, in punti opposti, dell’ordine gotico, e/forse costruite nell’invasione di questi Barbari./in una di esse, e precisamente in quella che/ora resta quasi nel mezzo del paese, si scorge, superiormente aggiunta, una lapide coll’emblema/della famiglia Colonna, (48) signore una volta della/Contea di Celano, al quale feudo questo paese sot-/toposto è stato fino alla legge eversiva del 1806[…]”(49)
Nella relazione fededegna del Regio Tavolario Donato Gallarano, riguardante la Contea di Celano e la Baronia di Pescina, compilata dal 1718 al 1722 apprendiamo per il nostro centro :
“[…] In detta Terra non vi è casa Baronale n’è circondata di mura, ma bene in detta Terra, quanto fuori vi sono chiese, et anco un monastero […]” .
Nella settecentesca carta topografica acquerellata a colori della “ Pianta è Veduta dello Stato di Celano ne Marsi/ Adi 3 Febraro 1720 “, conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana ( Archivio Barberini, Indice II,1944 a ), inequivocabilmente si nota invece, nella rappresentazione grafica del paese di Cerchio un antico castello: un muro formato da blocchi rettangolari sicuramente di pietra con ai lati due torri rotonde e a sinistra vi è un muro informe alto quasi quanto le torri recanti due porte di accesso al paese (50). Vicino al campanile, dobbiamo congetturare della chiesa matrice di Cerchio Santa Maria dell’Annuziata volgarmente detta “dentro le mura” (quindi le mura esistevano), è rappresentata un’alta torre quadrata.
Come mai due tesi a prima vista così discordanti? Eppure tutti e due i documenti presi in esame sono coevi : la relazione Gallarano è stata redatta dall’anno 1718 al 30 Settembre 1723 e la pianta topografica, come abbiamo soprariportato reca la data del 7 Febbraio 1720 quindi sembra che, o il Gallarano o l’anonimo agrimensore abbiano, con la loro opera asserito il falso oppure, in ultima analisi, e forse è quella giusta, tutti e due hanno detto la verità. Il Gallarano per stilare la citata relazione impiegò ben 5 anni e quindi era impossibile che sfuggisse ai suoi attenti occhi un castello o una rocca ben munita in quanto per “comando” doveva andare “super facies loci” e doveva “apprezzare” cioè doveva dare l’equivalente valore in denaro; l’anonimo agrimensore, forse locale, ( chissà se fu il Nostro Luca Ciotti molto attivo nella sua professione agrimensoria nella prima metà del XVIII secolo ) invece ha messo in risalto i resti di quello che dovette essere in antico un castello A ben vedere, infatti, quello che a prima vista sembra essere un castello sono in realtà, molto probabilmente, antiche mura di difesa munite di due torri: quindi tutti e due i documenti sopraccitati sono fedegni. L’agrimensore che ha curato la mappa doveva conoscere molto bene il nostro centro infatti ha riportato le 3 strade principali d’accesso al paese, ha raffigurato il Monastero degli Agostiniani Scalzi di Cerchio e più sotto, quasi davanti al convento, ha dipinto una grande croce : in questo luogo esiste, ancora oggi, una strada denominata Largo della Croce ( così chiamata, sicuramente, a ricordo di quella antica croce posta proprio all’entrata del paese e davanti al menzionato Convento degli Agostiniani Scalzi ). Chissà se l’anonimo agrimensore, nativo del luogo, ha voluto trasportare le conoscenze della storia patria del suo paese natìo nella mappa in questione. Altrimenti perchè rappresentare due torri e quel pezzo di muro, la croce posta prima del convento degli Agostiniani Scalzi di Santa Maria delle Grazie di Cerchio, tutte e tre le strade principali di Cerchio ed infine sembra a bella posta ha collocato il centro urbano di Cerchio quasi al centro della mappa? Per dipanare tale quesito bisognerebbe fare un esame grafico minuzioso: occorrerebbe una perizia calligrafica per stabilire se l’anonimo agrimensore è il nostro Luca Ciotti.
Donato Gallarano fu inviato “ super facies loci”, come perito “ super partes”, per apprezzare la Contea di Celano e la Baronia di Pescina agli inizi del secolo XVIII (1718-1723) per dipanare le liti ereditarie fra le potentissime famiglie Cesarini, Savelli, Peretti, Sforza Cabrera Bovadilla, ecc. Il suo encomiabile lavoro durato 5 anni, e lodevolmente riportato nella sua “relazione” composta da ben 300 carte ( inedita, tranne i “pezzi” riguardanti Cerchio e Celano che furono pubblicati alla fine del XIX secolo: il primo, dall’avvocato nonché senatore del Regno Gennaro Manna nel 1894 (51) ed il secondo dallo storico Pietro Piccirilli nel 1899 (52) ) andò completamente distrutto nel 1943. L’unica copia originale esistente nel Grande Archivio di Napoli, in seguito al bombardamento areo da parte degli Alleati, andò perduta, come abbiamno detto su nel 1943, insieme a moltissimi documenti: si salvò, solamente, la relazione finale del Gallarano ( composta da n. 20 pagine che io ho pubblicato, nel 1992, sul Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria col titolo : “ Una Relazione tecnica nella Marsica del ‘700 “ ). Noi, grazie ai sopramenzionati “pezzi” di Cerchio e Celano siamo riusciti a capire la grande importanza demo-etno-antropologica della “Relazione” e la distruzione del manoscritto aveva, ancora una volta privata la nostra Marsica di documenti molto preziosi ed importanti per tracciarne più compiutamente la sua storia. Finalmente, quasi a ciel sereno, si è aperto uno spiraglio circa il recupero di tale importantissime notizie: un collezionista possiede una copia ottocentesca della più volte menzionata relazione. Ho potuto vedere fotocopiata, in parte, il menzionato documento, dove, nella prima pagina, appare la seguente scrittura :
“ 26 Giug.o 1847 c as.a fol. 3 Tedeschi/Relazioni ed apprezzi dello stato di Celano colle sue…./otto Terre/”.
Il citato Tedeschi è forse il notaio celanese Francesco Tedeschi allistato nella vendita carbonara del comune di Celano: “[…]218. Tedeschi Francesco. Notajo – 2° Assistente Antico per sentimento[…]” ( Amiconi F.:” La Carboneria a Cerchio e nei Distretti di calano e Pescina”, Ed. Kirke, Cerchio, 2012, p. 60 ).
La Relazione Gallarano, dunque è salva. Avevo avuto formale e rassicurante promessa da parte del collezionista il quale al più presto mi avrebbe fatto avere una copia dell’intera relazione, che, appena avuta, immediatamente, avrei dato alla stampe. A distanza di ben 11 anni, però, non l’ho ancora avuta. Speriamo bene.
Le sopraccitate notizie sono le più antiche attestazioni riguardanti l’antico castello di Cerchio. Una fugace menzione ne fa, la maestra Tecla Vecchietti in Tucceri Cimini nel suo :” Cerchio Notizie storiche e Leggendarie”(53) :
”[…] Prima dell’ultimo terremoto, che distrusse parecchi/paesi della Marsica, del castello restava in piedi una parte/fino alla finestra del piano superiore, che i cerchiesi di una/certa età ricordano benissimo. Col terremoto il castello su-/bì ulteriori rovine, e i proprietari sui muri rimasti eretti/hanno edificato un tetto trasformando il locale in cantina./Ma un rudero si erge ancora e slanciandosi verso il cielo/pare implori la grazia di non scomparire completamente./Le mura del castello e quelle di cinta “ larghe e for-/ti” (cfr. Benedetto D’Amore : “ Miracoli e portenti della Madonna delle Grazie in Cerchio “, Aquila, Tipografia/Grossi, 1855 ) dalla parte detta “dietro i fossi” furono indebolite per il fatto che si fece passare in seguito una strada/di circonvallazione abbastanza ampia la quale favorì il/progressivo sgretolamento del vetusto fortilizio […]”.
Attualmente in località volgarmente detta “ngastej” ( letteralmente in italiano: in castello) nella proprietà delle famiglie Zavarella e D’Amore esiste un muro lungo 5-6 metri ed alto 3-4 metri formato da grandi blocchi rettangolari in pietra avente ad un lato (nella proprietà della famiglia Zavarella) una scarpa sempre in pietra, nascosto da un una siepe di edera, sono i resti antichi e maestosi forse o di un castello o di mura da difesa? Nei suoi pressi esiste ancora una strada denominata salita del Castello che si innesta dalla curva di contrada Acero. La strada passa poi sopra il ponte di Santa Lucia , nei suoi pressi vi era edificata l’omonima chiesa ( esistita fino alla fine del XIX secolo ) nota già il 18 marzo 818 quando l’imperatore Ludovico il Pio su richiesta dell’abate Theodomar, conferma a Montecassino i beni e gli edifici di culto :
“ […] in comitatu Marsorum cella Sancti Ianuarii in Torpiliano, Sancta Anastasia ibidem, Sanctus Maximus in Gurgu, Sancta Lucia in Circlu […]” (54)
e si immette, poi, nella curva detta “ dietro i fossi” e, girando a sinistra, va su sopra il nominato “ngastej”.
Perché non fare saggi per stabilire sia l’epoca della costruzione sia per capire di quali resti scientificamente questi facessero parte?
Sopra in località “ngastej”, nei pressi del muraglione fatto costruire, negli anni ’50 del passato secolo dall’amministrazione Comunale, esistevano ancora prima del terremoto del ’15, i resti dell’antica chiesa matrice intititolata a Santa Maria dell’Annunziata volgarmente detta “dentro” o “dentro le mura”.
Intorno al 1486 nasceva nel casale Paziano ( o Patiano ), territorio del Comune di Cerchio posto sotto l’attuale chiesa cimiteriale di santa Maria di Piediponte, il religioso Pietro Capocitto, eletto, nel mese di Maggio 1552, da papa Giulio III, alla carica di generale dell’ordine dei Celestini.
Nell’Archivio della Diocesi dei Marsi si conserva un frammento membranaceo recante la data del 2 Marzo 1493 dove vi figura un certo “ […] domino Petro Capocipti de Circulo […] “ non sappiamo al momento se questi era parente del Nostro, noi riteniamo di si anche perché, in quanto a fantasia, i Nostri lasciano molto a desiderare infatti si chiamano tutti Pietro: evidentemente dovevano avere un culto speciale verso il primo vescovo di Roma. L’attestazione più antica di tale casata l’abbiamo dal sopra menzionato ligio omaggio del 29 aprile del 1425 dove tra i vari attori, come abbiamo già avuto modo di dire, figura un certo “Mey Cappucipti de Circulo”.
Pietro Capocitto il Vecchio, futuro abate generale dei Celestini, fece la sua professione verso il proprio ordine il primo Settembre 1506 (vedi Appendice I ) e fu eletto Generale dell’Ordine nel mese di Maggio 1552 “[…] R.[everendus] D.[ominus] Petrus Capocittus de Circulo electus die ..a May 1552 Generale/Cap[itu]lus ex Indulto July iii ad Mense[m] 8[octo]bris prorogavit […] “ e morì, come afferma Muzio Febonio, all’età di ottant’anni, il 5 Novembre 1566, era nato, quindi, intorno al 1486:
“[…]Non poco ornamento apportarono ad esso ( Cerchio, n.d.r. ) l’uno e l’al-/tro D. Pietro Capocitto che furono portati all’apice del generalato dei/Celestini, il più vecchio dei quali essendo Abate in Siponto nello stesso/ anno in cui il Cardinale del Monte teneva la sede Arcivescovile, dove/egli raggiunse la cattedra del Pontificato massimo [ Giulio III, nd.]; il/fatto che aveva accettato quello di Abate, per la continua familiarità/
non lasciò affatto che la stima e l’osservanza della disciplina regolare e le/altre doti dell’animo rimanessero nell’ombre; ma per sostenere la verga/pastorale di tutta la Religione, in virtù del suo potere fù elevato alla/carica sublime di Generale di quell’Ordine tanto distinto subitamente/ si rivolse ai padri il 5 novembre 1566 (55)[…] L’altro nipote di lui, per/parte di padre, emulò le virtù rifulse per tutto l’ordine dei religiosi per/la magnificenza delle virtù, per la prudenza, per l’accortezza e per la/conoscenza di quasi tutte le scienze, tanto che per vari gradi delle ca-/riche non una sola volta meritò il più alto, ma meritò per quattro volte/( il 30 Aprile 1564, il 14 Maggio 1570, il 13 maggio 1576 ed infine il/ 12 Maggio 1582 n.d.r.) di ascendere all cospicua carica, ed in quella diede sé/stesso alle cure dell’ufficio pastorale che con nuove costituzioni purgò/
le cose corrotte, ultimate queste riforme meritò l’appellativo di riforma-/tore dei celestini: e non solo liberò il suo stesso ordine dai debiti, ma/accumulò moltissime ricchezze per usi futuri. Rinnovò il Monastero di/S.Eusebio di Roma, rovinatosi per l’antichità[…] avendo compiuto il/58° anno, ricco di fama, di virtù, nell’anno 1586 ( più esattamente morì/ il 9 Febbraio 1587, n.d.r.) strappato ai vivi a Barletta, in Puglia, fu stra-/sportato alla Chiesa di S. Spirito nel Morrone nella Cappella eretta poco/prima da lui stesso […]” (56)
Pietro Capocitto ‘Il Vecchio’, come già abbiamo visto, era pronipote, di Pietro Janitella (o Jannetella) di Aielli :
“[…] R.[everendus] D.[ominus] Petrus Capocittus de Circulo 1552, Rev.[everendissi]mi D.[omini]/Petri Janitelle ab Agellis Episcopi S.[anc]ti Angeli de/Lombardis ex Nepta Pronepos[…] “ (57)
monaco Celestino, priore del monastero di S. Eusebio in Roma nel 1426 ed eletto vescovo di S. Angelo dei Lombardi il 13 Agosto 1427 dove rimase per poco di più vent’anni, fino al 27 novembre 1447 quando rinunciò a tale incarico: “[…] ren.[unciatio] Petri Pogalus (Possulus Ursoni), can[onicus] Surrentin[i] 1447 Nov. 27 […]” (58)
Il Nostro fu “Commissario per la riforma dell’abbazia di Montecassino, commendatario dell’arcipretura di S. Maria “ad lacum” in Luco dei Marsi, forse fu promotore della devozione allo Spirito Santo che, in quel paese, vide fiorire, nel corso di quel secolo XV, la confraternita dei “ Signori dello Spirito Santo “. Il 7 Aprile 1422 è Priore del Monastero di Collemaggio ed il 6 Gennaio 1426 lo troviamo priore presso il Monastero di Sant’Eusebio di Roma. Il 12 Luglio 1424 è Priore del Monastero di Sant’Eusebio di Roma e Amministratore Apostolico del Sacro Monastero di Cassino ed il 25 Gennaio 1426 prende possesso della Chiesa di Santa Maria di Luco dei Marsi (59). Mons. Janitella era amico dell’illustre prelato nonché mecenate ed amante dell’arte e della cultura Monsignor Amico Agnifili di Rocca di Mezzo ( 1398-1476 ) consacrato vescovo dell’Aquila alla presenza di illustri prelati fra i quali anche il Nostro Pietro Janitella, il 4 Luglio 1431. Amico Agnifili fu amico e compagno di studi di Enea Silvio Piccolomini il futuro papa Pio II. Per l’alta considerazione e stima avuta da Papa Paolo II ( al secolo Pietro Barbo,1417-1471, eletto al soglio pontificio il 30 Agosto 1464 ), allievo del Nostro, fu da questi creato Cardinale: “ secondo alcuni designato nel 1464 e tenuto segreto fino al 1467 quando fu formalmente pubblicato il 18 settembre, ricevendo il cappello cardinalizio il 22 dello stesso mese e il titolo di S. Balbina il 19 novembre di quell’anno, cambiato, il 13 novembre 1469, con quello di S. Maria in Trastevere (60).
Pietro Capocitto “il Giovane “ era nipote di Pietro il Vecchio :
“[…] R.[everendus] D.[ominus] Petrus junior Capucittus de Circulo S.T.P./D.[ominus] Petri Seniores ex Frate Nepos[…]” (61)
e zio di Pietro di Aielli :
”[…] R.[everendus] D.[ominus] Petrus ab Agellis D.[omini] Petri Capocitti Juniores de Circu=/lo ex Sorore Nepos[…] “ (62)
eletto abate generale il 30 Aprile 1603 : “ […]R.[everendus] D.[ominus] Petrus ab Agellis electus dei 30 Aprilis 1603[…] “ (63).
Da queste stringatissime notizie si evince la grande importanza che rivestirono i sopramenzionati illustri personaggi dei tre limitrofi paesi : Cerchio, Aielli e Rocca di Mezzo, in un arco di tempo che va dall’ultimo ventennio del secolo XIV° alla prima metà del XVII° secolo uniti tutti da un forte rigore religioso.
Sembrerebbe a prima vista, non abbiamo elementi a sostenere questa tesi, come se questi fossero uniti anche da un unico retaggio parentale o comunque, sicuramente, amicale.
Non sappiamo se il Vescovo Gentile di Aielli fosse parente dell’altro vescovo Pietro Janitella di Aielli , certo è che , in un paese così piccolo i due vescovi dovevano conoscersi così come pure le loro famiglie.
Difficile, nell’epoca del nepotismo, che questi fossero immuni da tale “contagio”.
Chissà se il vescovo Gentile o il suo entourage pose i buoni servigi alla elezione di Monsignor Janitella alla carica di Priore del Monastero Benedettino di Sant’Eusebio in Roma e poi anche alla carica vescovile.
Mons. Pietro Janitella, sappiamo, attraverso il sopra citato documento, che era prozio di Pietro Capocitto il vecchio, eletto Abate Generale dell’ordine dei Celestini nel mese di maggio del 1552 e quest’ultimo, a sua volta, era zio dell’altro Pietro Capocitto il Giovane: il Riformatore dell’Ordine dei Celestini, eletto per ben quattro volte a tale prestigiosa carica. Pietro Capocitto il Giovane era, a sua volta, come abbiamo già visto, lo zio di Pietro d’Aielli eletto alla carica di Generale dei Celestini il 30 Aprile 1603 e, questi, a sua volta, era zio dell’altro futuro abate celestiniano Francesco Maceroni (o Macerola) di Aielli:
“[…]fatto la sua Religione, che vistolo ancora giovanetto seguitare le gloriose orme del Reverendissimo Don Pietro, Suo gran Zio[…]” (64)
Il sopracitato Don Pietro è senz’altro il Generale dei Celestini Pietro di Aielli morto nella città dell’Aquila il 13 novembre 1606. Notizia questa importantissima e non messa nella dovuta evidenza da padre Giacinto Marinageli nel suo ottimo articolo: “ I Celestini nella Marsica” (vedi più sotto).
Quindi per oltre due secoli, dal 1422 al 1640, questa singolare etnia parentale che accomuna i paesi di Cerchio ed Aielli, si è avvicendata, per le alte virtù e qualità dei suoi appartenenti, al comando dell’Ordine dei Celestini.
Francesco Macerola ( o Maceroni) fu eletto all’ onorevole carica di Generale dell’Ordine dei Celestini, la prima volta, il 2 Maggio 1627 e la seconda ed ultima volta, il 14 Aprile 1636, quattro anni prima della sua morte avvenuta, come accennato, nel 1640.
Il suo corpo fu tumulato, dove attualmente si trova, il 17 aprile 1640, nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio dell’Aquila, come chiaramente è riportato nell’orazione funebre eseguita nella medesima sopracitata giornata dal “ Dot.[tor] Equitio Mausonio “ (65).
L’elegante monumento funebre, formato da due lastre di pietra calcarea ( cm. 248 per 86) posto orizzontalmente a pari di pavimento, raffigura, in bassorilievo, un’abate celestino vestito in pompa magna con, recante in alto a sinistra, a fianco della sua testa, il proprio stemma gentilizio (cm. 191 per 72,5) e, l’altra ( misura cm. 72,5 per 38) reca incisa il cursus onorifico del Nostro: il tutto è circoscritto da una marmorea cornice. Chissà se il funebre bassorilievo rappresenta realisticamente il Nostro. Tale monumento è posto a sinistra di chi entra, prima dell’altare maggiore e reca la seguente, purtroppo, mutila iscrizione a causa dei guasti avvenuti nel corso dei secoli (nella catastrofica notte del 6 aprile 2009 quando la città dell’Aquila, con il suo intero comprensorio, è stata violentemente sconvolta dal tellurico mostro):
“ D O M
VIATOR […]RTIS[….]NDITO ROSAS
REVER. D. D. FRA[…]DAL[….]GERO VIRTUTU AGELLO
CUIUS APOLL[…]NTIA VITAE INTEGRITATES
ANIMI CAM[…]ORUM[…]ANTIAE SU DUS EIUSDEM AD
C[…]RA[…]OROM IDEM AD EGENERALATUS
[…]ICEM BI […]IO CONVECTAVIT
[…]EIUSDEM EO EVECUTRA ROSA
[…]CH[…]ONU ELASSET SYDUS DEFRONDASSET ROSAS
[…]DIRVISSET AGELLUM
OB.AC[…]AETAT. SUAE LXXII QUINTO KAL. MAY
D. PETRUS MARIUS ABBAS TANTO PRI COLLA CR. POSUIT”.
Il Nostro quindi era nato ad Aielli intorno al 1568 in quanto come chiaramente si evince nelle “ESSEQUIE FUNERALI”(vedi) il suo funerale fu eseguito il giorno 17 Aprile 1640 nella “Regia Chiesa di Collemaggio” e, nella sopracitata epigrafe, apprendiamo che alla data della sua morte, il Nostro, aveva 72 anni. .
Dall’ottimo ed interessante lavoro di padre Giacinto Marinangeli: “I Celestini nella Marsica” (66) pubblicato su “I Celestini in Abruzzo: figure, luoghi, influssi religiosi cultuali e sociali: Atti del Convegno: L’Aquila, 19-20 maggio 1995”, L’Aquila: Libreria Colacchi: Deputazione abruzzese di storia patria, 1996, apprendiamo:
“[…] Altro abate marsicano fu, come sopra accennato, Pietro da Aielli, nipote per parte di sorella, di Pietro Capocitti senior ( in realtà da come abbiamo soprariportato lo zio era Pietro Capocitto il Giovane (junior) e non il Vecchio (senior) n.d.r. ). In tal modo i due paesi di Cerchio e di Aielli si legano alla storia celestina in grazia di questi insigni generali. Abate nel 1603 per un triennio, fu angustiato dalle manovre e pretensioni del Ministro provinciale di Francia, Carlo Campigny. Era costui uomo di talento e d’indubbie doti, sia d’intelletto che d’azione e tendeva a considerarsi pari all’abate generale e considerare la sua provincia di Francia quasi del tutto affrancata alla giurisdizione dell’abate generale residente in Santo Spirito del Morrone. La vicenda si trascinò nel tempo e, non trovandosi una soluzione onesta, fu deferita a Roma e la Sede Apostolica riaffermò i diritti e le prerogative sovrane dell’abate generale su tutti i monasteri, su tutti i membri della Congregazione celestina. A distanza d’una ventina d’anni dall’abbaziato dell’aiellese Pietro, fu eletto un altro suo conterraneo ( in realtà, da come abbiamo sopra riportato era suo nipote n.d.r. ), Francesco da Aielli. Ma, nel frattempo, importanti eventi si erano avverati nell’ambito della Congregazione Celestina. Abbiamo accennato alla controversia Pietro d’Aielli e Carlo Campigny e la definizione della controversia data dalla Commissione dei Cardinali incaricati e sancita dallo stesso Sommo Pontefice. Nel 1607 veniva nominato Protettore Roberto Bellarmino, sotto la cui protettoria rilevanti atti cercarono di condurre a compimento quel movimento di riforma, che era stato portato avanti dall’abate Pietro Capoccitti junior, in ossequio alla volontà del Cardinal Protettore, interprete ed esecutore della stessa volontà del Pontefice, Paolo V, cui l’Aragona era particolarmente caro. L’azione del nuovo Protettore, il Bellarmino, rese necessaria un’ulteriore revisione delle Costituzioni Generali che quindi videro una nuova edizione nel 1627 ed una seconda nel 1629. Fu opera d’un altro abate generale marsicano, il sunnominato Francesco da Aielli. Fu eletto, una prima volta, nel 1627, per un triennio, ed un secondo triennio gli fu attribuito nel capitolo generale del 1636. Egli è ricordato con l’ufficio di procuratore del Santo Spirito di Sulmona, priore di Collemaggio, al tempo delle ricerche che nel locale preziosissimo archivio vi fece prima Lellio Marini, e, successivamente, Ludovico Zanotti. Ebbe questioni con i Piccolomini, signori di Celano, ma va ricordato, soprattutto, per aver ripreso energicamente l’azione dei conterranei Capoccitti junior e Pietro d’Aielli nello spingere avanti l’avviata riforma disciplinare-amministrativa della Congregazione. L’abate generale, nel presentare il testo aggiornato, dedicandolo al nuovo Card. Protettore, il Principe di Savoia Maurizio Emanuele, con le solite espressioni encomiastiche, come il secolo chiedeva, dichiarava:<<..ut ipse Ordo in sua sinceritate integer, et illibatus permaneat, atque mores corrigantur…Constitutiones redigi fecimus…>>. Segue l’approvazione papale di Urbano VIII e, come di norma, il testo delle stesse Costituzioni, alle quali fa seguito la Regola di San Benedetto e una raccolta di << Privilegia Coelestinorum>>. Francesco da Aielli è ricordato, come si diceva, con rispetto e simpatia da Lelio Marini, da Celestino Telera, da Ludovico Zanotti. Sono i tre maggiori storici del celestinismo, ciascuno con una sua propria fisionomia: il primo con intendimenti più vicini alla critica storica, il secondo inclinando verso una storia <<agiografica>> di edificazione, il terzo con intendimenti più spiccatamente annalistici[…]”.
Chissà se a tali elezioni, in qualche mondo hanno influito i nostri illustri personaggi? Sicuramente a tutto l’Ordine dei Celestini erano ben note le grandi figure di Mons. Jannitella e dei due Pietro Capocitto.
E l’ultimo “ D. Petri Capocitto ex Avezzano “ che il 25 Giugno 1636 viene incluso nelle “Professiones Monachorum” (67) è parente dei Nostri?
Il 4 Luglio 1431, come abbiamo su detto, fu consacrato vescovo dell’Aquila nella medesima città, Mons. Amico Agnifili di Rocca di Mezzo alla presenza di illustri prelati fra i quali vi era anche il vescovo di Sant’Angelo dei Lombadi Mons. Pietro Janitella.
La presenza del Nostro fu una mera coincidenza oppure era stato scelto per partecipare a tale cerimonia?
Da questo breve excursus possiamo asserire che il vescovo Gentile sia stato il capostipite di questa etnia altamente religiosa. Al momento, però, non sappiamo se vi fossero anche legami parentali sia con Mons. Pietro Janitella e di conseguenza con i Capocitto, che con il Cardinale Amico Agnifili ( Amico di Coletta di Cecco ).
Mons. Janitella doveva essere per forza di cose amico di Monsignor Amico Agnifili di Rocca di Rocca di Mezzo anche se, ad onor del vero, al momento non abbiamo un documento sincrono dove si nota ciò però, è ragionevolmente logico, che i due si conoscessero anche perchè Mons. Janitella per essere presente alla sua consacrazione dovette spostarsi da Sant’Angelo dei Lombardi ed intraprendere, per quei tempi, un non lieve viaggio.
Il mecenate Amico Agnifili fu amico e compagno di studi di Enea Silvio Piccolomini il futuro papa Pio II. Per l’alta considerazione e stima avuta da Papa Paolo II ( al secolo Pietro Barbo, 1417-1471, eletto al soglio pontificio il 30 Agosto 1464 ) allievo del Nostro, fu da questi creato Cardinale: “ secondo alcuni designato nel 1464 e tenuto secreto fino al 1467 quando fu formalmente pubblicato il 18 settembre, ricevendo il cappello cardinalizio il 22 dello stesso mese e il titolo di S. Balbina il 19 novembre sempre di quell’anno, cambiato,il 13 ottobre 1469, con quello di S. Maria di Trastevere” (68). Lo storico nonchè segretario della Deputazione Abruzzese di Storia Patria Mons. Giacinto Mariangeli aveva, con sapienti pennellate, descritto, nel suo ottimo saggio a cui si rimanda (68), la Figura del Nostro. A noi piace riportare l’inzio, a mò di incipit, del suo sagace intervento:
“[…] La ricorrenza del sesto centenario della nascita di Amico/Agnifili (1398 – 1476 ), mi spinge ad abbozzare un sobrio pro-/filo sulla sua figura ed attività, con particolare attenzione/alla sua presenza ed azione nell’ambito della Chiesa catto-/lica quattrocentesca, che da quella “locale” a lui affidata, guardò, in più mansioni e circostanze, a quella universale./Il modesto saggio viene pubblicato in questo Bullettino in/considerazione anche, che nel corso di oltre cento anni/dalla fondazione, nonostante sotto i suoi occhi e talora parte-/cipandovi da protagonista, si snodassero eventi di portata dav-/vero storica, nè già limitata alla sua città, dall’epica gloriosa /guerra “braccesca”, fin quasi al declino dell’ ”Aquilana li-/bertas” alla cui vicenda e rinomanza egli stesso aveva ag-/giunto lo splendore del suo episcopato prima, quindi del/cardinalato, donde talora veniva evocato e più tardi ricor-/dato col significativo appellativo di “ Cardinale dell’Aquila” o “Aquilano “[…]”.
E piace mettere in evidenza anche l’ottimo scritto dello storico Antonio Manfredi il quale nello stesso Bullettino ha pubblicato il suo : “ Amico Agnifili e i libri liturgici della biblioteca provinciale “Tommasi” dell’Aquila “ (70) facendoci partecipi dell’amore di questi verso il mondo dell’arte e della consistenza della sua biblioteca, ahimè, andata dispersa:
“[…] Anche le tracce della raccolta personale dell’Agnifli,/ che il cardinale volle fosse collocata accanto a sé il giorno/della sepoltura, andranno cercate, se ancora se ne con-/servano, seguendo le piste parallele a queste, cioè forse cercando nelle istituzioni ecclesiastiche aquilane o presso qualche erede remoto. E’ dunque importante a questo punto met-/tersi alla ricerca di elenchi librari antichi riferiti o riferibili/alle chiese aquilane, in particolare al capitolo e di cui non si/trova notizia, per quanto ho potuto(sic) finora sapere, in pubbli-/cazioni a stampa, anche perché nei confronti dei beni dell’Agnifili non fu esercitato, a quanto pare, il diritto di spo-/glio e quindi in Vaticana non sono emersi finora suoi libri (…)Il Corale 3 R 136 e l’Antifonario 5 R 136della Biblioteca/”Tommasi”, da poco restaurati, fanno parte di una raccolta/libraria in gran parte proveniente dal convento francescano/di San Bernardino. Su di essi è presente, sormontato da ga-/lero rosso, lo stemma agnifiliano, d’azzurro all’agnello di/bianco, intero, di profilo, all’impiedi con in capo un libro sigillato, di rosso.[…] la raccolta di cui fanno attualmente parte si compone di/ventinove libri quasi tutti di grande formato e di contenuto/liturgico: la tipologia è quindi quella dei volumi da coro,/corredati di notazione reumatica.Il carattere unitario del/fondo si coglie anche dalla storia di questi volumi, giunti/fino a noi in condizioni precarie. I libri hanno infatti subito/traumi, ma soprattutto una notevole usura, al punbto che alcuni risultano, per così dire, stremati. Questa condizione è/comune a molti codici analoghi, allestiti con rozza robu-/stezza, perché destinati all’impiego frequente(codici d’uso),/quindi esposti con il loro ampio formato agli strapazzi di sa-/crestati frettolosi e a restauri casalinghi e grossolani. Inoltre/la diffusione, nel giro di un secolo e mezzo, tra Cinque e Sei-/cento, di libri liturgici a stampa e di riforme liturgiche inci-/sive, portò ad un abbandono- lento però e progressivo- del/materiale precedente, che si trovò esposto al seccheggio/delle miniature più appariscenti, spesso riunite poi in colle-/zioni di fogli staccati, o al taglio dei larghi margini di perga-/mena riutilizzati per pratiche ben più materiali, o addirit-/tura al riuso di interi fogli per irrobustire o ricoprire dorsi e/legature dei libri a stampa.Di una produzione che dovette/essere massiccia rimangono tuttavia molti poderosi relitti,/che ebbero storie diverse a seconda degli enti religiosi che li/custodivano: quelli qualitativamente migliori subirono ven-/dite o ulteriori dispersioni, altri rimasero e rimangono ancor/oggi chiusi, a volte abbandonati, nelle sacrestie, altri ancora, credo la parte maggiore, giunsero con le soppressioni, dentro musei o collezioni locali, creando con la loro stessa mole/e per le loro precarie condizioni non poche difficoltà ai con-/servitori. Fino a tempi recenti questi libri hanno goduto di/scarsa attenzione da parte degli studiosi: considerati tardi e/diffusissimi dai paleografi, di solito sono stati consultati/quasi solo da eruditi locali o da storici dell’arte a caccia di/miniature di scuole tardo umanistiche o rinascimentali. E anche i primi tentativi di restauro moderno si sono in se-/guito rivelati spesso sempre infelici.[…]Entro tutta la raccolta si distingue facilmente un primo/nucleo di volumi, databile alla seconda metà del Quattro-/cento, a cui se ne sono via via aggiunti altri più recenti. Solo/due dei libri liturgici aquilani portano lo stemma dell’Agni-/fili e per essi soli dunque è possibile essere certi della com-/mittenza cardinalizia, tuttavia un’analisi pur sommaria di/tutto il blocco porta ad aggregare ai due libri oggetto di re-/stauro altri volumi affini, sia dal punto di vista paleografico/che da quello codicologico […]”
Anche noi siamo stati spinti a scrivere queste stringate note relative ai religiosi illustri di Cerchio, Aielli e Rocca di Mezzo per mettere in evidenza ancora una volta, là dove ce ne fosse stato bisogno, l’amore verso il “Bello ” che i nostri antenati , anche se vivevano in umilissimi e “selvaggi” borghi, nutrivano verso il mondo dell’Arte.
Ebbero anche i Cerchiesi e gli Aiellesi una loro biblioteca privata? Dobbiamo supporre di si e se così fosse dove ora sono conservati i tomi che la componevano?
A Cerchio si conservano, nel locale Museo Civico, due graduali miniati sicuramente coevi ed ascrivibli al XV secolo di cui uno, tra le varie annotazioni ne riporta una, la più antica, relativa all’anno 1457 riguardante un “evento horribile” (71), e l’altro, noto come il “graduale di Licharane” riporta una interessante messa; un’antifonario a stampa del 1548 (72), appartenenti sicuramente alla chiesa matrice di Cerchio e due tomi a stampa di S. Gregorio Magno: uno del XVI e l’altro del XVII (73) appartenenti al Convento degli Agostiniani Scalzi di Cerchio (74). Ad Aielli, presso l’archivio comunale invece, si conserva di quei secoli, purtroppo, un solo frammento di pergamena musicale (75) e una parte frammentaria di una versione in nove canti dei “Cantari del Danese “ data alle stampe nel mese di febbraio 2010 per i tipi della benemerita casa editrice Grafiche Di Censo dal titolo : “ La saga di Uggeri il Danese in Abruzzo : I Cantari di Aielli “ scritta da Fabio Carboni e Francesco Avolio. Per quanto riguarda invece Rocca di Mezzo dobbiamo far nostro quanto il sullodato Antonio Manfredi ha scritto e da me soprariportato.
Ho cercato in questo mio scritto di mettere in evidenza quanto sono stati importanti nel medioevo gli umili borghi italiani sempre, almeno per lo più delle volte, saggiamente guidati da mani capaci e spesso, questi personaggi, sono avvolti dalla nera coltre dell’oblìo a causa della matrigna terra aquilana martoriata da terribili e tremendi terremoti che tutto hanno distrutto e disperso persino le gesta dei nostri oscuri eroi. Solo pochi hanno avuto la fortuna di essere ricordati attraverso documenti fortunosamente salvatosi dall’incuria e dall’ingiuria del Tempo e dell’Uomo. Durante il XV secolo singolari figure di maestri itineranti come per esempio l’umanista Gian Battista Valentini detto il Cantalicio (1450-1515) fortemente contribuirono alla erudizione dei propri allievi:
“[…] pur nel difficile e dialettico rapporto del maestro con i suoi allievi ritrosi, la/continua lotta per la sopravvivenza dell’umanista che, tolti pochi casi/illustri e fortunati, si riduceva quasi sempre nei panni del modesto/grammatico costretto a sminuzzare in briciole non indigeste il pane/di un’eletta retorica pur di procurarsi di che mangiare :/ Agli studenti spoletini aveva posti patti chiari: se volete sapere che cosa sia/la grammatica, datemi galline; se rettorica, datemi capponi; se volete appren-/dere poesia, pane con carne e prosciutto./Ai discepoli della Marsica, al tempo delle feri di Carnevale, folaghe del Fucino,/capretti, agnelli, lepri, porchette, forme di cacio, zafferano, e cento uova per/risanare il cervello che essi gli strapazzavano con le loro assillanti domande./[…]”(76).
Come singolare certamente fu anche la figura dell’anomino cantastorie del sopracitato manoscritto di Aielli che di paese in paese cantava le nobili gesta del paladino “ Uggeri il Danese “ che una volta dilettato i trepidanti astanti soleva salutarli :
“[…] Sigiuri et cavalleri et merchatanti,
se io avesse nello mio dicto fallato,
in cortessia vi prego tucti quanti
che zasscheuno m’aia perdunato
quanno io returnarò qua davanti
< e vui > retornarete in quissto lato,
< io ben >e contaragio tucta gente
< l >e vertute de Cristo honypotente[…] “.
Attraverso la lettura dei sopraccitati graduali sono riuscito a scoprire, per quanto riguarda il territorio di Cerchio, le annotazioni scritte da ignoti amanuensi, sicuramente i parroci della chiesa matrice di Cerchio, di ben, purtroppo, 4 terremoti accaduti nel nostro paese :
“ Nello ando de missere domine dio mille cccc° LVII et adì[…] della V. indizione cioe allo di de Sabato[…]di foj dito horribile[…]tiquo no[…]ita vament[…]stato une udirlo dis[…]”
“ Adì p[rim]o di 9[novem]bre 1633 giorno di martedì ad hore venti in circa/prima che cominciasse il Vespero, fù un grnadidd[i]mo, et spaventoso terremoto/che fece tutti restare smarriti p[er] no[n] essere udito più il Simile, et dopo finito il/Vespero delli defonti dal R[everen]do Clero p[rese]nte il Popolo fù esposto il S[antis]S[i]mo Sacramento/co[n] grandiss[i]ma devozione acciò no[n] rasicondasse come p[er] gratia del Sig[no]re sono “
“ Adi 19 di Gennaro 1648 La matina circa le 14 hore mentre si celebrava la p[ubblic]a messa fu un terri[bile] Terremoto/più Terribile degli anni passati. Nel qual tempo stava assediata la T[er]ra di Celano Dal Pezzola per providere/Gente della Sere[nissi]ma Repubblica di Napoli, et in d[et]ta T[er]ra di Cerchio vi erano 150 soldati “
“ Adì 14 Gennao 1703. Dom[eni]ca 2.[second]a dopo L’epifania verso un’hora, e mezza di Notte fù/similmente un T[e]r[ri]b[i]le terremoto che qui in Cerchio cederono alcuni travi e tavole in alcuni/tetti de par[tico]l[a]ri, et anco muraglie de Casaleno, e fù proprio il 3° anno dopo la Morte di Carlo 2° Rè,/e Monarca di Spagna di Casa Austriacha: Nel qual te[m]po terribilm[en]te si guerreggiava la d[ett]a Monar=/chia dal Go[…]atore con il Duca d’Angiò Nipote di Luigi Rè di Francia con numerosis[sim]i Eserciti/d ambedue le diverse parti, e nell’istesso Anno il Sangue del Glorioso S. Gennaro in Napoli n[o] fè il so/lito miracolo della liquefatt[io]ne del proprio Sangue, q[ua]le diede gran timore a viventi; qu[al]e Ter[remo]to replicò/due altre volte in d[ett]a notte, ma n[o]n così terribilm[en]te cioè che à pena fù conosciuto”.
Un altro terremoto , accaduto a Cerchio il 30 Dicembre 1850, è riportato nella deliberazione comunale del 5 Gennaio 1851:
“[…] Ma la disgrazia che si ebbe del forte terremoto avvenuto la mattina dei trenta or caduto mese ha fatto si che non possa neppur da questo fondo prendersi cosa alcuna, poiche ha rovinato quasi tutte le chiese di padronato di questo Comune frà le altre la parrocchiale di cui la cuppola ha sofferto in più punti ed a bisogno di sollecito riparo. In quella della Vergine SS.ma delle Grazie deve nuovamente ricostruirsi l’intiera volta, con il tetto la Chiesa del Camposanto con il Camposanto istesso ed in generale tutti gli edifici Comunali han sofferto, ed han bisogno di riparo, ed all’oggetto si e fatto venire l’architetto Signor d. Rosario Baldi per redigerne le Corrispondenti perizie […]” (77)
E quello, purtroppo, tristemente noto e famoso del 13 Gennaio 1915 dove perirono in tutta la Marsica più di trentamila persone di cui più di diecimila nella sola Avezzano: a Cerchio i morti furono 254, ad Aielli 220 ed a Collarmele 555 .
Ed infine il terremoto del 6 Aprile 2009 che ha arrecato nell’interlnad dell’Aquila 205 vittime. Il violento ruggito, accompagnato da una misteriosa ed agghiacciante folata di vento, delle ore 3,32 di quella fatidica alba è stato fortemente sentito non solo dalla popolazione cerchiese bensì dall’intero comprensorio marsicano; questa volta, però, la matrigna natura ha risparmiato la nostra sub regione marsicana non causando alcuna vittima e l’ultimo: il terremoto del 24 agosto 2016, delle ore 3,36 avvertito a Cerchio e nell’intero aquilano che ha sconquassato Amatrice ed i paesi limitrofi causando 294 vittime: nella sola Amatrice i deceduti a causa del sisma sono stati 230.
Una buona parte della dispersione del patrimonio artistico è sicuramente dovuta più che al terremoto come fenomeno naturale bensì al post terremoto cioè all’uomo anche se, bisogna dire, molti si prodigarono al recupero: toccante, semplice, concisa e precisa fu la lettera del Regio Ispettore Onorario Dott. Vincenzo Sabatini ( 1852-1942 ) di Cerchio che il 29 Aprile 1915 inviò a quanti amavano le bellezze artistiche (78).
Sicuramente l’incuria dell’uomo ha causato il non reperimento in loco dei documenti di qualsiasi genere utili per descrivere più compiutamente la storia dei luoghi e la storia familiare di quanti, nella loro epoca, si distinsero : su questi è caduta una fitta coltre di nebbia che molto difficilmente si riuscirà a dipanare.
Nonostante alcuni personaggi si siano lodevolmente distinti, come nel nostro caso, nel mondo religioso, è molto difficoltoso tracciarne esaurienti biografie di alcuni, infatti, non sappiamo né il cognome, né quando sono nati e morti, né il nome dei genitori, né dove sono sepolti né sappiamo dove questi illustri personaggi abbiano studiato, né, infine, sappiamo lo svolgimento del loro cursus onorifico né chi furono i loro corrispondenti. Senz’altro hanno meritato di occupare il posto che ebbero.
Il Nostro impegno, di coloro cioè che hanno a cuore le cosiddette “historiae minores “, è quello di scavare ed andare alla ricerca magari di lontanissimi parenti o di rinvenire documenti, scritti o addirittura libri che a loro appartennero per vedere se vi sono delle annotazioni o qualsiasi cosa per cercare di recuperare, come speciali reliquie, frammenti utili per le nostre ricerche.
Altre cause della dispersione sono dovute anche, a pestilenze (79), furti, saccheggi, incendi, esodi e anche per la noncuranza di chi doveva ed eticamente era tenuto a salvaguardare e proteggere tali Beni.
Con il presente mio modesto lavoro ho cercato di portare un po’ di luce a questi personaggi oscurati dall’inclemente Tempo e dall’Ignoranza che ancora oggi, purtroppo, regna invitta nel Mondo.
Ho scritto queste modestissime note affinché altri continuassero e maggiormente apportassero ‘luce nova’ a coloro che si sono prodigati a favore della Conoscenza e mi perdoni il Sommo Vate:
“ […] Considerate la vostra semenza:
fatti no foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza […]”.
Perché non dedicare loro una strada, una piazza, un largo?
Cerchio, 23 Aprile 2019
FIORENZO AMICONI
Il presente lavoro, già dato alle stampe nel 2010 su il Quaderno n. 116 del Museo Civico di Cerchio, è stato in parte rielaborato con qualche aggiunta.
Note
- Vedi appendice.
- MEMORIE ISTORICHE DEGLI AURUNCI ANTICHISSIMI POPOLI DELL’ITALIA E DELLE LORO PRINCIPALI CITTA’ AURUNCA E SESSA RACCOLTE DAL SIGNOR D. TOMMASO DE MARI DEL PEZZO DE’ MARCHESI DI CIVITA TRA GLI ARCA DI DAMISCO GLAFIRIANO IN NAPOLI MDCCLXI PER GIUSEPPE MARIA SEVERINO BOEZIO.
- BERARDI M.R.: “ UNA DIOCESI DI CONFINE/TRA REGNO DI NAPOLI E STATO PONTIFICIO/documenti e regesti del fondo pergamenaceo/della Curia Vescovile dei Marsi/(secc. XIII-XVI )”, EDIZIONI LIBRERIA COLACCHI L’AQUILA/ Tipografia G.T.E. s.r.l., L’Aquila, 2005.
- BERARDI M.R. : “ Poteri centrali e poteri locali nella Marsica in età angioina “, in AA.VV. : “ La Terra dei Marsi/cristianesimo, cultura, istituzioni “/ a cura di Gennaro Luongo, Viella Libreria Editrice, Tibergraph s.r.l. Città di Castello, 2002.
- AA.VV. : “ ARCHITETTURA E ARTE NELLA MARSICA/1984-1987/II ARTE “, L.U. JAPADRE EDITORE/L’AQUILA-ROMA, Edigrafital S.P.A. 1987.
- Si ringrazia pubblicamente l’amico Giuseppe Grossi per avermi fornito le notizie, che qui si riportano, riguardanti l’ “ INVENTARIUM BONORUM EXCELLENTISSIMI DOMINI COMITIS CELANO (1387-1388) in Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Barberini, II, 1994 (B)
[INVENTARIUM A.[NNO] D.[OMINI] 1387]
f.1r
In Dei Nomine amen./Quaternus inventarii continens omnia/et singula bona stabilia que vir magnificus/Rogerius Celani comes habet in Comitatu suo/Celani et aliis locis extra Comitatum men/surata per mensuram cande nec non et alia iura collectas, redditus et prestationes alias quascumque/ac ius patronatus ecclesia rum si qua fuerit, factus anno Domini mi/llesimo trecentesimo octuagesimo septimo, decime indictionis/de mandato ipsius comitis est pro ut infra describitur./In primis videlicet:[…]
f. 10v
IN CASTRO AGELLI
Videlicet in primis,/Habet Curia Celani in Agello cabellam baiu/lationis que est omni anno in carlenis argenti uncias/undecim./Item habet cabellam iudicatus omni anno que est in carlenis/argenti tareni decem et octo./Habet collectam montenearum quod siquis homo ipsius castri/hiis pecudes debet ipsi Curiae solvere pro fida ipsa ducatos/duos per centenarium./Habet Curia ipsa cabellam Lacus Fucini partinentiarum/ipsi Curiae omni anno in carlenis argenti uncias triginta./Habet Curia ipsa quendam cabellam que vocatur Silve Fucis/et venditur omni anno plus emere volentibus./Habet Curia ipsa cabellam in Lacu Fucini partinentiarum Casalis/Pentome que omni anno venditur plus emere volenti bus./Habet curia ipsa patronatum ecclesi Sancte Trinitatis que/ecclesa
f. 11r
noviter est edificata per virum magnificum Rogerium/Celani comite ac etiam et dotatam./Item habet Curia ipsa patronatum ecclesie Sancte Marie de Acuto silicet/in medietate ipsiu ecclesie.2 ( (2) di seguito : “ Item habet dicta Curia in Sancta Christina de olivis in pluribus locis/pedes tricentos septuaginta sex./Item habet dicta Curia ibidem de olivis que fuerunt domini Brachi/pedes viginti”. Il testo,qui posto per errore, non è depennato ma, a margine: “ vacat quia posite sunt/dicte olive in alio loco” ) Item habet dicta Curia in orto Petrelle de Sancta Christina pedem/unum de celso./Item habet post domum Agustini de Sancta Christina de celsis pedes tres./Item in ortalibus Christine Sancte pedem unum de celso./Item habet ad Petram Cavam in terra Antonii Cicci de Molessiano, et/in terra Petrelle Vertoni de celsis pedes decem et octo./Debentes solvere adoham in Castro Agelli/Sunt hii videlicet, in primis/Nicolaus
f. 11v
Andre de Sancto Iohanne den. XII/Heredes Iohannis Techie gr. III/Nicolaus Iohannis Bartolomei cum fratre tr. I, gr. X/Item in alia gtr. VIII, II ½ /Heredes Andre Basilis gr. III/Aloysius et Iohannes notarii Petri g. V, den. V/Iohannes Recchie de Filimine pro Philippa Massarii g. III, den. IV (Localita’ ancora oggi attestate nella mappe comunali: Flimini al Foglio n.11.Volgarmente è nota come “Frim’n’”. Nell’antichità ,in questa località eistevano ben due chiese San Pietro in Filimini e san Martino in Filimini n.d.a)/Berardus Nicolai Thomasselli g. V, den. V/Angelus Ray g. V, den. V/Giptius Silvestri g. VI/Nicolaus Angelicti de Ozano et Palma Nycolai Butii g. IIII, et sex t.( Località attestata nella mappe comunali come San Vito [esiteva nel 1115 S. Vito de Ozano ] riportata ai fogli n. 8 e n. 9. Nei suoi pressi c’è, attualmente, la fontana di S. Vito n.d.a.)/ Nicolaus Petri Rimandi cum nepote tr. I, g. II/Nicolaus Notarii Mathei tr. I/Ciccus Cole Masii pro bonis Leonis Capudgrassi tr. I, gr. XV/Petrus Angeloni gr. V, t. II ½ /Idem Petrus bonis uxoris gr. V, t. II/Angelus Paulotii gr. XV/Dompnus Amicus de Pentoma pro duabus partibus et Iacobus Philippi pro tertia parte tr. V, gr. X/Constanzia g. III/Petrus notarii Pauli tr. I, gr. X/Colecta Macthutii notarii Mathei gr. VI, t. II/Iaocbus Mathei notarii Mathei cum Amico eius fratre g. XIII, t. I/Petru Pauli Petri tar. I/Petrutius notarii Nycolai de Sulmona tar. I, gr. X/Idem Petrutius pro bonis condam Cole Angeli tar. I/Massius Marcelli gr. V, den. V/Berardus Catena g. VIIII ½ /Petrutius Nicolai de Armeli g. X/Idem
f. 12r
Petrutius pro nepote g. X/Ciccus Paulotii gr. VIIII, t. II/Antonius de Filimino tr. I, gr. XV/Giptius Oddoni gr. V/Heredes Masii Iohannis Amici gr. XII/Heredes Lutii de Alba g. XV/Vincentius Massicci de Bivitio pro uxori g. XII/Heredes Giptii Nicolai Palloni tr. I/Heredes Petri Benedicti Petri de Galiano gr. VII ½/Massiolus Cicci Petri de Castroveteri pro dote g. X/Iohannes Patri Melioris cum nepotibus tar. II ½ /Symon Oddonis nomine uxori star. I, gr. VII ½ ,Heredes Mozioni den. XVI/Heredes Iacchecte g. X/Antonius Iohannis Palloni tr. I/Rubeus Patri Leonis g. VII/Heredes Patri Iohannis Benedicti tr. I, g. VI et I/Angelus Tutii et Berardi Angeli Manabacce nomine uxoris g. X, den. XVI/Benedictus Zacthey tar. I, g. V ½ /Petrus Bartholomei Ioannis et Angelus Giptii tar. I/Leonardus Racusi nomine uxoris g. XV/Iohannes de Racuso cum herede Iohannis Petruczolo et aliis consortibus pro bonis que fuerunt Oddorisii Francisci de Galliano tar. III/Berardus dompni Fallocchi g. XV/Paulus Petri de Agello g. X/Heredes Iacobi Iannutii g. X, den. IIII/Berardus Benedicti de Colle g. V/Torcictus de Sancto Iohanne gr. XV/Heredes Macthei Benedicti g. X/Colecta Iohannis Benedicti g. X/
f. 12v
Nicolaus Landutii tar. I/Heredes Iohannis Roberti de Ozano pro bonis domine Imbrie tar. I/Giptius de Galiano pro emptionibus gr. XV/Mancinus Raymundi tent bona nobilia ipsius Bartolomei Iohannis de Rocca tar. III, gr. X/Silvester Nicolai Sanctori gr. X/Nicolaus Iacobi Mathei tar. I, gr. IIII/Giptius de Valleregia tar. I, gr. III, et/ et Benedictus de Joa pro tertia parte Castri Fucis unc. I/Abbas Galapsus cum nepotibus ac prepositus Celani pro/Casali Alastani modo est Curia exzemptioni facta pro /Habet dicta Curia in Sancta Cristina domum unam in qua/est montanum iuxta viam publicam/Habet etiam dicta Curia turrem sitam in Castro Agelli/Habet dicta Curia casarena sita in Pentoma que fuerunt condam Iacobi Benedicti Garofani iuxta Fucinum et/via publicam./Habet terram unam sitam in Marzone que fuit dicti Iacobi/iuxta viam quartaria viginti./
f. 13r
IN EODEM CASTRO AGELLI
Habet Curia domini Celani comitis ratione cambii facti cum Li/sio monaci de Iohanna de Collecta Sancte Marie auri uncias VIII./Item habet cabella baiulationis per eadem causa argenti unc. II:/ et tar. Duodecim tar. XII/Item habent ratione cambii facti cum Aprutino de Collecta Sancte Marie/Alastani auri unc. IIIIor/Debentes solvere adoham in dicto Castro Agelli sunt hii vide licet:/Angelus Nicolecte debet adohare gr. V/Petricca Nicolai de Armele pro terra empta a Cola Fello gr. V/Et teriam unias grani t. I/Massius Russus de Ozano tar. III (località ubicata a sud di Cerchio nei pressi della fonte S. Vito-Foglio 9- n.d.a.)/Matheus Pauli pro dote tar. I, gr. X/Ciccus de Alba pro dote tar. I, gr. X/Ventulus de Torpeliano gr. X (località sita a Nord del paese nelle località S. Silvestro, dove nell’antichità era ubicata la chiesa di S. Silvestro de Turpiliano, Capazzano [ nell’antichità esisteva la chiesa di S. Stefano de Caparzano] e S. Anastasia [ nell’antichita’ esisteva l’omonima chiesa ] e riportata all’attuale Foglio 6 del comune di Cerchio n.d.a.) /Antonia uxor condam Nicolai sir Petri gr. V/Giptius de Galiano pro terris emptis ab heredibus prepositi de Pentoma gr. VIIII/Rubeus Petracche pro certis bonis per ipsum acquisitis ge. X/Petrus Bartholomatii tr. I/Petrus Iohannis Catini pro terra empta per ipsum gr. III ½ /Massictus de Bivitio pro bonis acquisitis tr. I, gr. IIII ½ /Cola Berardoni gr. III et I/
f. 13v
Paulus Petri de Agello pro bonis acquisitis gr. X/Pucciacchius Iohannis Racusi cum fratribus gr. X/Nicolaus Iohannis Bartholomei cum fratre pro quodam prato sito in Cusano gr. II ½ /Idem Nicolaus pro certis terris et quadam vinea emptis a Be/rardo dompni Fallocchi gr. IIII/Iohannes Petri magistri Nicolay de Sancto Iohanne pro quodam pratp/sito in Cusano gr. II ½ /Meus de Scire cum Lutio de Rocchecta pro terris emptis a/Iovella tr. I/Berardus magistri Nicolai tenetur adohare omni anno tr. I/Debitales/Heredes Starnoni de Ozano tenetur facere in festo Na/tivitatis omni anno Curiae domini Celani comitis spallam/unam porcinam. Item tempore vindemmiarum de vino musto cup. I ( E’ la medesima sopra riportata località così come le seguenti sottoriportate località agli attuali fogli 8 e 9 del comune di Cerchio- n.d.a.) /Heredes Iohannis Roberti de Ozano tenetur facere omni anno quar/tam partem unius spalle porcine. Item gallinam quartam et tem/pore vindemiarum de vinum cuppam mediam/Masius Canis de Ozano tenetur facere in festo Nativitatis/omni anno longam unam porcinam./
f. 14r
Heredes Dominici Tautan de Ozano tenetur facere omnia n/no tempore vindemiarum de vino cuppam unam./Heredes Castruczi tenentur facere omni anno media spallam/porcinam mediam gallinam et tempore vindemiarum de musto cuppas II/Item in pecunia numerata tarenos IIII./Heredes Rogerii de Galiano facere omni anno/longam mediam porcinam in festo Nativitatis./Meus Celleris tenetur facere omni anno ipsi Curiae pro una/domo sita in Sancta Cristina denarios XII/Heredes de Fusco de Molesciano tenetur facere omni anno/in festo Nativitatis par unum spallam de porco. Item tempore/vindemiarum de vino musto cuppas II./Meus Martini tenetur facere omni anno pro una domo tarenum I/Heredes Leonardi de Cartio tenentur facere omni anno ipsi Curiae tarenum I/Heredes notari Mathei de Bivitio tenentur facere omni anno ipsi Curiae grana X./Butius Oddorisii tenetur facere omni anno ipsi Curiae denarios VII ½ /Heredes Carregie tenentur facere omni anno pro adoha denarios XVIIII./Heredes Nicolai Ciccaroni tenentur facere omni anno ipsi Curiae denarios XXV./Heredes Pasqualis Nicolai Russi de Patiano tenentur facere omni/anno in festo Nativitatis Domini spallam unam porcinam/et in pecunia numerata in epdem festo tarenos VIII.( Località posta a Sud Est di Cerchio e riportata all’attuale foglio 9 del Comune di Cerchio come Fosso S. Stefano. Qui, in questa località nacquero i due Pietro Capocitto, zio e nipote, entrambi eletti alla carica di Abati Generali dell’Ordine dei Celestini nel XVI secolo. In questa località esisteva l’antica chiesa di S. Stephano de Patiano n.d.r.)/
f. 14v
Heredes Iohannis Valentini de Agello tenentur facere ipsi Curiae omni/anno grana V./Salvator Pauli cum fratre grana II ½ ./Petrus Raymundi cum nepote gr. II ½ /Iacobus Dominici gr. II ½ /Heredes Martini de Molesciano gr. II ½ /Heredes Basilis gr. III ½ /Heredes Nicolai Mathei gr. III ½ /Heredes Pasquali et Berardi Iohannis gr. II ½ /Heredes Iohannis Barisani cum Matheo Thomasi gr. IIII/Petrus magistri Nicolai [de Sancto Iohanne Ozanello gr. XV]/Nicolaus Andree[de Sancto Iohanne Ozanello gr. XV]/Nicolaus Bartholomei[de Sancto Iohanne Ozanello gr. XV]/Giptius Oddoni[de Sancto Iohanne Ozanello gr. XV]/Heredes Landutii [de Sancto Iohanne Ozanello gr. XV]/Paulus Berardi[de Sancto Iohanne Ozanello gr. XV]/Pasqualis Marci Luce[de Sancto Iohanne Ozanello gr. XV]/Habet dicta Curia domini Celani comitis olivetum unum situm in/in partinentiis Agelli in contrata que vocatur Sancta Christina/quod incipitur ab olivis que fuerunt domini Brachiae/de Fucis sub via qua igitur Celanum et usque ad locum ubi/est per terminos lapideos terminatum et designatum./Item habet aliud olivetum supra viam quod incipitur a foxato et usque/ad olivas nonnullorum bonorum de Sancto Iohanne de Ozanello quod vocatur et prout et terminos lapideos terminatum./
f. 15r
IN CASTRO PISCINE CUM COLLE MELLIS
Habet Curia domini Celani comitis castrum seu for/tellitius in capite dicte terre Piscine./Habet Curia Celanbi comitis cabellam baiulati/onis que est omni anno in carlenis argenti uncie/decem et octo./Item habet dicta Curia silvam unam in costi de Palcareis/iuxta incultum./Item habet dicta Curia cabellam Sancte Marie omni anno que/est in carlenis argenti uncie viginti./Item habet ipsa Curia molendinum unum situm in forma acque fl/uminis ipsius castri prope pontem./Item vicendam unam sitam in partinentiis Leonis iuxta/viam a pede, et mediantibus duabus viis iuxta heredum/Iohannis de Folcaria versus Patianum, iuxta rem Sancti Nicolai de/Ferrato versus Piscinam in qua vicenda est domus/una cum recastro que domus vocatur La Maxaria, et est/dicta vicenda in totum quartaria quinquaginta sex cuppe IIIIor./Item habet Curia pratum unum situm in Carminanda ( toponimo ancora oggi attestato nelle mappe comunali del comune di Cerchio “ Carmenando” e riportato al Foglio 9 n.d.r.) iuxta/rem Sancte Sabine iuxta viam et rem heredum Berardiche de Casi/sano
f. 15v
quartaria tres cum dimidio./Item habet pratum unum situm ibidem iuxta rem Catalli Pa/uli de Beczano et iuxta rem Nanni Iannutii de Prezolo/quartaria tria et cuppas octo./Item habet pratum unum situm ibidem iuxta rema Sancte Sabine et rem/dicti Beradicche quartaria none./Item habet pratum unum situm in pratis de Leone pro medieta/te cum Petro de Meliore iuxta rem Sancte Anatolie et Iacobi/Riccardi pugilli tresdecim./Item dicta Curia habet pratum unum situm in pratis de Leone iuxta/rem Sancte Anatolie et iuxta rem Mathei Symeonis et Andree/Antonii de Laureto, cuppe undecim./Item habet pratum unum ibidem iuxta rem Petri Nicolai Silvestri/pugilli sex./Item habet ibidem pratum unum iuxta rem Cole Marci et rem Masii/Raymundi et iuxta rem notarii Antonii et Petri Nicolai Silvestri quarta/ria tria et cuppe undecim./Item habet vineam unam sitam in loco ubi dicitur Li Cappuczicti ( in un documento pergamenaceo conservato presso l’Archivio del monastero di Santa Scolastica di Subiaco del 29 aprile 1425 (vedi sopra) viene citato un certo “ Mey Cappucipti de Circulo” : questa località ha qualcosa in comune con la famiglia Capocitto del sopranominato casale di Patiano ? n.d.r.) iuxta viam et rem Nicolai Iohannis de Rocca de Piscina, quartaria IIIIor./Item habet dicta Curia in Piscina ultra flumen vineam unam/iuxta rem Antonii magistri Nicolai iuxta rem Nicolai Pauli Surdi/cuppe viginti./
f. 16r
Item habet ibidem pratum unum cum arboribus in ipso iuxta dictam vi/neam et iuxta ortum Curie cuppe sex./Item habet dicta Curia ortum situm ibidem iuxta flumen et iuxta dictum/pratum cuppe decem et octo./Item habet ibidem domum unam cum quodam orticello ex parte poste/riori iuxta dictam domum que domus est iuxta flumen./Item habet dicta Curia in Piscina stabulum unum iuxta rem/hospitalis./Item habet ortale iuxta rem dicti hospitalis a duabus parti/bus quod ortale vocatur Lu Ferragine. ( E’ la località nota in dialetto cerchiese “ L’ Furrain” ubicata a fianco di via della Fontanella: a Sud, dove esisteva l’antichissima chiesa di Santa Lucia. Molto probabilmente, tale località, doveva iniziare nei pressi dell’attuale via Foraggine n.d.r. ) /Item habet dicta Curia vineam unam sitam ultra Sanctum Petrum/de Apacziano iuxta viam puplicam, iuxta rem notarii Antonii/de Piscina et iuxta rem Nicolai Iohannis Iacobi, quartaria duo et cuppe II./Item habet dicta Curia patronatus ecclesie Sancti Marcelli situm in Leone/prope maxariam Curie./Item habet dicta Curia vineam unam sitam in Laterana quam/tenet ad partem Ianicella de Piscina de qua debet reddere/Curie medietatem vini musti et debet facere omni anno pollastrum/unum pro dicta vinea in festo Sancte Marie de mense agusti que/vinea est cuppe sex./Item Iordanus de Piscina tenet domum unam cum quodam/orti contiguo ipsi domui sitam in Fraginale iuxta rem Curie locatam
f. 16v
sibi pro Curia, pro qua domo et orto tenetur facere omni anni libram/unam de cera in candelis in festo Nativitatis Domini./Debentes solvere adoham in Castro Piscine sunt hii vide licet
Antoniu Fidanze tenetur adohare gr. X/Nicolaus Iohannis de Rocca cum fratre tar. III, gr. III et I/Gentilis domini Thome cum Ugone tar. III, gr. III, et I/Nicolaus Pauli Surdi tar. I, gr. XVIII ½ /Antoniis Butii tar. V, gr. XVII ½ /Heredes Pauli Mathei tar. I, gr. V/Antonius Cicci Mutii cum fratre tar. III, gr. XV/Antonius Nicolai de Agello cum fratre tar. V/Antonius Masii de Agello tar. V/Antonius Nicolai Christophani cum Antonio Masii pro Pheudo Frederici tar. I, den. XVI/Iannitella gr. II/Paulus Gentilis domini Thome pro dote uxori star. V/Antonius Gentilis Petri tar. V/Berardi Iacobi magistri Patri cum nepotibus tar. X. Gr. XI/Notarius Antonius Thome tar. I, gr. XVIII/Heredes Gentilis Laurentii tar. I, gr. X/Heredes Gentilis Laurentii cum heredibus Nicolai[….] cum heredibus Cicci Gualterutii de Gordiano Sicco tar. III, den. XXXII/Heredes Cabutii tar. I, gr. V/Heredes Gulielmi de Bisineo tar. III, gr. XV/Iohannes Caseus de Pesclo tar. III, gr. XV/
f. 17r
Notarius Rogerius de Gordiano tar. XI, gr. XV/Lutius Innamoratus de Avezano pro magistro Francisco ta. I, g. V/Nicolaus Iannutii Raymundi tar. II ½ /Nicolaus Gentilis cum Nicolao Quartelli tar. II ½ /Petrus Nicolai Silvestri gr. V/Palmerius de Beczano et Petrus Luce tenetur solvere pro bonis que fuerunt Buczarelli de Galliano ta. I, g. VII/Antonius Marcelli cum herede Gentilis Petri tenentur pro bonis dicti Buczarelli tar. I, gr. III/Marinus Nalli de Busso de Sulmona tar. V/Notarius Nicolaus de Cucullo tar. V/Ballutius de Gordiano tar. I/Domina Agatha de Sulmona tar. V/Ciccus Giptii tar. III, gr. VII/Antonius Marcelli tar. VI, gr. XIIII/Iacobus Thomae de Beczano tar. II/Heredes magistri Iacobi de Ravellis tar. VII ½ /Nanus Nicolai Iannutii de Perzolo tar. VII ½ /Butius Berardi de Agello gr. V/Heredes Berardi Candolfi gr. IIII/Heredes Iohannis de Felcaria g. IIII/Iohannes Nicolai de Pezolo cum Berardi Thomasi tenentur adohare pro certis bonis per ipsos tar. I, et gr. VII ½ /Andreas Antonii cum nepotibus pro una terra empta per ipsos gr. II ½ /Rubeus Pauli de Laureto tar. I/Debentes facere Curiae redditum in dicta Piscina sunt hii videlicet,/Heredes Masii Laurentii tenentur facere omni anno in festo/Nativitatis Domini de cera in candelis libram unam/
f. 17v
Tutius Catarine pro dote uxoris sue tenetur facere/ib dicto festo de cera in candelis libram mediam./Petrutius de Cartio tenetur facere omni anno nomine/dotis in festo Nativitatis Domini spallam unam de porco./Item tenetur facere operas tres, silicet una ad metendum/unam ad seminandum et unam in ara cum furca./Cola Iacobi cum consortibus tenetur facere in festo Nati/vitatis Domini longam unam de porco./Item operas tres, unam ad seminandum, unam ad metendum,/unam in ara cum furca./Antonius Iohannis Angeli tenetur facere de mense agusti/operam unam et mediam in ara./Item in festo Sancte Marie de agusto pullastrum unum./Berardus Angeli tenetur facere pro una gripta in/festo Sancte Marie par unum de pollastris./Berardus Thomasii tenetur facere in festo Sancte Marie de agusto/de ordeo cuppas decem cum dimidia./Iuctinus de Maccaniano tenetur facere in festo Nativi/tatis Domini de cera in candelis libras tres./Item in pecunia in moneta sollos vigintiquatuor./
f. 18r
Heredes Rigorii de Lonso tenetur facere de cera in ca/ndelis libras tres in dicto festo./Heredes Mathei Nicolecte tenentur facere cum Catallo de Lonso longam unam de porco./Heredes Iannocti tenentur facere ipsi Curiae de ordeo cu/ppas viginti./Petrus Mathei tenetur facere de cera in candelis uncias/novem./Iohannes Symeonis tenetur facere similiter de cera uncias novem./Iacobus Thomasii tenetur facere de ordeo cuppas/decem cum dimidia./Catallus Paulicti nomine uxoris tenetur facere/de ordeo cuppas septem et tertias alterius cuppe/ et spallam unam de porco./Butius Berardi de Agello tenetur facere in festo Na/tivitatis par unum de spallis de porco./Cola de Muzulo tenetur facere de cera in candelis libram I./Tutius de Squintrono et Palmerius de Beczano tenentur/facere pro medio pheudo Iutiii Mathei Angeli operam unam/et mediam ad seminandum, metendum et in ara./Idem Tutius tenetur facere omni anno in festo Nativitatis pro una/nuce sita in Valle Armelis daetulos tres./
f. 18v
IN CASTRO COLLI
Cola de Agello tenetur facere in dicto festo de candelis/de cera libram mediam./Cola de Marco tenetur facere in dicto festo de candelis/de cera libram mediam et de ordeo cuppas quatuor./Berardus notarii Thomasii tenetur facer sollos/de provisinis tres pro uno paro de speronis./Heredes Benedicti Bartholomei tenetur facere omni anno/duos denarios provisinorum./Berardus Benedicti cum Cicchino de Cansano tenetur/facere in festo Sancte Marie de agusto pollastrum unum./Iaocobus Riccardi tenetur in festo Nativitatis Domini facere/de cera in candelis libram unam et uncias decem cum dimidia./Heredes Angelutii de Felcaria tenentur facere in dicto/festo de candelis uncias quatuor cum dimidia./Meus Vitalis tenetur facere in dicto festo de cera uncias/quatuor cum dimidia./Silvester Nicolai Siluri nomine uxoris tenetur facere in dicto festo uncias III./
f. 19r
Angela Nicolai Iohannis Amodei tenetur facere de cera in dicto fe/sto uncias duas./Heredes Petri de Marco tenetur facere in dicto festo/de cera uncias tres./Margarita Berardi Iacobi Egidii tenetur facere in dicto festo/de cera uncias quatuor./Thomassictus pro bonis Iohannis de Aquila tenetur facere/in dicto festo de cera unciam unam./Similiter Angelus Clementis tenetur facere de candelis/de cera libram mediam./Iohannes de Sicinalio cum Landicto tenetur facere in dicto/festo de cera uncias quatuor cum dimidia./Heredes Iohannis dompni Silvestri tenetur facere in dicto/festo de cera uncias duas./Heredes Gullielmi de Cansano tenetur facere in dicto festo/de candelis libram unam./Et cum heredibus Iacobi de Chirico facere/in festo Carnisbruni gallinam unam./Heredes Pauli Rogerii cum herede tenentur facere/in festo Sancte Marie de agusto de ordeo quartarium unum./Item par unum de spalli set de cera in candelis in festo/Nativitatis Domini libram mediam./
f. 19v
Heredes Angeli de Capurussu tenetur facere in festo Na/tivitatis Domini de cera in candelis libram unam./Nicolaus Butii de Molexiano nomine Casie uxoris sue te/netur facere in festo Nativitatis Domini spallam unam de porco./Item ordeo in festo Sancte Marie de agusto cuppas septem/et tertias duas alterius cuppe./Cola Iacobi Masii tenetur facere in festo Sancter Marie de/ordeo cuppas septem./Heredes Laydi tenetur facere in dicto festo de ordeo/cuppas tres./Stephanus Berardi cum fratre de Asclo tenetur facere in/festo Nativitatis Domini de cera in candelis libram m/ediam./Item omnes et singuli nomine Castri Piscine et casalium eius te/nentur omni anno portare salmam unam de lignis ad Ca/strum Piscine a festo Omnium Sanctorum usque ad festum Nativi/tatis Domini ad voluntatem domini ipsius castri vel castel/lani esistente in castro seu alterius officialis cuius/cumque./
f. 20r
Antonius Marcelli cum Cicco Giptii tar. V de adoha/Idem Antonius Marcelli pro pheudo Tibaldi tar. V. gr. V/Gentilis domini Thomasii cum heredibus Ugonis pro pheudo/domine Gemme de Casale tar. V/Idem Gentilis cum dictis heredibus pro pheudo domine Gemme Lutii tar. V/Idem Gentilis cum dictis heredibus pro pheudo Tibaldi tar. V, et gran. Quinque/Nicolaus Iohannis de Rocca pro pheudo Iohannis de Novaria taren. quinque/Antonius Mey pro patrimonio tar. III, gran. III etc./Idem Antonius pro pheudo notarii Beradi de Colle tar. X/Idem Antonius pro pheudo Ciccarelli tarenum unum./
f. 21r
IN CASTRO TERRE NOVE HABET DICTA CURIA INFRASCRIPTA BONA, VIDELICET
Heredes Boneinsenge tenetur facere in festo Nati/vitatis Domini de cera in candelis libram unam./Heredes Nicolai Ciccaroni tenetru facere in dicto fe/sto pro pheudi Petri Candulfi in argento tarenum unum/cum dimidio./Viri nobiles Raymundus et Benedictus Beradi de Ioha habue/runt, tenuerunt et poxiderunt tertiam partem Castri Fucis de Iustitiarato Aprutii ultra flumen Pisca/rie consistentem in vaxallis, demaniis, collectis et/redditibus aliis quibuscumque qui Raymundus habebat pro/parte sua de mense agusti pro collecta Sancte Marie/ducatos de auri viginti et pro cabella baiulationis/omni anno de mense ianuarii in argento unciam unam sexa/ginta carlenos pro uncia qualibet cimputatis et tarenos sex qui/quidem Raymundus mortuus et superstitit sibi domina Nicolasia/filia legitima naturalis que domina vendidit et ex/ea venditionis dedit magnifico Rogerio Celani comi/ti omnia et singula iura sibi expectantia in dictis/bonis prout supra narratum est./Insuper supradictus Benedictus dictus Monachus/sicut Domino placuit estitit vita functus, superstitit sibi Loy/sio filio suo legitimo et naturali qui Lisius permutavit ex
f. 21v
eadem ea permutationis dedit, tradidit, et assignavit eidem/comiti Celani aliam medietatem vaxallorum, collectarum, re/ddituum et aliorum iurium quorumcumque et specialiter ducatos vi/ginti de auro de collecta Sancte Marie et de cabella baiu/lationis in carlenis argenti unciam unam et tarenos sex/tempore ut supra, qui quidem comes dedit eidem Loysio/certa bona stabilia pheudalia sistenti in dicto Castro que/quidem dictam tertiam partem dicti Castri predicti Raymundus et Ben/edictus Monachus tenebat in pheudum a dicto Celani comite […]”.
7) BERARDI M.R. : “ Poteri centrali op.cit. “ ,p. 196.
8) BERARDI M.R. : “ Poteri centrali op.cit. “ Le chiese citate sono : S. Martino di Molesciano;S. Lorenzo di Preturo, S. Stefano di Carczano(sicuramente Capeczano, l’odierna Cabazano n.d.a.), S. Giusta di Buvizio, S. Agnese di Buvizio, S. Giovanni di Ozanello, S. Croce di Alafrano, S. Bartolomeo di Cerchio, S. Andrea di Preturo, S. Silvestro di Agello o Aielli “, p. 187.
9) EUBEL C.: “ HIERARCHIA CATHOLICA/MEDII AEVI/SIVE/SUMMORUM PONTIFICUM, S.R.E. CARDINALIUM,/ECCLESIARUM ANTISTITUM/SERIES/AB ANNO 1198 USQUE AD ANNUM 1431 PERDUCTA/E DOCUMENTIS TABULARII PRAESERTIM VATICANI/COLLECTA, DIGESTA, EDITA/PER/CONRADUM EUBEL, S. THEOL. DOCT./PRD. MIN. CONV. DEFINITOREM GENERALEM/OLIM APOSTOLICUM APUD S. PETRUM DE URBE POENITENTIARUM/”EDITIO ALTERA./MONASTERII MDCCCXIII./SUMPTIBUS ET TYPIS LIBRARIAE REGENSBERGIANAE .,p. 90.
10) EUBEL C. : “ HIERACHIA CATHOLICA/MEDII AEVI/SIVE/SUMMORUM PONTIFICUM, S.R.E. CARDINALIUM,/ECCLESIARUM ANTISTITUM/ SERIES/AB ANNO 1431 USQUE AD ANNUM 1503 PERDUCTA/ E DOCUMENTIS TABULARII PRAESERTIM VATIVCANI/COLLECTA, DIGESTA, EDITA/PER/CONRADUM EUBEL, S. THEOL. DOCT./ORD. MIN. CONV. DEFINITOREM GENERALEM/OLIM APOSTOLICUM APUS S. PETRUM DE URBE POENITENTIARIUM/EDITIO ALTERA./MONASTERII MDCCCXIV./SUMPTIBUS ET TYPIS LIBRARIAE REGENSBERGIANAE, p.88.
11) “[…] Nell’archivio dei Colonnesi in Roma osservato abbiamo una cara di procura fatta ad un cittadino Romano co i Sindaci di Cerchio per giurare fedeltà nell’A.[nn]o 1425 a Odoardo Colonna[…]” Corsignani P.: “ Reggia Marsicana ovvero memorie topografico-storiche ecc.”, in Napoli M.DCC.XXXVIII. Presso il Parrino,p. 643,Lib. III – Parte I.
12) “ Subiaco. Trasferito a Roma l’Archivio dei Colonna. Subiaco. Trasferito da Roma lì archivio dfei Colonna. E’ stato completato il trasferimento dell’archiivio storico della famiglia Colonna. Dall’antico palazzo nobiliare di piazza Santi Apostoli a Roma è stato portato al monastero benedettino di Santa Scolastica, a Subiaco. La biblioteca statale del monastero benederrino già custodisce oltre 120 mila volumi. Tra i sioi “gioielli” il primo libro stampato in Italia nel 1465. Il trasferimento, contro il quale si era pronunciato il “gruppo dei Romanisti”, è stato eseguito sulla base della convenzione stipulata il 13 dicembre tra la famiglia Colonna, la Sopritendenza degli archivi di Stato del Lazio e la direzione della biblioteca del monastero. Si tratta di 3.500 pergamene e di 7000 manoscritti relativi all’amministrazione dei Colonna in tutta Italia. Il materiale, che resta di proprietà della famiglia, verrà riordinato e catalogato. Sarà consultabile da luglio.” Corriere della Sera, 18 aprile 1996.
13) E’ forse l’odierno cognome Carusoni?
14) E’ il giudice, o un suo parente, “Masio Janitelle de Agello” che compare nell’atto della “Corporalis possessio Prepositura Ecc[lesi]a S[anc]te Maria de Luco capita p[er] pro[curato]res Mag[istri] Petri de Agello, cui p[er] D. Abb(at]es Cassine(ensi)s collata fuerat[…]” redatta il 15 gennaio 1426. Chissà se questi erano congiunti del vescovo aiellese Pietro Jannitella, eletto vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi il 13 agosto 1427? (vedi in seguito).
15) Cognome ancora oggi attestato a Cerchio ovviamente con la forma attuale di Tucceri.
16)E’ il nostro sicuramente un antenato di un certo “ Butio Martellozzi” che compare in un atto notarile dell’Archivio d’Amore Fracassi di Cerchio ( AQ ) (al momento in mia visione) relativo al 15 Agosto 1484 dove il conte di Celano Antonio Piccolomini vende al Nostro alcuni terreni :” Butio Martellozzi di Cerchi compra all’Ecc .[ellentissimo] Sig.[no]re Ant.[oni]o Duca di Amalfi e Conte di Celano l’infrascritti terreni ricaduti à Corte per la morte senza heredu di Cola di Gregorio Mercolini di Sulmona cioe 1 terra in Campoli conf. Ceccho di Giacomo Risaoni, Ant.[oni]o d’amore e marco Varanelli 2 terra ibid[em] conf.[ino] Daniele di Giacono di filippo e la via a due lati 3 terra ibid[em] conf.[ino] Stefano pietro Cicchi, e […] la via a due lati 4 terra alle cortine Conf[ino] Gio:[vanni] Iaocobacci Colama[…] e la via da Capo 5 terra in Fontiano conf.[ino] Cola di Missere […]grosso e, Cola Pietrociccho 6 Prato a Campoli Conf.[ino] Meo Angeloni e la via 7 terra in Capezano conf.[ino] S.[anta] Sabina da due lati et Antonio Gerardini 8 terra alle cortine conf.[ino] Colantonio Pietro di Marino e S. Andrea 9 Prato in Valle maiano conf.[ino] Macteo Varanelli[…] 10 terra in Colle Cerino con li suoi confini il tutto è stato venduto per prezzo di ducati cento li 15 ag.[ost]o 1485” ( è il 15 agosto 1484 e non come erroneamente riporta nel dorso dell’atto in parola il trascrittore come inequivocabilmente si evince nel nostro documento: “ Datum In Castello n[ost]ro Celani die XV Augusti MCCCCLXXXIV “. Amiconi F.:” Storia di Cerchio dalle origini al ‘400”, Museo Civico di Cerchio, Quaderno n. 2, Anno I, 1998.
17) E’ sicuramente lo stesso personaggio attore di un atto notarile dell’Archivio d’Amore Fracassi di Cerchio ( attualmente in mia visione) del 3 Dicembre 1430: “Gio.[vanni] di Pietro Megliore fa donatione di tutti li suoi beni a Bartholomeo Coletta Martellozzi di Cerchio per gli atti di Amico Pacentro Si Silvestro Cerchi li 3 x[decem]bris 1430”. Amiconi F.:” Storia di Cerchio dalle op.cit.”.
18) E’ sicuramente lo stesso personaggio che compare in un atto notarile dell’Archivio d’Amore Fracassi di Cerchio ( attualmente in mia visione ) del 21 maggio 1427: “ Istromento di Notar Silvio di Andrea del Colle Armele 1428 ( così è datato erroneamente sul dorso, dal trascrittore, del nostro documento) Istromento nel quale si divide l’heredità di Donna Rota di Berardo Vendecta del Colle cioe la meta si da à Giacomo del Colle, e l’altra meta sia di Bartholomeo Colecta Martello di Cerchi per gli atti di Ceccho di Mastro di Nicola Cappelli di Subiaco li 21 maggio 1428 ( data errata)”. Nel 1428 viene stilato un susseguente atto notarile sempre dell’Archivio D’Amore Fracassi di Cerchio ( sempre attualmente in mia visione) avente protagonisti gli stessi attori e la medesima eredità:” Sentenza data da due eletti cioe da Lelio di Vito e Berardo di[..]di Nicola ambedue del Colle Armele a sopra la lite della heredità[….]di Rita di Berardo di Benedecto del Colle[…] che si divida in due parti[…] una che sia di Giacomo del Colle sudetto l’altra parte di Bartolomeo Martelli di Cerchi per gli atti di Ceccho di Mastro Nicola Cappelli li 16 Giugno 1428”. Amiconi F.: “ Storia di Cerchio dalle op.cit”.
19) Sicuramente è un appartenente al clan dei Nostri Pietro Capocitto il Vecchio e Pietro Capocitto il Giovane, zio e nipote, entrambi arrivati alla suprema carica di abate generale dell’Ordine dei celestini addirittura, il Giovane, fu eletto per ben quattro volte (vedi in seguito).
20) Rubeo V. : “ Covella, contessa di Celano sulla storia di una nobildonna di Celano nella Marsica del Quattrocento”, Edizioni Kirke Cerchio-Avezzano, 2015, pag. 89, nota 66:” Al 29 aprile 1425 risale un omaggio presentato alla giovane coppia di coniugi dalla terra di Agello e Circulo ( gli odierni Aielli e Cerchio ) (AC, III BB, 56, 2015 ).
21) GROHMANN A.: “ LE FIERE DEL REGNO DI NAPOLI IN ETA’ ARAGONESE ”, Napoli, nella sede dell’Istituto MXMLXIX, Istituto Italiano per gli studi storici. Vi era 1 operatore di Albe; 1 di Artucchio ( Ortucchio n.d.r.); 5 di Avezzano;1 di Castello di Fiume; 3 di Celano, 1 di Cerchio; 1 di Colle Armeo ( Collarmele n.d.r.); 2 di Curcumello; 2 di Gioia dei Marsi; 1 di La Scolcula ( Scurcola Marsicana n.d.r.); 2 di Magliano ( Magliano dei Marsi n.d.r.); 2 di Morino; 2 di Ortona ( Ortona dei Marsi n.d.r. ); 1 di Pereto; 18 di Piscina; 24 di Rocca di Mezzo; 6 di Rovere; 8 di San Sebastiano; 14 di Tagliacozzo; 2 di Verery ( Venere?); 1 di Verrecchie, pp. 109-112.
22) GROHMANN A. :” LE FIERE op.cit. “ Erano presenti i seguenti mercanti : 6 di Aschi; 5 di Bisegna; 3 di Celano; 5 di Gioia ( Gioia dei Marsi n.d.r. ); 2 di Ortona ( Ortona dei Marsi n.d.r. ); 2 di Ortucchia ( Ortucchio n.d.r. ); 4 di Pescasseroli; 4 di Pescina; 1 di Rocca di Mezzo; 9 di San Sebastinao; Scuncula ( Scurcola marsicana n.d.a.) 1 e 2 di Tagliacozzo, pp. 114 e 115.
23) GROHMANN A. : “ LE FIERE op.cit.”. Celano 9.000 pecore, senza altri animali grossi; Aiello ( del Contado di Celano) 6.000 pecore, senza altri animali grossi; Novindolo ( è Ovindoli n.d.r.) 10.000 pecore, senza altri animali grossi ; Roboto ( è Rovere n.d.a.) 4.000 pecore, senza altri animali grossi ; Bisegna 4.000 pecore, senza altri animali grossi ; Collarmele 6.000 pecore, senza altri animali grossi ; Cirglio ( è Cerchio ; sicuramente è da leggersi “Cirghio” n.d.r.) 14.000 pecore, senza altri animali grossi;San Sebastiano 2.000 pecore, senza altri animali grossi”; Leze ( è Lecce nei Marsi n.d.r.) 5.000 pecore, senza altri animali grossi; Pisania ( è Pescina n.d.r.) 10.000 pecore, ultra li animali grossi”; Aschi ( sic ) pecore, ultra li animali grossi; Tagliacozzo 12.000 pecore circha; Albe 15.000 percore circa, ultra li animalio grossi; Magliano ( è Magliano dei Marsi n.d.r.) 9.000, ultra li animali grossi, p. 126.
24) PAPPONETTI G. : “ “ La Provincia dell’umanesimo. Saggio e note sulmonesi”, Tipografia Labor, Sulmona MCMLXXXVI. In quel lasso di tempo un altro cerchiese viveva in Sulmona infatti, in un documento del 1528 apprendiamo[…]1528 aprile 6 aprile Sulmona/L’organo di governo ( Sindaco, Consilium et Universitas ) della città di Sulmona, ricevuta una supplica, concede in perpetuo al concittadino, Giacomo di Clemente di Cerchio la potestà di chiudere una porzione della via cieca nei pressi delle mura della città nella località lo largo de Sancto Nicola e di costruire un muro sino all’orticello di Luigi di don Pitotta[…]”, Francesco Mottola “ Le cancellerie delle università meridionali. Gli esempi di Penne e di Sulmona ( secc. XV-XVI )”, Mario Consedo, Arti Grafiche, Lavello (PZ), 2005.
25) PICCIONI L.: “ Marsica vicereale Territorio, economia e società tra Cinque e Settecento” , Aleph editrice, LCL Stampe litografiche, 1999 ristampa, pp.150-151, nelle tabelle riassuntive dei capi ovini dei locati marsicani registrati nella Dogana di Foggia apprendiamo che nel 1601, fra i vari capi ovini dei paesi marsicani erano presenti anche quelli di Aielli con 6870 capi; di Collarmele 5.600 e di Cerchio 1.210; nel 1619 i capi ovini di Aielli erano 3.600 e quelli di Cerchio erano 5.020; nel 1655 vi erano presenti di Aielli 1.260 capi e di Cerchio 1.920 e, nel 1657 ( è l’anno dell’inizio della peste del 1657-1658: in tutto il territorio marsicano 4080 furono i morti. A Cerchio ne perrirono 254 ) di Aielli vi erano 860 capi e di Cerchio 670. Inoltre attraverso i capitoli della zafferano emanati il 16 settembre 1569 per ordine del “regio Dohanero della Dogana della città dell’Aquila ”, Giovanni Battista de Antonellis, e banditi in tutti i centri dell’aquilano dove tale preziosa spezia veniva coltivata apprendiamo che anche i paesi di Cerchio, Aielli e Collarmele facevano parte dei “ maggiorj castella della provincia” dove veniva coltivato lo zafferano : “ Adi 4 di Ott(obr)e 69 ( è l’anno 1569 n.d.r. ) fo bandito in Ayellj in la piaza pub.(blic)a in pr ( è cancellato n.d.r.) ava(n)te la chiesa/della Trinità in pr(esen)za di biascio di macerola, Jac.(com)o di Jacobuccio, Matteo/di paolo amico don Ve(n)turino p(re)posto di d(et)ta chiesa notar aless(andr)o bar/tenicchio tuttj di d(et)ta t(er)ra et moltj altrj/fo bandito in Circhi in la piaza solita ava(n)te la porta in p(rese)ntia di/Terre(n)tio de petri de Ciccho, lorito d’Amore, Cipriano de Varanello/Jo:(van)ber(ardi)no de Micuti tuttj di d(et)ta terra, et notar Gio(vann)i Cayo di/Magliano, et Cola petruccio d’Amore Massaro/fo bandito in lo colle Armele in la piazza solita ava(n)te la porta/in p(rese)ntia di Tomeo di Perascia massaro Aluisci di Jan(n)otto Cam(erleng)o,/Fr Biascio de ranallo. Pietro de Ciaglia, Giovan(n)i d’Ales(sandr)o et/Don Julio de Pasqalone tuttj di d(et)ta t(er)ra et moltj altrj (…)” Archivio di Stato dell’Aquila. Sicuramente per dar più voce alla classe mercantile cerchiese, il 19 Maggio 1633, con Real Rescritto di re Filippo d’Aragona, venne istituita la “ Fiera in Nome di Maria” che ancora oggi – ininterrottamente- si svolge la prima domenica dopo l’8 settembre per le strade del centro urbano di Cerchio. All’inizio la fiera, come si ricorda nella Relazione di Donato Gallarano per gli anni 1718-1723, si svolgeva nei pressi della chiesa di Santa Maria di Piede Ponte (attuale chiesa cimiteriale): “[…] Nella Domenica tra l’ottava della vergine nella cappella di S. Maria Piè di Ponte, dove portano a vendere ogni sorta d’animali grossi e minuti, vasi di creta, frutti e verdume e dura un giorno[…]”,cfr. MANNA 1984. In seguito, con atto del Consiglio Comunale del 14 aprile 1882 (era sindaco, carica che ricoprì per ben 35 anni, Venanzio D’Amore Fracassi, “il Giovane”, 1856-1940) venne trasferita, per motivi di ordine pubblico ( accadde, anche, purtroppo, un fratricidio) dentro l’abitato del paese.
26) COZZETTO F.: “ MEZZOGIORNO E DEMOGRAFIA NEL XV SECOLO “, Rubettino Editore, 1986, pp.88-89. E’ la pubblicazione integrale del “ LIBER FOCORUM REGNI NEAPOLIS “ conservato presso la Biblioteca Civica Berio di Genova.
27) A seguito del matrimonio con Maria D’Aragona (1440-1460), figlia natuale del re di Napoli Ferrante I d’Aragona avvenuto nel 1458, Antonio Todeschini Piccolomini assunse anche il cognome D’Aragona. Divenuto vedovo nel 1460, si unì nuovamente in matrimonio con Donna Maria Marzano d’Aragona, figlia di Marino Marzano d’Aragona, I Principe di Rossano, 3° Duca di Sessa, I Duca di Squillace e di Eleonora d’Aragona. Antonio Todeschini Piccolomini d’Aragona fu il I° Duca diAmalfi (1461), Marchese di Capestrano (12-II-1463),I° Marchese di Delicato(1463), Conte di Celano e di Gagliano (12-ii-1463), Barone di Balzorano, Piscina e di Carapelle (12-II-1463), Barone di Scafati (1465), Signore di Ravello, Minori e di Tramonti (1461), Signore di Castiglione della Pescaia e dell’Isola del Giglio ( 1460-1464), Signore di Senigallia e Vicario Pontificio di Mondavio (1462-1474),Signore di San Sebastiano, Sperone d’Asino, Civita Marsa, Caspio, Castel d’Agra, Sangro, Santo Stefano, Balascio, Rocca Collarmele, Castel di ieri, Castel Nuovo, Valle Custa, Valle Fermo, San Ruffino, San Benedetto dei Marsi, Lecce dei Marsi, Gioia dei Marsi, Goriano, Bisegna, Cocullo, Venere, Morra, Collelongo,Rocca d’Arce, Vittorio, Brittori, Farnola, Valle Malleverno, Vestigio, Antrosano, Bifaro, Berticara, Malignano, Crete, Mucciano, Iura, Carpineto, Fonti delli Casali, Modola, Troia, Nonteverde, Melodia,Campera, Poggio degli Atti, Pescio di Roccaserra, San Grigio, San Michele, Vestatio, Valle Vaccaia, Morelli, Roccacagliata, Casa Castarma, Francorputa, Abula, Piano, Camorra, Cologno, Secinaro, Subequo, Ajelli, Celle, Colle, Carsoli, Intramunti, Torre dei passeri, San Potito, Ovindoli, Rovare, Rocca di mezzo, Santa Eugenia, Rocca Santo Stefano, Foce, Cerchio ed Ortucchio ( 12-II-1463), Signore di Aschi( 1464), Signore di Castel del Conte ed Ofena ( 1478 ), Gran Giustiziere del regno di Napoli ( 1458), Patrizio di Siena, Patrizio Napoletano del Sedile del Nido (1480), Governatore di Castel Sant’Angelo (1458-1464), Governatore degli Abruzzi ( 1480 ), cfr. Il sito web www.aragon10.free-online.co.uk/cilia%20corte-legacy/3477.htm.Il fratello, Francesco Nanni Todeschini ( 1431-1503) fu eletto al soglio pontificio con il nome di Pio III, il 22 settembre 1503 e morì il 18 ottobre dello stesso anno, dopo appena ventisei giorni di pontificato, cfr. Il sito web www.aragon10.free-online.co.uk/cilia%201a%20corte-legacy/4820.htm. Quest’ultimo secondo quanto riportato Nel Grande Dizionario Enciclopedico UTET (Torino 1976, p. 629), era nato a Siena nel 1440 ca. e morto a Roma nel 1503. Nel sito web “htt.it.wikipedia.org./wiki/Francesco_Nanni_Todeschini Piccoloimini, invece risulta nato a Siena il 9 Maggio 1439 e deceduto in Roma il 18 Ottobre 1503.
28) Presso la sezione di Avezzano dell’Archivio di Stato dell’Aquila si conserva, proveniente dal convento francescano di Balsorano, un incunabolo stampato a Venezia, da Michele Cenobio, il 28 gennaio 1495, dedicato da Beradino Gadolo proprio al cardinale Francesco Todeschini Piccolomini dal titolo “ Liber Vite. Biblia cum glossi ordinarijs:et interli/nearibus:excerptis ex omnibus fer/ne Ecclesie sancte doctoribus:/simulque cum expositione/Nicolae de lyra:et/cum concordan/tiji in margine”, cfr. Testimonianze preziose, capolavori sacri svelano la loro storia” catologo dell’omonima mostra ( a cura di FLAVIA DE SANCTIS E ANTONELLA SARAGOSA), Stampa GTE. L’Aquila, 2008.
29) GROHMANN A. : “ LE FIERE op.cit.”, p.84.La citazione si trova in ANTINORI SEC. XVIII, vol. XVI, p. 595.
30) Purtroppo, se questi erano i buoni proponimenti dei nostri antenati a nulla valsero: infatti, la popolazione di Cerchio nel 1625 contava 192 fuochi ( Biblioteca Apostolica, Barb. Lat. 4415, f. 10 ). Dal 14 Ottobre 1656 al 17 Agosto 1657, la comunità fu flagellata da un’epidemia di peste. In quel tragico frangente morirono 254 persone, quasi la metà della popolazione che al 19 dicembre 1657 ammontava a 330 anime. Adesso, ogni fuoco, se la numerazione delle famiglie è rimasta immutata a quella del 1625, è composto da poco più di tre persone, cfr. Archivio Diocesi dei Marsi, D/108/38 e B/57/162. In quest’ultimo documento, purtroppo, non vengono riportati i nomi dei paesi che furono attaccati violentemente dalla peste. Sicuramente nell’Archivio diocesano dovevano trovarsi documenti coevi dove venivano riportati i nomi dei paesi con il relativo numero dei decessi, come chiaramente si evince dal preciso numero dei morti appestati riportato nel nostro citato documento: 4080 è il totale della somma scaturita dai dati dei 13 addendi di altrettanti anonimi paesi marsicani. Vedi anche MANNA G. :” VERTENZA CERCHIO-COLLARMELE PARERE Gennaro Manna”, AQUILA TIP. SOCIALE DI A. ELISEO 1894.
31) In onore di tale importante documento ogni 24 agosto si svolge a Cerchio “ Il Corteo storico Bulla Indulgentiraum” arrivato quest’anno alla 14^ edizione.La citata “Bulla” rappresenta per la comunità religiosa cerchiese il più antico documento dove si menziona la chiesa di S. Bartolomeo. In questa chiesa restaurata nel 1986 si possono ammirare il portale quattro-cinquecentesco in pietra (sagacemente restaurato nel mese di giugno 2001 dalla restauratrice Anna Grazia Grassi ), tre statue in terracotta policroma ( bisognose di un sapiente restauro ) collocate sull’altare e raffiguranti l’apostolo San Bartolomeo, la Madonna con Bambino in braccio benedicente ( Madonna della Misericordia) e S. Antonio di Padova ( scuola Abruzzese secc. XV-XVI ), due statue lignee di Sant’Antonio di Padova ( sec. XIX ) e la Madonna della Misericordia ( sec. XIX ) e i moderni dipinti della Via Crucis opera di valentissimi maestri di Scuola Abruzzese e Laziale ( Carlo Colonnello, Donatella Marchini, Nazzareno Cugurra, Marcello Ercole, Luciano Primavera, Miro Bonaccorsi, Gabriele Petrarca, Manlio Sarra, Alfredo Di Bacco, Gino Amicuzzi, Quirino Cervelli, Pasquale Di Fabio, Nino Gagliardi, Dante Simone ) collocati in chiesa con una solenne cerimonia avvenuta il 28 maggio 1987 alla presenza di Monsignor Pietro Garlato, presidente della Pontificia Commissione per l’Arte Sacra in Italia e dell’avv. Benito Bove, presidente della Camera di Commercio dell’Aquila. Ad un’altra chiesa ubicata nel territorio di Cerchio, San Pietro in Filimini ( toponimo ancora oggi attestato nelle mappe comunali come Frimini) fu inviata, il 12 Luglio 1295, da 12 vescovi riuniti in Anagni, città natale del menzionato papa Caetani (Bonifacio VIII) , nell’anno primo del suo pontificato, la prima “ Bulla Indulgentiarum”inviata alla nostra comunità. Entrambi el due citata “Bulle” si conservano nell’Archivio della Diocesi dei Marsi in Avezzano. Vedi BERARDI M.R. : “ Una diocesi di confine op.cit.”
32) Il suo nominativo compare nella targhetta posta nel verso della citata croce grande astile d’argento commissionata nel 1484 da tre committenti cerchiesi per la loro chiesa matrice intitolata alla Santissima Annunziata.
33) AMICONI F.-DI DOMENICO M.: “ BONIFACIO VIII E LE Bolle delle Indulgenze Abruzzesi L’AQUILA 1294- CERCHIO 1300 ”,D’ABRUZZO LIBRI EDIZIONI MENABO, CENTRO Stampa Filerete-Roma, 2000; BERARDI M.R. : “Una diocesi di confine op.cit.”
34) Anche se ad onor del vero, attraverso le cronotassi dei vescovi della diocesi dei Marsi, della diocesi di Lamezia Terme e della diocesi di Sessa Aurunca tratte da “ Wikipedia, l’encicopledia libera “ abbiamo appreso il cognome del Nostro e la varie elezioni alle tre sopramenzionate diocesi. Dalla cronotassi dei vescovi della diocesi di Avezzano abbiamo appreso che il Nostro Gentile si chiama, come inequivocabilmente si legge, Gentile Maccafani vescovo dall’anno 1385 all’anno 1398 epoca in cui fu traslato alla diocesi di Lamezia Terme; dalla cronotassi dell’elenco dei vescovi della diocesi di Lamezia Terme veniamo alla conoscenza che Gentile Maccafani fu vescovo di tale diocesi dall’anno 1398 all’anno 1417 anno in cui il Nostro fu, ancora una volta, trasferito a tale diocesi che la resse fino all’anno 1425. Al momento non sappiamo dove gli estensori delle summenzionate cronotassi abbiano attinto tali notizie: sono le uniche notizie dove si apprende il cognome del Nostro Gentile d’Aielli. A meno che non abbiano fatto proprio quanto Muzio Febonio nella sua “ Historia Marsorum “ riporta a pag. 35: “ XLIII/ANGELO, figlio del Notaio Antonio Maccafani, di nobile famiglia di Pereto, primo di questa famiglia è annoverato fra i Vescovi dei Marsi, mentre è stato terzo di quelli che tennero la Sede. Siamo, infatti, persuasi che Gentile e Salvato da Pereto appartennero pure a questa famiglia [ Maccafani n.d.r.], se è vero che in quel tempo, secondo una costumanza dei Longobardi, il nome alla famiglia veniva dato dalla giuridizione e dal dominio dei luoghi; e il borgo predetto era sotto il loro dominio dal 1310 (…)”[ ‘Storia dei Marsi” libro secondo testo latino e traduzione di Pietro Smarrelli, De Cristofaro Editore Roma, 1988].Secondo noi è troppo semplicistica questa affermazione peraltro non suffragata da alcun documento se non da quella laconica affermazione riportata dal Febonio.Non si capisce perché il Febonio quando descrive al numero XXXVI il Nostro Gentile non specifica meglio che Gentile di Aielli altri non era che Gentile Maccafani da Pereto. Perché deve aspettare il numero XLIII cioè quando descrive Angelo Maccafani per affermare” Siamo, infatti persuasi che Gentile e Salvato da Pereto appartennero pure a questa famiglia “. Da dove proviene questa sua persuasione?
Attraverso la recente pubblicazione dell’inedito manoscritto di Gian Maria Maccafani dal titolo : COMPENDIOLO DELLA VITA DEI VESCOVI MACCAFANI “ [ scritta fra il 1785 ed il 1793 anno di morte del citato Maccafani] e data alle stampe, con lo stesso titolo, nel Quaderno N. 105 del Museo Civico di Cerchio, Anno XIII,a cura di Massimo Basilici, apprendiamo :”[…] Da tal riguardevole Famiglia ne discese Monsig:r Gentile Maccafani, e/fu il primo Vescovo che essa vanti. Il di lui Genitore fu Bartolo/meo Maccafani Barone di Pereto. Per fare apprendere un educazione/al Giovinetto proporzionata al di lui grado fu dal Genitore mandato/ in Roma per fargli apprendere le lettere. Seppe così ben/corrispondere alle speranze del Genitore, che avendo, non senza/molto profitto, compiuta la carriera degli studi si stabilì in Roma,/dove fece conoscere i suoi non ordinarj talenti. Nell’anno 1385/essendo restata vacante la Chiesa Vescovile dei Marsi per morte del/Vescovo Giacomo il Sommo pontefice Urbano sesto volendo/provedere d’idoneo Pastore quella vedova Chiesa rivolse lo sguardo/al Nostro Gentile, ed a 28 luglio del d.° anno lo fece Vescovo della/medesima. Fra le altre cose, che egli operò nel suo goberno di d.a/Vescovile Chiesa si legge in un pubblico Istrumento rogato sotto il di/5 Novembre del 1387 da Andrea Luca di Casilverio, e vallato colla/sottoscrizione di esso Vescovo, che si conserva nell’Archivio/dell’inseigne Colleggiata Chiesa di Trasacco, si legge dico, che in/sieme con Errico de Erricis di Trasacco donò alla Chiesa di S. Ce/sidio la rural Chiesa di S. Tommaso posta in loco detto la Fossa de/Villa con obbligo che la medesima ogn’anno nel Mese di Agoato/dovesse per dritto di Procura, e di Catedratico pagare al Vescovo, e/suoi Successori in perpetuo cinque coppe di orzo, e carlini quindici,/pagandosi anche oggi di questo censo al Vescovo dei Marsi./Resse per dodici anni Monsig:r Gentile Maccafani la Marsicana/Chiesa, finchè ai 14 di Novembre del 1399 dal Somo Pontefice/bonifacio Nono da questa Chiesa fu traslato a quella di Nicastro in/Calabria. Mentre ritrova vasi Vescovo di quella Città nell’anno 1409/fu convocato in Pisa il Concilio Generale, dove egli con gli altri/Padri intervenne, sebben il d.° Concilio da Gregorio Duodecimo,/che allora reggeva la Sede di S. Pietro non fosse ne approvato, ne/riprovato. Del Nostro Gentile ne fanno Menzione il Labbè nella/Collezzion de Concilj, e Cossart, L’Abba.te Ferdinando Ughelli nella/dua Italia Sacra, Muzio Febbonio nell’Istoria dei Mar-/si, e Monsig.r/Pietro Antonio Corsignani nel Tomo, che tratta de Viris illustri bus/Marsorum. Doppo d’aver successivamente con lode governate queste/due Chiese, e la Marsicana, e la Neocastrense morì in Nicastro, ed/ivi sepolto senza che il di lui onore gli sia stata eretta una lapide, o/inciso sopra il seplcro un epitaffio […]”, pp.4 e 5.
Non sappiamo dove Gian Maria Maccafani nello stilare il suo “ Compendiolo” abbia attinte le notizie riguardanti il vescovo Gentile. Forse ha fatto propria la notizia sopradescritta del Febonio.
La famiglia Maccafani di Pereto, ameno paese nella nostra contrada marsicana, è nota per aver dato molti vescovi sia alla nostra diocesi sia ad altre: “[ …] Sui/Maccafani non è stata mai redatta una pubblicazione, ma le sue vicende sono state/tante a tal punto che questa famiglia ha rappresentanto un caposaldo della storia della/Marsica, dell’Abruzzo e di parte della storia dell’Italia tra gli anni 1400 ed il 1500/In questi due secoli ha dato vescovi a diverse diocesi. Primo fra tutti troviamo/Salvato, che fu eletto vescovo dei Marsi nel 1418. Segue Angelo, nominato nel 1446 alla cura della diocesi marsicana e successivamente, nel 1466, nominato da/papa Pio II tesoriere della Marca Anconetana, luogotenente di Macerata e/governatore di Fano./Morto Angelo Maccafani, gli successe suo nipote Francesco nel 1470 alla guida/pastorale della diocesi dei Marsi. Troviamo Gabriele nel 1471, che dopo 27 anni/lasciò la diocesi a Giacomo Maccafani, suo nipote. A Giacomo successe Giovanni/Dionisio che venne eletto vescovo nel 1520./Da non dimenticare tra i vescovi di questa famiglia, monsignor Angelo, che fu il/primo vescovo della diocesi di Lanciano nel 1516, e Giorgio, vescovo della diocesi/di Orte e Civita astellana nel 1498 e successivamente, nel 1511, vescovo di Sarno […]” dalla presentazione dell’ottimo lavoro di Massimo Basilici : “ Gian Gabriello Maccafani “ , I Quaderni di Lumen “,n. 16- stampato in proprio, settembre 2005. Nel “ Liber Matrimoniorum ( 1567-1705 ) “ della chiesa di Santa Maria dell’Annunziata volgarmente detta “ Dentro “ di Cerchio è registrato il seguente atto di matrimonio riguardante ” Gio.[van] Maria maccaphano “: “[…] Adi 20 d[e] Giug.[n]o 1626/M[esser] Gio:[van]Maria maccaphano con Mad.[onn]a Cristina d[e] amor’[e] d[e] circhio/Forno cognionti in Matrimonio p[er] me Don And.[re]a panecas[i]o Arciprete d[e]/Circhio precedentino le 3 denu[n]tie stante populo ad/Divina et così n’have fatte fede l’Arceprete d[e] Perito si como coma[n]da/il sac[ro] con[cilio] d[e] tr.[ent]a p[rese]nto l’infrascritti test.[imon]y/il dcotor’ Gio:[van]maria d’amor’/il Doctor’ Alfonze Capello/Don Alf.[onz]o rubeis/Don Cesar’ Col.ant.[oni]o/et altri d[e] Circhio et d[e] Pereto […]” )
35) H. Millet: “Le péres du Cocile de Pisa (1409): édition d’une nouvelle listre-Presée Melanges de l’Ecole francaise de Roma. Moyen Age. Temps modernes. Année 1981 Volume 93 Numero 2 pp. 713-790.
36) Vedi nota 24.
37) ITALIA SACRA/SIVE/DE EPISCOPIS ITALIAE/, Et Insularum adjacentium, rebusque ab iis preclare gestis,/deduca ferie ad nostram useque aetatem./OPUS SINGULARE/PROVINCIIS XX.DISTINCTUM,/In quo Ecclesiarum originis,Urbium conditiones, Principum donationes,/recondita monumenta in lucem proferuntur./TOMUS PRIMUS,/COMPLECTENS Ecclesias Sanctae Romanae Sedi/immediate subjectas./AUCTORE/D. FERDINANDO UGHELLO/FLORENTINO/Abbate SS. Vincentii,& Anastasii ad Aquas Salvias Ordinis Cistercensis./Editio seconda, aucta & emendata,/CURA ET STUDIO/Nicolai Coleti, Ecclesiae S. Moysis Venetiarum Sacerdotis Alumni./VENETIIS, Apud Sebastianum Coleti MDCCXVII./SUPRIORUM PERMISSU, ET PRIVILEGIO.
38)FEBONIO M.: STORIA DEI MARSI”/Libro Terzo/testo latino e traduzione, De Cristofaro Editore-Roma 1991- Volume realizzato con finanziamento della Banca Popolare della Marsica, pp. 264,265,266,2667.
39) CORSIGNANI P.A.: “ REGGIA MARSICANA, Patrrino Napoli 1738, parte I, p.645
40) ZANOTTI L.: “ Regesti op.cit.” Nella sottoscrizione di firma “ Masius Janditella ad contractus Judex pred[ic]ti interfui et me subscripsi et signavi” è chiaro quindi che tale cognome veniva usato normalmente sia come “Janitella” che “ Janditella” sicuramente lo stesso personaggio è riportato il 12 Aprile 1428 come Antonio Masi Janitella : “[…] 1428/Die 12 Aprilis sexta Ind[icitio]nis P[rese]n[te]s Inst[rument]tus fuit in Sudicio, et apud Acta curie/R[everendissi]mi in xpo P[et]ris J. Episcopi[…] Regys Consialys et Comis[sa]rio proc Antoniu[m]/Masi Janitellu[m)]de Agello Episcopi S(anc)ti Angeli de Lombardis[…]”.
41) CORSIGNANI P.A. : “ Reggia Marsicana” op.cit., Parte I, p. 647
42)AMICONI F. : “ Aielli: Porta Janitella”, Marsica Domani, n. 17/2003, 15.11.2003, Anno XIV.
43) CORSIGNANI P.A. : “ Reggia Marsicana op.cit.”, parte I, p. 643.
44) CELANI E. :” Una pagina di Feudalismo la signoria dei Peretti-Savelli-Sforza-Cesarini sulla Contea di Celano e Baronia di Pescina (1591- 1806 )”, Città di Castello, Tipografia dello stabilimento S. Lapi, 1893, pp.10,11.
45) TOLLIS C. : “Storia di Celano “, Tipografia Fabiani-Pescara, 1867, p. 102.
46) “Personaggio dotato di profonde conoscenze umanistiche, era legato alle vicende politiche e alla cultura della rinascenza, sollecitato anche dal fervore artistico che circondava Alfonso V il Magnanimo, re d’Aragona e di Napoli. Molto stimato da questi fu mandato a Roma nel 1452, quale suo rappresentante, per partecipare alla incoronazione imperiale di Federico III, frutto della conciliazione tra la Santa Sede e la corte tedesca, dovuta all’attività di Enea Silvio Piccolomini, allora vescovo di Siena […]”, in Taccone N. : “ Celano oggi, memoria d’arte “, Stamperia Artistica “ Il Globo”, Bologna 1990,p.10, nota 3.
47) Nacque a Cerchio il 17 Giugno 1807 da Giuseppe e Berardina Santoro. Fu medico condotto prima a Scanno e poi, dal 15 Gennaio 1839, definitivamente a Cerchio. Fu eletto sindaco di Cerchio in due tornate elettorali: 1840-1846 e nel 1861.Il Nostro dopo aver superato gli studi ordinari nella città dell’Aquila presso “il florido Collegio dei dei dotti Padri Gesuiti[…] meritò il diploma in belle lettere e filosofia a venti anni di età[…]”e nel 1831 conseguì nella città di Napoli due lauree “dottorali in Medicina e Chirurgia che egli meritò a 24 anni appena” ( vedi Amiconi F.: “ La Carboneria a Cerchio e nei Disttretti di Celano e Pescina farri e documenti “, Edizioni Kirke Cerchio, 2012, pp.104-113. Vedi anche Amiconi F. : “ Benedetto D’Amore: storia di medici nella Marsica del XIX secolo “, Museo Civico di Cerchio, Quaderno, n. 1, Anno I, 1998, ). Nel Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, edito nell’anno 1993 ( Annate LXXXIII) è stato pubblicato dal medico Dott. Angelo Di Gennaro un lavoro inedito del medico cerchiese Benedetto D’Amore dal titolo : “ Come si muore in medicina Memoria sull’epidemia di Scanno nel mese di novembre 1835 fino a maggio 1836 “ già pronto per esser dato alle stampe il Primo dicembre 1837. Non siamo riusciti a comprendere perché il mio prozio Benedetto D’Amore non diede alle stampe tale lavoro e perché lasciò il manoscritto in Scanno. Il citato manoscritto dal titolo esatto : “ Memoria/sull’Epidemia di Scanno ricorsa/nel mese 9[novem]bre 1835 fino a Maggio 1836/del Dottore/Bendetto d’Amore “ si conserva nel Museo Civico di Cerchio ( è stato donato dal Dottor Angelo Di Gennaro nel 1996. Il ricercatore tuttologo Antonio De Nino nelle sue “ Notizie e Scavi 1897- Regione IV (SAMNIUM ET SABINA ), p. 428, così lo ricorda : “[…] si andava con alcune indicazioni favoriteci dal decano dei medici abruzzesi, Cav. Benedetto D’Amore novantenne, della cui affabilità non si dice mai bene che basti […]”.
48)”[…]Cerchio – “[…] Nella sommità di un’antica/porta di forma gotica vi è un altro stemma, rappresentante uno scudo/con una fascia obliqua. Alcuni dicono derivato dalla dimora della Dea/Circe, Patrona di un distrutto Castello, ed altri dal possesso Baronale/del paese: nulla però di preciso può ritenersi.[…]”, ( Bonanni T.: “ STEMMI E CATASTI ANTICHI/DELLA UNIVERSITA’/DELLA PROVINCIA DEL/ SECONDO ABRUZZO ULTERIORE “, SEAB s.r.l., litografia F.A.R.A.P, S. Giov. in Persiceto,Bologna 1977-ristampa ottocentesca, p.p.35, 36) inequivocabilmente si tratta dell’antico stemma dei Beradi conti di Celano, rappresentato appunto da uno scudo con una fascia obliqua. Tale costruzione, purtroppo andata perduta, rientra, sicuramente nel potenziamento urbanistico difensivo voluto dai conti di Celano, così come lo è stato per Aielli ed altri centri, alla fine del secolo XIV. Quindi stante alle testimonianze dei due citati Autori dobbiamo arguire che nel nostro centro in un’antica porta vi era rappresentato lo stemma dei Colonna ed in un’altra lo stemma dei Berardi. Attraverso tre deliberazioni comunali ( una di Consiglio e due di Giunta ) della seconda metà dell’Ottocento apprendiamo: “[…] Seduta del dì trenta Aprile 1883 “[…] Il Presidente ( è il sindaco Venanzio d’Amore Fracassi il Giovane che egregiamente svolse l’attività di sindaco dal 1879 al 1913 e dal 1919 al 1920 n.d.r.) ha esposto al Consiglio che nella/strada principale interna, Via Regina Margherita,/e precisamente presso la casa del Signor Francesco/Tucceri fu Angelo esiste ancora un muro semi-/diruto detto arco di piazza, il quale è d’ingombro al-/la strada e di pericolo ai passanti. Propone quin-/di di deliberare l’abbattimento, trovandosi la pro-/posta da oltre ventiquattrore all’ordine del/giorno. Il Consiglio ritenuto la convenien-/za di abbattere l’inutile muro suddetto, ad una=/nimità Delibera : che a cura dell’Amministra=/zione comunale ne sia fatta eseguire la demoli-/zione, ed incarica la Giunta di disporre di quan=/to occorre per la medesima […] ”, Archivio Comunale di Cerchio, ”DELIBERAZIONI/DEL CONSIGLIO/MUNICIPALE/1/DAL 6 MAGGIO/1877/AL 31 OTTOBRE /1889”; Nella Seduta del 25 ottobre 1887 apprendiamo: “ […] Il Presidente ha esposto alla Giunta che essendo stato/demolito l’arco detto di piazza, e trovandosi la strada/Regina Margherita presso il medesimo ingombro di/terra ed inutile materiale, è stato necessario pulirla/e sistemarla, essendo tal provvedimento reclamato/non solo dal scomodo dei cittadini, che debbono in quel/punto passare, ma anche dalla igiene pubblica,/permanentemente offesa dalle mefitiche esalazio-/ni, che da quel cumulo d’immondo materiale esa=/lavano. Sottopone il notamento delle spese/occorse, e propone di deliberarne il pagamento./1° Giornate di carro N.° dodici a Lire cinque l’una £ 60,00/2° Gradoni metri lineari 45,20 a Lire tre messi/in opera £ 136,20/3° Selciato metri quadri 44,20 a Lire una al metro 44,20/Totale Lire duecentoquaranta e cent.mi quaranta 240,40/La Giunta:/Ritenuto che il cumulo delle materie ammonticchiate/presso l’arco detto di piazza erano un fomite perma-/nente di malsania per le cattive esalazioni che/tramandavano, ed arrecavano gran danno alla sa=/lute pubblica per trovarsi nel centro del paese, onde/lo sgombro del medesimo, e la sistemazione di quel/punto era cosa di somma urgenza./Visto il notamento delle spese occorse e trovatolo/regolare, Con voto unanime Delibera:/Che le medesime siano pagate nel loro ammontare/di lire duecentoquaranta e centesimi quaranta,/prelevandole dal Tit.(ol)o 1° Categ. 5° Art.° 63[…]”, Archivio Comunale di Cerchio, “ DELIBERAZIONI/DELLA GIUNTA/MUNICIPALE/1/DAL 12 DECEMBRE/1879/AL 18 DECEMBRE/1892 ”, p.1-184b, 1-185; in un’altra seduta sempre del 25 ottobre 1887 apprendiamo ancora: “[…] Il Presidente ha esposto alla Giunta che la strada/interna dalla Trinità all’arco di via Belvedere era dive-/nuta intransitabile pel pessimo stato in cui era ridot-/ta, e per le materie putride nella stessa accumula-/te, onde è stato necessità di bonificarla e siste-/marla. Sottopone il notamento delle spese occorse/e propone di deliberarne il pagamento./1° Gradoni metri lineari 41,88 a Lire tre al metro, messi/in opera £ 125,64/2° Selciato metri quadri 49,74 a £ Una al metro 49.74/Totale Lire centosettantacinque e Cent.mi trentotto 175,38/ La Giunta: Ritenuto l’urgente bisogno di boni-/ficare il tratto di strada suddetto./Visto il notamento delle spese e trovatolo regola-/re.Con voto unanime Delibera./Che le medesime siano pagate nel loro ammon-/tare di Lire centosettantacinque e centesimi trentotto,/prelevandole dal Tit.° 1° Categ. 5° Art.° 63 […]”, pp. 185b,186.Archivio Comunale di Cerchio, “ DELIBERAZIONI/DELLA GIUNTA/MUNICIPALE/1/DAL 12 DECEMBRE/1879/AL 18 DECEMBRE/1892 “.
49) D’AMORE B.: “ RACCOLTA DE’ PORTENTI E MIRACOLI FATTI DALLA MADONNA DELLE GRAZIE LA DI CUI IMMAGINE SI VENERA NELLA TERRA DI CERCHIO COMPILATA A SUA DEVOZIONE DA BENEDETTO D’AMORE , AQUILA TIPOGRAFIA GROSSI 1855, pp.4, 5. Amiconi F.:” Storia della Madonna delle Grazie di Cerchio Attraverso documenti editi ed inediti “, Ed. Kirke, Cerchio – Avezzano, 2018.
50) Non più esistenti in quanto furono abbattute mel XIX secolo per ordine dell’allora amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Venanzio d’Amore Fracassi il Giovane (1856-1940): “[…]Nella medesima seduta ( 30.4.1883 n.d.r. ) Il Presidente ha esposto al Consiglio che nella strada principale interna, Via Regina Margherita ( strada ancora esistente n.d.r. ), e precisamente presso la casa del Signor Francesco Tucceri fu Angelo ( tale abitazione doveva esistere proprio nel sito, andando su, dopo l’attuale abitazione di Giacomo Croce n.d.r. ), esiste ancora un muro semidiruto detto arco di piazza ( qui venivano annunciati i bandi più importanti per la comunità cerchiese come quello, per esempio, divulgato a Cerchio, il 4 ottobre 1569 riguardante i capitoli dello zafferano emanati in L’Aquila, il 16 settembre 1569, per ordine del “Regio Dohanero della Dohana della città dell’Aquila” Giovanni Battista de Antonellis e banditi in tutti i luoghi dell’aquilano dove la preziosa spezia veniva coltivata :”[…] fu bandito in Circhi in la piaza solita avanti la porta in presentia di Terrentio de petri de Ciccho, lorito d’amore, Cipriano de Varanello Jo:[van]berardino de Micuti tutti di d[et]ta terra, et notar Giovanni di Cayo di Magliano, et Cola petruccio d’Amore Massaro[…]” ) il quale è d’ingombro alla strada e di pericolo ai passanti. Propone quindi di deliberare l’abbattimento, trovandosi la proposta oltre ventiquattro ore all’ordine del giorno. Il consiglio ritenuto la convenienza di abbattere l’inutile muro suddetto, ad unanimità Delibera che a cura dell’Amministrazione comunale ne sia fatta eseguire la demolizione, ed incarica la Giunta di disporre di quanto occorre per la medesima[…]”. Archivio Comunale di Cerchio, registro delle “DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 1 DAL 6 MAGGIO 1877 AL 31 OTTOBRE 1883. “[…]Nella medesima seduta ( 25.10.1887 n.d.r. ) Il Presidente ha esposto alla Giunta che essendo stato demolito l’arco detto di piazza, e trovandosi la strada Regina Margherita presso il medesimo ingombra di terra ed inutile materiale, è stato necessario pulirla e sistemarla, essendo tal provvedimento reclamato non solo dal comodo dei cittadini, che debbono in quel punto passare, ma anche dalla igiene pubblica, permanente offesa dalle metifiche esalazioni, che da quel cumulo d’immondo materiale esalavano. Sottopone il notamento delle spese occorse, e propone di deliberare il pagamento. 1° Giornate di carro N° dodici a Lire 5 l’una L. 60,00 2° Gradoni metri lineari 45,20 a Lire tre messi in opera L. 136,20 3° Selciato metri quadrati 44,20 a Lire una al metro 44,20 Totale Lire duecento quaranta e cent.[esi]mi quaranta 246,40 La Giunta Ritenuto che il cumulo delle materie ammonticchiate presso l’arco detto di piazza erano un fomite permanente di malsania per le cattive esalazioni che tramandavano, ed arrecavano gran danno alla salute pubblica per trovarsi nel centro del paese, onde lo sgombro del medesimo e la sistemazione di quel punto era cosa di somma urgenza. Visto il notamento delle spese occorse e trovatolo regolare, con voto unanime Delibera: Che le medesime siano pagate nel loro ammontare di lire duecentoquaranta e centesimi quaranta prelevandole dal Tit.° 1° Categ. 5^ Art.° 63[…]” Archivio Comunale di Cerchio, registro delle “DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 1 DAL DICEMBRE 1879 AL 18 DICEMBRE 1892”. “[…]89. Cerchio – […] Nella sommità di un’antica porta di forma gotica vi è un altro stemma, rappresentante uno scudo con una fascia obliqua. Alcuni dicono derivato dalla dimora della Dea Circe, ed altri dal possesso Baronale dela paese: nulla però di preciso può ritenersi[…]” Bonanni T: “ STEMMI E CATASTI ANTICHI DEALLA UNIVERSITA’ DELLA PROVINCIA DEL SECONDO ABRUZO ULTERIORE”, EDIZIONI SEAB BOLOGNA, 1977 , riastampa anastatica de “ I CATASTI ANTICHI DELLE UNIVERSITA’ DELLA PROVINCIA DEL SECONDO ABRUZZO ULTERIORE IMMESSI NELL’ARCHIVIO PROVINCIALE” , AQUILA- Stab. Tip. Grossi 1882, p. 35-36. Il su menzionato stemma è senz’altro quello della famiglia Berardi ( vedi le foto riprodotte alle pagg. 24, 26, 31 e 32 di “ Celano Oggi memorie d’arte”, di Nando Taccone, Edizioni Bora Bologna, 1990) come chiaramente si evince nella sopra descritta epigrafe posta nella trecentesca torre cilindrica di Aielli ancora oggi esistente recante la data, 1356, ed il nome del committente, Ruggero (II) conte di Celano con il proprio relativo stemma gentilizio raffigurante uno scudo sannitico recante una fascia obliqua: il simbolo araldico della potente famiglia dei Berardi. Nella “Pianta e Veduta dello Stato di Celano ne Marsi Adì 3 Febraro 1720” (conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Barberini, Indice II, 1944 b) si nota, tra le altre rappresentazioni, in modo inequivocabile, la porta principale ed un’altra entrata laterale oltre una parte delle mura cittadine con due torri cilindriche. Emergenze queste non messe nel dovuto risalto nella pianta, facente parte, della “Reintegra del regio Tratturo Celano-Foggia, realizata per ordine di Ettore Capecelatro il 7 Luglio 1651. Una torre cilindrica, invece, viene rappresentata, sempre nella rappresentazione grafica della università di Cerchio, nella “ Pianta delle Reggi Tratturi reintegrata dall’Illustrissimo Signor Don Alfonso Crivelli “ nel 1712. Nel 1869 lo storico Andrea Di Pietro a pag. 60 della sua già citata opera “Agglomerazioni delle popolazioni ecc.” riporta: “[…]7°. Il paese di Cerchio in questi ultimi tempi ha edificato fuori il recinto delle sue mura un tempio elegante dedicato ai Santi Martiri Giovanni e Paolo[…]”.
51) “ VERTENZA CERCHIO-COLLARMELE PARERE GENNARO MANNA, AQUILA TIP.SOCIALE A. ELISEO 1894, pp.CXVII-CXLIV.
52) PICCIRILLI P: “ Una relazione inedita intorno allo stato di Celano “, Rassegna Abruzzese di Storia e Arte, 1899.
53) TUCCERI-CIMINI VECCHIETTI T. : “ Cerchio Notizie Storiche e Leggendarie”, Roma 1947, ARTI GRAFICHE SEZZATINI .
54) CUOZZO E.-MARTIN J.M.:” Documents inedits ou peu connus des archives du Mont-Cassin (VIIIe-Xe siecles ) “ Mefrm, 103,1, 1991, pp. 115-210,18 Marzo 818.
55) Nel 1579 diede alle stampe le CONSTITUTIONES/MONACHORUM/ORDINIS S. BENEDICTI/SUB RIFORMATIONE/S. PETRI CONFESSORIS/OLIM COELESTINI PAPAE QUINTI./AB ILLUSTRISS.MO ET REVERENDISS.MO/D. CARDINALI DE ARAGONA/PROTECTORE/Ad praescriptum Regulae reformatae & auctae:/ATQUE A REVERENDISSIMO D. MAGI-/stro Petro Capocitto Circensi Abbate Generalia com/pilatae, eiusque cura excussae, anno tertio sui/tertij triennij, M D LXXIX./ ROMAE APUD Heredes Antonij Bladij Impressores Camerales,/ M D L X X I X..Rarissimo volume. Attualmente ne esiste una sola copia conservata presso la Biblioteca Alessandrina in Roma ( schedatura I.C.U. n. 2690 ).Tale opera fu ripubblicata postuma nel 1590 per i tipi di Giovanni Rossi in Bologna. Le menzionate edizioni sono collocate in fotocopia nel Museo Civico di Cerchio. Nel 1992 con apposita deliberazione di Consiglio Comunale gli amministratori del Comune di Cerchio hanno dedicato al Nostro una strada. Cfr. anche Febonio 1678 e Marinangeli. Il 14 Marzo 1585 D. Pietro Capocitto commissionò a Guillaume Porioret della Champagne, attivo in Roma, sette statue lignee da collocare nella basilica di Collemaggio dell’Aquila ( Atto del Notar Porzio, presso l’Archivio di Stato dell’Aquila ). Vedi Amiconi F. : “ I CODICI MUSICALI DI CERCHIO E LA LORO IMPORTANZA PER LA STORIA LOCALE “ in AA.VV. : “ LA MUSICA SACRA NELLA PROVINCIA DELL’AQUILA LA MARSICA “, IANIERI EDITORE, PESCARA, 2009, pp. 285, 286, 287.
56) ZANOTTI 1995, PAG.160- Vedi appendice. Tale chiesa andò completamente distrutta in seguito al sisma del 1706.
57) EUBEL C. HIERACHIA CATHOLICA/MEDII AEVI/SIVE SUMMORUM PONTIFICIUM, S.R.E. CARDINALIUM,/ECCLESIARUM ANTISTITUM/SERIES/AB ANNO 1431 USQUE AD ANNUM 1503 PERDUCTA /E DOCUMENTIS TABULARII PRAESERTIM VATICANI/COLLECTA, DIGESTA, EDITA/PER/CONRADUM EUBEL, S. THEOL. DOCT./ORD.MIN.CONV. DEFINITOREM GENERALEM/OLIM APOSTOLICA APUD S. PETRUM DE URBE POENITENTIARIUM/EDITIO ALTERA/MONASTERII MDCCCCXIV/SUMPTIBUS ET TYPIS LIBRARIAE REGENBERGIANAE “ ; cfr. anche FEBONIO 1678, MARINANGELI E 2001, ZANOTTI 1995, pagg.103-
58) AMICONI 1998 e BERARDI 2005.
60) MARINANGELI 2001, passim;cfr. anche ZANOTTI 1995, PP. 103-110. Sullo Spirito Santo di Luco dei Marsi cfr. ANGELINI 1982-83.
61) MARINANGELI 2001, passim
62) ZANOTTI 1995, pag. 160
63) ZANOTTI 1995, PAG. 162.
64) ZANOTTI 1996,PAG. 260.
65) “ESSEQUIE FUNERALI Fatte nella Regia Chiesa di Colle.maggio. In morte del Reverendissimo Padre DON FRANCESCO D’AIELLI. Vicario Generale de Celestini, e co-Abbate nel detto Monasterio. Nel di 14. d’Aprile 1640. Nell’Aquila, Per Francesco Marino 1640 Con Licenza de’ Superiori.”. Vedi appendice.
66) “ESSEQUIE FUNERALI op.cit”.
67) E’ stato pubblicato con lo stesso titolo su Museo Civico di cerchio,Quaderno n. 116, Anno XIII, 2010.
68) ZANOTTI 1996
69) MARINANGELI G.: “ AMICO AGNIFILI PRELATO (1398-1476) “, Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Annata LXXXIX- (1999) [CXI dell’intera collezione]Tipografia G.T.E.,2001, pp. 5-30
70) MARINANGELI G. :” AMICO AGNIFILI op.cit . ”
71) MANFREDI A.: “ AMICO AGNIFILI E I LIBRI LITURGICI DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE “TOMMASI” DELL’AQUILA “, Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Annata LXXXIX(1999) [ CXI dell’intera collezione ] Tipografia G.T.E., 2001, pp. 31-57.
72) AMICONI F.:” I CODICI op.cit.”
73) AMICONI F.: “ I CODICI op.cit.
74) AMICONI F.: “ Storia della Madonna delle Grazie in Cerchio (Aq) (documenti) “, s.c.e. ( ma De Cristofaro Editore Roma ) s.d. ( ma 1996 ), p.98, nota 7 : “ Tomus secundus operum aliquot D. Gregorii papae huius nominis cognomento Magni, doctae[…]Parisiis, Apud Guilielmim in ponte Numaliorum e Gulielmum Debois sub sole aureo ac Sebastianum Nivellium sub Ciconiis” in via Iacoba MD62, reca manoscritto sul frontespizio: “Est Conventus Sactae Mariae Gratiarum Terre circuli Fra Eremitarum Discalceatorum Sancti Augustini” e, l’altro : “Sancti Gregorii Magni papae primi operum tomus VI Complectens Expositionem in vetus ac novum testamentum a B. Paterio[…]”, Parisiis MDCXIX cum privilegio Regis “ anche questo reca manoscritto sul frontespizio l’identica annotazione sopradescritta.
75) AMICONI F. : “ Storia della Madonna op.cit., pp. 58-63 è riportato l’ “Inventario della Libreria”(vedi appendice) consistente in 499 volumi di cui 154 “ di poca considerazione ” all’epoca dell’espulsione, per ordine del re di Napoli, avvenuta il 16 Marzo 1776 dei frati Agostiniani Scalzi del Convento di Cerchio ( ora sede del municipio del Comune di Cerchio, del Museo Civico , del Bar Barattella, dell’Archivio Comunale e dell’abitazione del rettore della Chiesa della Madonna delle Grazie. Tale edificio, insieme con la chiesa della Madonna delle Grazie, in seguito al sisma del 6.4.2009 è stato ritenuto inagibile e quindi chiuso al pubblico ed ai fedeli.In occasione dei solenni festeggiamenti della festa della Madonna delle Grazie del 2010 è stata riaperto, per il mese di settembre, la chiesa ed il Museo Civico ed, infine, il primo settembre 2018, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, è stato riaperto al pubblico l’intero palazzo municipale con il Museo Civico.
76) AA.VV. : “ LA MUSICA SACRA op.cit, tav. XII.
77) PAPPONETTI G.: “ Croce e l’umanesimo meridionale “, Estratto da Abruzzo letterario, n.2/92, p. 12.
78) Archivio Comunale di Cerchio. Vedi anche AMICONI F. : “ STORIA DI CERCHIO DAL 1798 AL 1851 “, Stampa MCM carsoli AQ, 2006, pag. 263.
79) “ R.[EGIO] ISPETTORE DEI MONUMENTI/E DEGLI SCAVI DI ANTICHITA’/Cerchio, (sic) Febbraio 1915./Gentile Signore,/Nel grande disastro tellurico il meraviglioso patrimo-/nio artistico, così ricco specialmente di Arte autoctona, della/nostra regione è rimasto gravemente danneggiato. Spetta a noi su-/perstiti provvedere senza dubbio a raccoglierlo, proteggerlo, con-/servarlo. Io sono convinto che le forze si uniranno tutte in un/intento comune di amor figliale verso la disgraziata regione, per/conservare nei singoli paesi il tesoro artistico tramandato e da /tramandare./Voglia la S.V. perciò farmi conoscere quali opere d’Ar-/te nel Suo paese sono andate perdute e quali devono essere ricer-/cate e protette, affinché rendendomi interprete di tali bisogni/verso lo Stato, e constatandoli, ove occorra, di persona, possa/compiere nel miglior modo l’opera di conservazione dell’Arte A-/bruzzese./In attesa, Le porgo l’espressione della mia alta stima “. La soprariportata lettera facente parte del putroppo andato distrutto Archivio Sabatini D’Amore Fracassi e da me salvata insieme ad altri documenti ora collocati, in parte, nel Museo Civico di Cerchio ed in parte nell’Archivio Storico è conservata da me. Un’altra lettera simile a questa però recante, scritto a mano 25 Aprile ( la data del 25 Aprile è stata corretta infatti,prima, così era stata scritta: “Cerchio, Febbraio 1915”.) e la firma del “ Regio Ispettore Onorario de’ Monumenti e degli Scavi e degli oggetti di antichità e di arte Dottor Vincenzo Sabatini” è esposta nel Museo Civico di Cerchio. Quella da me conservata doveva essere la minuta oppure una lettera tipo da inviare, con l’aggiunta della data e della firma, ad altri.
80) Eloquenti sono le notizie intorno alla peste accaduta nella nostra contrada marsicana dal 14 Ottobre 1657 al 17 Agosto 1658 dove perirono ben 4080 persone ( Fondo B/162 -Archivio Diocesi dei Marsi Avezzano ) suddivise in 13 paesi fra i quali Cerchio (dove morirono 254 persone, G. Manna : “ Vertenza op.cit.”,pag. CXXIII, nota 1 ) e Ortucchio: qui, come chiaramente si evince da alcuni documenti del 1739 conservati nell’Archivio della diocesi dei Marsi in Avezzano ( C 32/802) e riguardanti la Cappella della Madonna del Carmine di Cerchio, veniamo all conoscenza che, per tema del contagio, furono bruciati non solo documenti ma anche mobili :” […] 4.° intende, E vuol provare, Come in te[m]po del Contagio tutti li libri/Parochiali di Battesimi, E Matrimoni furono incendia=/ti, di modo che in potere dell’attuale Prevosto Curato/della d.[ett]a T[er]ra d’Ortucchio no[n] Si trovano altri libri Parochia=/li,che dall’an[n]o 1694 à q[ue]sta parte, ed un libretto à quarto/foglio de Battezzati, che principia dall’anno 1657;fino//à Febraro 1658[…]Adi 3 Ap[ri]le 1739 In Ortucchio[…] Testifico di più, che altri libri Parochiali antichi in questa Terra/e impossibile trovarli, atteso che di Settembre del 1656 vi/fù il Contaggio, e Si Suppone restassero ingeneriti con gl’al-/tri mobili come è probabilis.[si]mo, mentre non si trovano[…]”. Così dobbiamo suporre che accadde anche nelle pestilenze accadute in Abruzzo nei seguenti anni: 1332, 1348, 1363,1381-84, 1429,1463, 1476, 1497, 1522-29, 1631, 1656 (L. Capasso – A. Capelli: “ Le epidemie di peste in Abruzzo dal 1348 al 1702”, Adelmo Polla Editore,Cerchio 1993, Tabella 3. Nel 1484, a L’Aquila, non furono eletti i mastri di fiera di maggio e la citata fiera non fu celebrata “ acciocchè da’ forestieri non fosse introdotta peste nell’Aquila” (A. GROHOMANN: “ Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese” Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli MCMLXIX. Si veda anche l’ottimo lavoro di Luigi Del Vecchio dal titolo : “ La peste del 1656-1657 in Abruzzo/Quadro storico-geografico-statistisco “, pubblicato sul Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria/ Annate LXVI-LXVIII/XCVII-XCIX dell’intera collezione, L’Aquila.Lo stesso autore anni dopo, nel 2006, ha ampliato il su menzionato lavoro dando alle stampe in modo integrale tutti i documenti rinvenuti nella sua lodevole opera: “ Processo delli morti in servitio delli appestati: contributo di un codice cappuccino alla storia dell’epidemia del 1656-1657/introduzione, edizione e note a cura di Luigi del Vecchio. L’Aquila:Frati minori cappuccini d’Abruzzo, c. 2006.
APPENDICE
Regesti Celestini
Di LUDOVICO ZANOTTI
Riproduzione anastatica
A cura della Deputazione Abruzzese di Storia Patria e dell’Abbazia Benedettina di Montecassino
Volume I: “ ARCHIVIA COELESTINORUM “, Arti Grafiche Aquilane, 1996
Volume I,I : “ DIGESTUM SCRIPTURARUM/COELESTINAE CONGREGATIONIS ”, Arti Grafiche
Aquilane, 1994
Volume I,II : “ DIGESTUM SCRIPTURARUM/COELESTINAE CONGREGATIONIS “, Arti
Grafiche Aquilane, 1994
Volume II : “ ARCHIVIA COELESTINORUM “, GTE, L’Aquila, 1999
Volume II,I : “ DIGESTUM SCRIPTURARUM/COELESTINAE CONGREGATIONIS “, Arti
Grafiche Aquilane, 1994
Volume II,II : “ DIGESTUM SCRIPTURARUM/COELESTINAE CONGREGATIONIS “, Arti
Grafiche Aquilane, 1995
Volume IV,I : “ DIGESTUM SCRIPTURARUM/COELESTINAE CONGREGATIONIS “, Arti
Grafiche Aquilane, 1995
Volume IV,II : “ DIGESTUM SCRIPTURARUM/COELESTINAE CONGREGATIONIS “, GTE,
L’ Aquila, 1999
Volume VI,I : “ DIGESTUM SCRIPTURARUM/COELESTINAE CONGREGATIONIS “, Arti
Grafiche Aquilane, 1995
Volume VI,II : “ DIGESTUM SCRIPTURARUM/COELESTINAE CONGREGATIONIS “, GTE
L’ Aquila, 1999 .
In questa parte del lavoro ho messo in evidenza le notizie tratte dai pregevolissimi su menzionati volumi riguardanti i vari personaggi appartenenti alla nostra sub regione marsicana :
Volume VI,II
Nelle pagg. 523,524,525 vengono messe in evidenza le date esatte della elezione ad abati generali( vedi in seguito) e nelle pagine 631,632,634,635,637 apprendiamo i nominativi dei vari frati celestini :
“[…] 1289. 14 Februariis[…]Fr’ Bartholomeus de Transaquis quis Proc.r ipsius Mon[aster]ii S.[anc]ti
Sp(irit)us[…]
1408. 14 9bris[…] F. Paulus Antonij Masij de Celano Frater ecc.[lesi]a S./[anc]ti Angeli […]
1438 5.^ et 7. (è scritto sopra n.d.a.) February F. Angelus de Castro Collis Armelis Prior S.[anc]ti Angeli de
Celano[…]
1438.25.May […] 4. F. Sanctus de Celano[…]
1508.29.7[septem]bris[…] 6. F. Celestinus de Celano[…]8. F. Jacobus de Piscina[…]
1510. 29. 7bris[…] 6. Petrus de Circhio[…]
1511. 9.Marty[…] 1. F. Petrus de Circulo[…]
1512. 15. Augusti[…] 1 F. Petrus de Circulo Subprior […]
1513. 13. 8[octo]bris F. Petrus de Circhio Subprior Mon.[aster]ii S.[anc]ti Angeli de Celano[…]
1522.6.May. F. Petrus de Circulo Prior d.[ic]ti Mon:[naster]y[…]
1526. 23. 9[novem]bris F. Petrus de Circhio Prior Abbate[…]
1527. 4. F. Jo(ann)es Cola Ovindoli[…]6. Petrus Celani […]
1532. 8 Aprilis[…] 7. Honufrius de Celano[…]
1539. 6. February[…]7. Maurus Circuli […] 6. F. Honofrius de Celano […]
1540. I. X[decem]bris F. Petrus Janniconi de Celano Prior S.(an)cti Angeli […] 2. F. Maurus de Circulo[…] 7.
F. Honufrius alias Ciaffone de Celano […]
1541. 19.January F. Petrus Janniconi de Celano Prior S[anc]tyi Angeli[…]2. F. Maurus Circuli[…]
1542. 19. January. F. Petrus de Celano[…] 3. F. Maurus de Circulo[…]6. F. Honofrius de Celano […]
1544. 10.7bris[…] 5. F.Honufrius de Celano […]
1546. 19. Augusti F. Petrus de Celano Prior S.[anc]ti Angeli de Celano[…]
1558. 25 Junii. F. Petrus de Circulo con[…]Prior S[anct]i Mon:[naster]y S.(anc]ti Angeli[…]3. F. Petrus
Janniconi de Celano […] F. Placidus de Agello(….)
1559. 26 Augusti F. Petrus de Circulo Prior S.[anc]ti Angeli et Pro.lis ultra Piscaria[…]3. F. Placidus/de Agello[…] P.r Mag.[iste]r Petrus fr Circulo Prov.lis Campanie, et Proc.r g[e]n[era]lis Cel[esti]nus […]
1561. 13. 8bris D. Petrus de Circhio prov.lis ultra Piscaria Coll[…] Cel[esti]nus[…] F. Placidus de Agello[…]
1564. 10. Aprilis […]F. Petrus/Janniconus de Celano […]F. Robertus de Celano[…] et F.Bernardinus de
S.[an]cta Eugenia[…] F. Petri Capocitti de Circulo prov.lis ultra Piscaria […]
1573. 7 July[…] 3. D. Robertus de Celano[…] 25. Juny[…] D. Petrus de Circulo Vic.[ariu]s g[e]n[era]lis
et Proc.[urato]r g[e]n[era]lis in urbe/D. Fra.[ncisc]us de Celano senior[…]
Volume I
Pagine 512, 514, 517, 519, 520, 521, 525, 526,531 si mettono in evidenza i la data esatta dei vari personaggi marsicani che scelsero la professione di farsi monaco ( Professiones Monachorum ):
1478. 10. January. F. Paulini de Licio
1481. 7. 8bris. F. Joannis de Celano
1483. 3. May F. Antony de Afflicto de Licio
1506. p.a 7bris F. Petri de Cirghio Marsican
1525. 25. Juny. F. Roberti de Ovinulo
1541. 8. 7bris. F. Francisco de Celano
1549. 2. May . F. Petrus de Circulo Marsican
1570[…]January F. Petri Pauli de Circulo
1571. 14. 8bris Petri de Agello
1576. 24. Juny F. Petri de Circhio
1577. 21. February. F. Cornely de Agello
1577. 2. 7bris. F. Paulini de Collarmelis
1578. 21. February. F. Benedicti de Colloarmelis Marsican
1580. 25. February. F. Clementis de Celano
1589. 21. May. F. Benedeicti Litiensis
1606. 4 . July. D. Jacobi de Ortona
1610. 25. Aprilis Professio D. Placidi de Gioa
1611. 24. Juny D. Arcangeli Marianetti de Celano
1614. p.a 9bris D. Alexandri de Litio
1636. 15 Juny Professio D. Petri Capocitti ex Avezzano
A pag. 534 apprendiamo ( Professiones Monachorum Addi…):
1657. 4. Martj D. Matthei Jordano de Litio
E a pag. 541 apprendiamo i nominati degli oblati( Professiones Oblatorum ):
1649. 16 Juny F. Petri de Celano oblati
1657. 16. 7bris. F. Francesco de Celano oblato
1657. 16 7bris. F. Giulio d’Aielli Oblato (…)
Volume II
Alle pagine 714 e 715 apprendiamo altri nominativi di personaggi marsicani che scelsero la professione monacale ( Professiones Monachorum ):
[…] 1537. 5 Aprilis F. Vincenty de Celano
1537. 15. 9bris F. Vincenty de Celano […]
1589. 20 Augusti F. Francisci ab Agello Marsen[…]
1592. 26 7bris d. Fausti à Colle Armeli[…]
1619. 24. February D. Leopoldi à Celano […]
Volume I.I
“Privilegia, et scripture/Celestinorum/ac suis proprys originalib[us] de verbo ad verbu[m]/extracta,/et iusta temporu[m] seriem ordinate,cum/quibus dam Annotationib[us] ( pagg. 39,62 e 63 ) :
“ […] 1426. 6. January. D. Abb[ati]s Cassinen[si]s Collatio Prepositure S:[anc]te Marie de Luco facta/F.ri Mag[nifi]ci Petro de Aiellis Prori S.[anc]ti Euseby de Urbe p[er] Mon[aste]rius Cassinense de/mand[a]to Ap[osto]lico gubernavit et bene se gessit. Vide stit.s quiapostem fuit E[pisco]pus S. Angeli/
1426. 15. January Corporalis possessio Ecc[lesi]a S[anc]te Marie de Luco capta p[er] Proc[urato]res F. Mag[istr]i/Petri de Agello, cui p[er] D. Abbate Cassinen(sis) collocata fuerat[…]
1639. p[ri]mo May. D. Card[inalis] Viceprotect[o]ris Depuratio D. Fran[cis]ci ab Agellis Abb[at]is g[e]n[era]lis/Cel[esti]nus/Celestinus in Presid.te Cap[itu]li g[e]n[era]lis de prox[im]o celebrandi[…]”.
Volume II
“ Pro nomibs in Civitate Aquile ”, pagg. 709 :
- 7. Aprilis. In Mon[aste]rio Collis mady Fr. Mag[iste]r Petrus de Agello/Prior, Fr. Dom[eni]cus de Pistigiola Subprior, F. Lucas de Monte Reguli, Fr/Nicolaus de Acciano, F. Angelus de Canu, F. Petrus de Rasino, F. Ant:s/de Rassino, F. Coletta de Rassino; F. Laurentius de Monteregali, F. Santes/de Podio, F. Jo[ann]es de la Porta, F. Castellinus de Popleto, F. Jo[ann]es de Balneo,/F. Ant.s de la Porta, F. Antonellus de Navellis, F. Comollus de Paganica,/F. Angelus de Colle, F. Angelus de Cucumbetta, F. Jacobus de Podio, F./Anucius de Pistingiola, F. Ciccus de Rasino, F. Jacobus de Undeci,F./Amicus de Podio, et F. Jacobus de Cocullo Conventuales d(ic)ti Mon.(aster)y capituli/indigentes pro felicita fiendo intus d.[ict]a ecc.[lesi]a, et pro alys debitis/cum lic[en]za D. F[rat]ris Laurenty de Adria Dec: Dir. Abb[ati]s S. Sp[irit]us vendiderunt/Bone uxori Micuti Collette de Rasino, Domum in Civit.[a]te in locali de Bazzano/Pro p[e]tio unciarum 40 monete Not(ariu)s Hannes Cole Not.[arius] Jo[ann]is de Bazzano[…]”
“ Diversorum “, p. 740:
“[…] 1426. 15 January. In Ecclesia S[anct]e Marie de Luco Ord[in]is S[anc]ti Bened[ic]ti/Marsican[am] Diocesis Proc[uratore]m Mag[ist]ri Petri de Agello Decret: Doct:/S[anc]ti Euseby de Urbe Prioris, corporale posses[io]nem accepit d[ic]ti Mon[aste]ry, et Ecc[les]ia S[anc]te Marie castri Luci, ac unium suor[um] vigne Lisa. F. Petri/Tomasselli de Neap.[o]li Abb:[at]is Mon[aster]y Cassinensis, qui d:[ict]a Ecc:[lesi]a, seù/Prepositura[m] vacante eid. Contulit sua vita durante, intuitu/servitior[um] Cassinensi Mon:[aste]rio preptitor., qui de Sedis Ap[osto]lica mandato/ d:[ictu]m Cassinense Mon[aster]ium gubernavit sub date in Civit:[a]te S[anc]ti Germani ( odierna Montecassino n.d.r.) […]”
Volume I
“ Iura Castri Pratularu[m] “, pag. 83:
- 6. May. In Abb[ati]a D. Fran.[sis]cus ab Agellis Prior S.[anc]ti Sp[irit]us permutant/Andree, et Ant.[oni]o de Lucente eius P.re de Pratulis Casalenu[m] sit à S.[an]ta Maria/della Pietà extu Pratulama, proPrato sito trà le forme, salvis imib. Abbatiae/Not:[ariu]s Jo[annes] Petrus de Stefanis de Pratula
1621. 27.Aprilis In Abb.[ati]a Idem Prior, et Monachi permutarunt Joanni/de Santo de Prosciutto de Pratulis terra[m] opera[m] triu[m] in terr.[itori]o Pratile/ubi dicit sup.ra la via di Prezza, salvis imis Feudalib. Abb.[atia]e pro Petia/terre centenarior undecim, et vitum 25. ubi dicit la Vicenda delli Mar=/giotti, et pro ducatis. Not[ariu]s de Omnibono del Sulm.[on]a […]”
“ Iura de Domib(us), & Terris in Civitate,/& territorio Sulmon:(ensis),& alibi[…]”, p 169:
“[…] 1602 9. xbris. Sulm[on]a D. Fran:[cis]cus de Aiello Proc.tor permutavit Jo:Frn:co,/et Camillo de Omnibono, Tera lla Macerina à giuno Operar quatuor cu[m] dimidia/Pro petia terre Opera[m] triginta in c.a alla Marana, quib. Est solvit pro equi.bentur/d.tus/d.tus 45. Not[ariu]s Vincentius Giannittus de Pectorano[…]
“Capsula Locationum, Censuu(m),/& aliorum Abbatie in/diversis Locis “, pp. 237,238 e 239:
“[…] 1576: ult. Augusti. In Mon(aste)rium S.te Marie Collis Madij de Aquila D. Petrus/de Circulo Abbas g[e]n[era]lis Cel[esti]nus, et aly Pres. congregati locaverunt ad sexe=/nium, Cole de Florino de Roma Rasi, Massaria, Oniu[m], et animaliu[m] Abb:[ati]e S[anc]ti Sp[irit]us, cum/cu[m] pactis, et conditionis pro annuo affictum. Not:[ariu]s Jo:[annes] Dom:[ini]cus Rite
1605. ij 7bris. In Abb.[ati]a D. Petrus de Agello Abbas g[e]n[er]ali et Monache d.[icta]e Abb:[ati]a/locaverunt p[er] sexenium Cap.nee Dom[eni]co Ant.[oni]o de Santis, et Jo:Ant.o eius filio, Mas=/saria oniu[m] pro annuo afficta. Not:[ariu]s Julius Campana[…]
1614. 17. Marty. In Abb.[ati]a D. Fran.[cis]cus de Aiello Prior, et Monachi, loca=/verunt p[er] annos quinq[ue] Cap.neo Dom.[eni]co Ant.[oni]o de Santis, Massaria omni. Pro annuo/responsione Not[ariu]s Thomas de Omnibono del Sulm.(on)a[…]
“ Census, et Emphyteuses “, pp. 242, 243:
“1614. 8. Augusti Sulm[on]a in Mon[aste]rio S. Lucia Bap[tis]ta Margiotta de Pratula, et Dott:[or]/Paulus eius Filius, vendideru[n]t D. Fran:[cis]co de Aiello Priori Abb[ati]e S. Sp[iri]tus, annuo Censu[um]/d[uca]tus 36; sup[ra] […]bris, pro p[e]tio, et cap.li d[uca]tus 450. Not[ariu]s Thomas de Omnibono[…]
1632. 12 Marty. Sulm[on]a D. Fran.[cis]cus ab Agellis Abbas Collismady Vic[ariu]s g[e]n[er]alis,/ et D. Jacobus de Naep[o]li Prior Abb[ati]e, no.e d.[ic]to Abb[ati]a vendiderunt D. Camillo Como,/D. Camillo Sanitate, no.e etia[m] Jospeh, et Jo[ann]is Bap[tis]te suo nepotu[m], et D. Lud[ovi]co de Capite/Icononio Mon[aste]ri, Monialiu(m) pro p[e]tio, et capituli d[uca]tus quatordecim milliar[um] ad ratione[m] teste[m] cu[m]/dimidio pro centenario D. Camillo Corvo pro rata cap[ita]lis d[uca]tus 6500/D. Camillo Sanitate pro rata d[uca]tus 1000; d[uca]tus suis Nepotu[m] pro rat[i]bus d[uca]tus 5500/et d:o Ma.io Moraliu[m] pro rata d[uca]tus 1000. Not(ariu)s Vincentius Giannittus […]
“ Pro Monast[e]riis Collis mady, & Celani “, pag. 330:
- 4. January. Pratulis D. Fran[cis]cus ab Agellis Prior Collimady concessit in/enphitensium ad 3:m generazione[m] mascolina[m] tn, Benedico Margiotti de Pra=/tulis, Canapina, fainile, et terras aratorius in territ.[ori]o pratile, ubi dicit lo /Rivo/pro annuo canone d.[uca]tus 24[…]
“ Iura Diversorum “, pag. 497:
1629. 12 . Junii. D. Fran:[is]co de Agellis Abb:[ati]s g[e]n[era]lis Investitum et concession/ facta d(omin)o Baroni Nuntio de Petris, pro se, et filys masculis tn,de Domo cu[m] macchia in Pratulis ante Ecc.[lesi]a S.[anc]ti Petri Cel[esti]ni iuxta MELIORA D.E Terre, qui/solvita pro entratura d[uca]tus triginta[…]
“ Pro terris de Petrinis “, pag. 508 :
“[…] 1600. 9. 9bris. Pratulis D. Fran[cis]cus de Aiellis Proc.[urato]r Abb[ati]a, vendidit Donato Li=/beratori, pro se ea filius masculis tui, petia terra opera[m] orto, cneteriaq.; alle cer=/que di S.[an]to Ant.[oni]o, devoluta. Abb[ati]a p[er] morte Vennaty Mei de Augustino/ de Rodiano abq[ue] filys masculis salvis imiq Abb[ati]a pro p[e]tio d[uca]tus 47. et/ carolenor[um] 6. Ide[m] Not[ariu]s […]”
“ Registrum/Actor Capitulor Generaliu(m), et Diffinitorialum “, pagg. 547, 548,549 e 552:
“[…] 1564. Aprilis. Acta Cap[itu]li g[e]n[er]alis in d.[ict]i Ven[erabili] Abb.[ati]a Preside./rev.[erendissi]mo D.[omino] Jacobo Picolomineo Ep[iscop]o Aprutino, et Rev:[eren]do D. Artogio Pa=/ganello Vic:[ari]o et Aud:[itor]e Ill.[ustrissi]mi D. Card[ina]lis Crispi Protect[o]ris in quo electus fuit/Rev.[erendissi]mus P[rio]r Mag(ist)ro Petrus de Circulo in Abb.[at]e g[e]n[er]ale a fol: 32 usq(ue) 57[…]
[…]1570 May. Acta Cap[itu]li g[e]n[er]alis celebrati in d.[ict]a Ven:[erabile] Abb:[ati]a Presidente/Rev: D. Lud.[ovi]co Michaelio V.J., in quo fuit electus Rev.[evendissi]mus/Mag.[iste]r Mag.[iste]r Petrus de Circulo in Abb:[at]e g[e]n[er]alem a fol. 88 usq[ue] ad 113
1576. May. Acta Cap[itu]li g[e]n[er]alis celebrati in Mon[aste]rio S[anc]ti Euseby de/Urbe de mand:[a]to ss.mi D. Gregory Pape XIV, in quo electus fuit Rev[erendissi]mus P[rio]r Mag.[istr]o Petrus de Circulo in Abb[at]e g[e]n[er]alem, a fol. 136 usq[ue] ad 1585[…]
1571. Octobris. Acta Cap[itul]i Annalis celebrati in d.[ic]ta Ven[erabile] Abb.[ati]a p[er] Rev.[erendissi]mus/p.re D. Petru[s] de Circolo, Abb[at]e g[e]n[er]alem fol:90[…]
1577. Octobris. Acta Cap[itu]li Annalis celebrati in d[ic]ta Ven.[erabile] Abb[ati]a p[er] Rev.[erendissi]mus pre D. Petru[s] de Circio Abb[at]e g[e]n[e]ralem fol: 29[…]
1585. May Acta cap[itu]li g[e]n[er]alis celebrati in d:[ict]a Ven[erabile] Abb.[ati]a Presid[en]te Rev.[erendissi]mus/D. Mag.[nifi]co Petro de Circio Abb[at]e g[e]n[er]ale nomine Ill:[ustrissi]mi D. Card.[ina]lis Protectoris,/in quo electus fuit Rev.[erendissi]mus Pr D. Mauritius de Bergomo in Abbate Ge=/nerale fol. 12[…]
1603. Aprilis. Acta Cap[itu]li g[e]n[era]lis celebrati in Ven[erabile] Abb:[ati]a S.[anc]ti Sp[irit]us de/salmone, p[re]sidente Ill.[ustrissi]mo et rev.[erendissi]mo D. Mattheo Saminiato Archip[presbiter]o/Theatin[u]m, in quo electus fuit Revend.[issi]mus P.D. Petrus ab Agellis in /Abb:[at]e g[e]n[er]alem. Cu[m] Actis Diffinitorialis Congreg[atio]nis in Mon[aste]rio S[anc]te Marie/Collismady de Aquila habite de Mense Augusti 1603: Fol: 91[…]
1605. Aprilis. Acti Ca[pitu]li Annalis in Mon[aste]rio S[anc]te Marie de Casaluccio/celebrati p[er] Rev[erendissi]mus P.D. Petru[s] ab Agellis Abb[a]te g[e]n[er]alem fol. 22[…]
1638. Aprilis. Acta Cap[itu]li Annalis Rome in Mon:[aste]rio S[anc]ti Euseby/p[er] Rev[erendissi]mus D. Fran:[cis]cus ab Agellis Abb[at]e g[e]n[er]alem, Assistente P[er] Ill.[ustrissim]o et Rev.[erendissi]mo D./Jo[an]ne Ant[oni]o Aglonio Vic.[ari]o g[e]n[er]ali Vercellen[sis] à Seren[issi]mo Principe/Card[ina]le Protec[to]re destinato fol. 44
1639. May. Acta Cap[itu]li g[e]n[er]alis celebrati in Ven[erabile] Abb[ati]a S:[anc]ti Sp[irit]us de Sulm[on]e/Presid:[en]te D. Fra:[nces]co Abb[at]e g[e]n[er]ale, Assistente verò/pro Seren[issi]mo Pri[nci]pe Card[ina]li Protect[o]re Rev[erendissi]mo D. Jo[ann]e Anyt.[oni]o Aglenio Vic[ari]o Ver=/cellensis in quo electus fuit Rev[erendissi]mus Pr F. Dominicus Chimentus in Abb[at]e g[e]n[er]alem cu[m] Actis Cap[itu]li Annalis in ead[em] Abb[ati]a celebrati de /Mense May 1641. fol. 66[…]
“ Additiones “, pag. 554:
1627. Aprilis. Acta Cap[itu]li g[e]n[er]alis celebrati in d.[ict]a Abb[ati]a Murr./Presid[e]nte Ill[ustrissi]mo, et Rev[erendissi]mo D. Erasmo Paravicino Episcopo/Alexandrino, in quo electus fuit Rev[erend]us D. Fra[ncis]cus ab Agellis/in Abb[at]e g[e]n[er]alem fol: 77[…]
“ Registra Abbatu[m] G[e]n[er]alium “, p. 555:
“[…] 1627. 1628. 1629. Registru[m] R.[everendissi]mi D. Fran[cis]ci Ab Agellis Abb[at]is g[e]n[er]alis
Volume II,I
“ Processus,sup[er] vita, morte, et miraculis B. Petri de Mur=/one pro eius Convintione “, p. 127:
de Mense May, et Juny quarte Inditionis./De Anno 1306, et de mand[a]to Clementis Pape/V […]
Testis n. 162. Fr. Bartholomeus de Transacco/Ord.[in]is fr[atr]is Petri de Murrone, annoru[m] quinquaginta quinq[ue]/vel circa, testis exam.[ina]tus dixit che erano gia passati/4°. Anni che si era fatto Monacho, e pigliato l’habito/del suo Ord.[i]ne nel Mon[aste]rio di S[anto] Sp[irit]o della Maiella, e fu co[n] lui in d:[ett]o Luogo, et altri Luoghi dell’Ord[i]ne, e lo serviva q[uan]do/era Papa[…]”
Volume II
“ Pro Molendinus, & Terris in tutte,/Balneo, Bazzano, & Paganica/Pro Molendinus “, p. 565:
1606, ij. Augusti. In Mon[aste]rio Collismady D. Petrus ab Agellis/Vic[ariu]s g[e]n[era]lis Cel[esti]nus Abbas, et Prior d[ic]ti Mon[aste]ry, ac Monachi capituli/congregati reservato assensu Ap[osto]lico concesserunt in enphiteu=/sim ad tertiu[m] generazione[m] mascolina[m] D. Hieronimo Josephi/Pica de Aq[ui]la Molendinu[s] d[ic]ti Mon:[aste]ris sit in pertinentis de/turri/pro annuo canone ex responsione salmas 40 Frumenti de mo=/litum, boni cum pactis. Not[ariu]s Carlolus Ant.[oniu]s Pandulfus
“ Pro terris ibidem “, pag. 586,587:
“[…] 1606. 10. Aprilis. In Mon[aste]rio Collismady D. Fran[cis]cus de Aiello/Prior, et Monachi d[ic]ti Mon:[aste]ry capituli congregati, no: permutaverunt/Fran[ces]co et Alphonso Olive de Aquila Petia terre in territ[ori]o Bal=/noi a pede la Vicenda di S[an]to Ranerio cuppas 20 et dexter:20/valoris d[uca]tus 224 et carol[enorum] 4. It[em] petia terre sodive, ibid[em]/cuppas 4, It[em] petia[m] terre platium ins. Cuppas 2, et terit. 22./valoris cu[m] d.[ict]a terra sodam d[uca]tor 357. Pro petia terre arative in/territ.[ori]o Fosse d[uca]tus 286. Ite[m] pro petia terre in territ[ori]o Balnei alle vicende/di S[an]to Rainieri Cuppas quinq[ue] et dexter 47, valoris d[uca]tus 50/Not[ariu]s Carolus Ant.[oniu]s Pandulfus de Aquila[…]
“ Census, Loacationes, & pro cereis, in Festivit:[ate] S.[anc]ti Petri Celestini “, p. 589:
“[…] 1607. P[rim]o 9bris. In Mon[aste]rio Collismady. D. Fran.[cis]cus de Aiello/Prior, et Monachi d[ic]ti Mon[aste]ry capituli congregati concesserunt in enphi=/teutim ad termia[m] generazione[m] mascolina[m] Not.[a]rio Cesari Cesario de Acciano Ecc[lesi]a S[anc]ti Comity in territ[ori]o Acciani cu[m] a[…] terris suis/aratorys, vineatis, silvis, et orb[…]alys bomis, et redditibus,/ad d[ict]ta Ecc[lesi]a spectantib[us] Pro annua responsione d[uca]tus quatuorde=/cim in Festo O[mn]iu[m] Sanctos. Not.[ariu]s Carolus Ant.[oniu]s Pandulphus
“ Pro S:[anc]ta Maria de Gratis “, pag. 609 :
1632. 29. 9bris Aquila. Lauretus Simeonis de Preta de/Coppito vendidit Mon[aste]rio S(anc)tis Marie Gratiaru[m] extra Aquila, et eius Monachis p[rese]nte D. Aloysio de Capua Proc.[urato]re Collismady de/ord[i]ne D. Fran:[cis]ci de Agellis Vic:[car]i g[e]n[er]alis Cel[esti]nus et Abbatis Collismady/Petia terre aratorie in territ:[ori]o completi ubi dicitur alle Grotte cup=/paru(m) quatuor, et dexter: 9, Pro p[e]tio carolenor[um] 26. pro quolibet/cuppa; quod p[e]tium solutu[m] fuit ex pecunys elemosinat[o]r receptis/ed effectu[m] q[uo]d fructus d[ict]e terre impendantur pro oleo lampade conti=/nuo ardende ante altare S[antis]S:[i]me Virginis in d:[ict]a Ecc:[lesi]a Not[ariu]s Ant:[oniu]s Pandulfus
“ Iura S.[anc]ti Cesidij, Caporciani,/ & Sancti Pij/Pro S.[anc]to Cesidio, et alus “, pag. 636. 637 :
“[…] 1542. 12. bris In Burgo Terre Caporciani. F. Petrus de/Circulo Prior Prov[incia]lis, et Rector Mon[aste]ry Collimady, no.e locavit/ad livellu[m] in enphiteutim ad plantendis vineis et durantibs vineis, Jo[ann]i Santi Santis, Paschalis/Miei Antony, Jo[ann]i Vincentio Antony Trieri; Petro Paulo Antony/Thiroi, Jo[ann]i Angelo Santis Jannis Marci, Hallo Mancini, et Jo[ann]i/Bernard[in]o Jaocbi, Terris infra[scrip]tus in terr[itori]o Capurciani ubi dixit,/le Pizze; it[e]m alia[m] petia[m] ubi dicit[ur] Lo Moricone, cuppar[um] in totu[m]/38 dividendis inter ipsos, ad plantandis vineis, et q. eis no[n] possint/alienare inequibito Domino Sed nulla fit mentio de annua/responsione Not.[ariu]s Sancte Lapiolus de Beffio[…]
“ Pro Santo Pio “, pp. 647, 648:
“[…] 1607. In Actu Visitationis D. Fran[cis]ci ab Agellis Prioris/Collismady/Collismady Ord[in]is S.[anc]ti Py, quandocumque vacare con=/tingerit facta Parochiali Ecc.[lesi]e S.[anc]ti Petri Celestini de d.[ict]o Castro/ S[anc]ti Py cu[m] Sigillo pendenti […]
“ Pro S:[anc]to Mattheo de Monte Regali “, p. 662:
“[…] 1631. 21. May . In Mon[aste]rio Collismady D. Fran[cis]cus ab Agellis Abb.[at]e/et Monachi d[ic]ti Mon[aster]y concesserunt in enphiteutim ad 3.m generazione[m]/mascolina[m] Flaminio, et Ant.[oni]o Coccio, et Angelo Rufino de Villa Paci/Comit.[ati]bus Montis regalis ac et singola bona spctatua[…] ad ecc.[lesi]a S.[anc]ti Matthei de/Cesariana Grancia d[ic]ti Mon:[aster]y alias in enphiteutim concessa Doct:[or] Jo[ann]i Propter/et cesari Maria sub die 27 Aug.[us]ti 1604 et nunc ob eorum morte[m] ad/d[ic]ti Mon[aste]rius devoluta. Pro annua responsione d[uca]tus 49. Not[ariu]s Carolus/Ant.[oniu]s Pandulphus de Aquila […]
“ Pro nomib[u]s in Civitate Aquile “ , p.711:
“[…] 1604. 2. January In Mon[aste]rio Collismady, D.Fran[cis]cus ab Agello/Prior, et ceteri Monachi d[ic]ti Mon[aste]ry capitula dederunt in enphiteutim/ad tertia[m] generazione[m] mascolina[m] Not[a]rio Jo[ann]i Maria Venuce de Aq[ui]la,/et Josepho eius filio, Una[m] Apotheca[m] in Civit[a]te in bocali de Funi,/ubi dicitur piazza maggiore, Pro annua respons.[io]ne d[uca]tus 18. Not[airu]s/Carolus Ant[oniu]s Pandulfus
1605. 16. 7bris In Mon[aste]rio Collismady D. Fran[cis]cus de Aiello/Prior, et Monachi d.[ic]ti Mon[aste]ry dederunt in enphiteutim ad tertia[m] ge=/neratione[m] mascolina[m] Jo[ann]i Vincentio Rasuro de Aquila tres quar=/tus Apoteca in Civit:[a]te in platea magna; Pro annuo canone D[uca]tus/decem. Ide[m] Not.[ariu]s
1606. 4. Marty. Aquila. Gaspar Nobilis de Civit[a]te Pennaru[m]/vendidit Mon:[aste]rio Collimady, et D. Fran:[cis]co de Aiello Priori duodecima/parte Unius Apotheca sit in capite platee Civit[a]tis Aquila iuxta/Apotheca d:[ic]ti Mon:[aste]ry Pro P[e]tio d[uca]tus 40. Idem Not[ariu]s […]
“ Iura quecumque in Pizzolo, Poppleto,/& aliis Locis “, p. 733:
“[…] 1603. 10 7bris In Mon.[aste]rio Collismady D. Fran[cis]cus de Aiello Prior,/et Monachi d.[ic]ti Mon:[aste]ry capituli no.e permutaverunt Christofaro Mosseri/de Aquila Petia terre sodive in Popleto ubi dicit[ur] Pettino; Pro pe=/tia terre ubi dicit[ur] à capo lo laco Cuppas 15 et dext: 35/ iuxti bona d.[ic]ti Mon[aste]ry Not.[ariu]s Carolus Ant.[oniu]s Pandulfus […]
“ Diversorum “, p.746, 748:
“[…] 1534. 14. July. Aquila in Cam.[e]ra Mag[nifi]cus DD. Eiusd[em] Civit:[a]tis Mag:[nifi]co Bo=/naventura de Urbino cu[m] voluntate, et consensus dd:re DD. De Cam:ra, pro=/misit, et se obligavit Fr. Petro de Circulo Prov[incia]li, et Priori Collismady,/et Proc[urato]ris Laicis d:[ic]ti Mon:[aste]ry recolare Campana[m] magna d.[ic]ti Mon:[aste]ry Not[ariu]s Jo[ann]es Thomas de Eusanys de S[an]ta Ansia[…]
1552. 10. May D.F. Petri de Circulo Abb[at]is g[e]n[er]alis Cel[esti]nus Lite participationis o[mn]iu(m) bonor[um] Relig:[io]nis pro D. Dominico de Salvis Civi/Aquilano. Cu[m] sigillo pendenti.
1553. 22.Augusti. In Mon[aster]rio Collismady R.P. Mag[iste]r Vincentius de Celano Prov[incia]lis[…]
1627. 25. 9bris Benedictio D. Fra[cis]ci ab Agellis in Abb[ati]e S[anc]ti/Sp[irit]us de Murrone, facta Neap[o]li in Ecc[lesi]a S[anct]os Petri et Catarine, ad/Magella[m] per D. Placidu[m] Pariglia[m] Neap:[olita]nus Celestinu[s] Episcop[u]s/Lavellen[sis]. Lice. Imperfecti abq[ue] sigillo […]”.
Volume VI, II
Elezione degli abati generali ( pagg.523, 524, 525 ):
“ […]R. D. Petrus Capocittus de Circulo electus die […]a May 1552. Generale/Cap[itu]lu[m] ex Indulto Julii III ad Mense(m) 8bris prorogavit […]
R. D. Petrus Capocittus de Circulo Sac:[re] Theol:[ogie] Mag:[iste]r electus p:[ri]mo die 30 Aprilis 1564[…]
R. D. Mag:[ist]er Petrus de Circulo electus 2:do Die 14 May 1570[…]
R. D. Mag[iste]r Petrus de Circulo electus 3° die 13 May 1576. Rome in Mon:[naste]rio/S[anc]ti Euseby urbe de man:[da]to Gregory XIV congregate fuit g[e]n[era]le Cap[itulu]m[…]
R. D. Mag[giste]r Petrus de Circulo electus 4:to die 12 May 1582[…]
R. D. Petrus ab Agellis electus die 30 Aprilis 1603 […]
R. D. Francsicus ab Agellis electus p:[ri]mo die 2:da May 1627[…]
R. D. Franciscus ab Agellis electus 2:do die 14 Aprilis 1636 in Mon:[aste]rio S:[anc]ti/Euseby de Urbe, in quo de ordine Seren.[issi]mi P[ri]n[ci]pis Car.[o]lis, à Sabaudia Pro=/tectoris, Urbani VIII, ave[n]te convocatu[s] fuit g[e]n[era]le Cap[itu]lus cu[m] interventu/tantum[m]odo Patru[m] Diffinitorialiu[m], et unius Abbatis pro quolibet qarantenio/In hoc Cap[itu]lo Decretu[s] est quod Cap[itu]la g[e]n[era]lia et Annalia semper celebrentur/in Abbatia Murronensi die 10 May sine Priorib[u]s sed solu[m] cu[m] Abba=/tis, quod ab eos Urbano per eius Breve confirmatu[s] est[…]”.
Volume IV. I
Corporalis possessio Prepositadis. Ecc.a S.te Maria de Luco Capta p[er] Rev.dus Mag:ci Petri de Agello p[er] D. Ann.tes Cassine.a collate fuerat.
Edit. A.D. In Dei no[mi]ne Ame. Anno à Nativitate, eiusd[em] 1426. Regnante Sereniss.a Dom.a
1426 n[ost]ra D[omi]na Ioanna Secunda Dei Gratia[…] Mense Januarii Die quinto decimo
eiusd.[e]m quarta Inditionis. Ante Ecc.[lesi]a S.[anc]te Marie de Luco Ord:[i]nis S.[anc]to Bened.[ic]ti
Marsican[a]m Diecesis Nos Masius Janitelle de Agello publicus ubilibet per totu[m]
Regni Sicilie Regia au[ctor]i[ta]te Judex ad contractus[…]Dom[i]nus Masius de Agello
[…]Dominu[m] Ranieru[m] Lonne de Agello[…]nec non Fra[ncisc]is Angeli de Colle
Armele Jo[ann]is de Vertuno Antony Masy Jannitella de Agello[…]seu pred.to Domino
Ranerio Lonchi[…]d:ti Domini Raniery procuratori[…]
Ego q.[ui] su.[pr]a Matius Janditella ad contractus Judice pred.ti interfui et me subscripsi et
Signavi[…]” p. 107-108-109-110.
1428 Die 12 Aprilis sexte Ind.[ictio]nis pres.[en]s Inst.[i]tum p[rese]ntatu[m] fuit in Judicio et
Apud Acta Curie R.[everendissi]mi in x[cris]po P[resen]tis In E[pisco]pi Issersien Regy
Consiliary et Comiss.[io]ni p[er] Antoniu[m] Masi Janitellu[m] de Agello Proc:[urato]res
Procuratorio no[mi]ne et proparte Rev.[erendissi]mi in x[cris]po P.[atr]es, et Domini,
D[omi]ni Petri de Agello Episcopi S.[anc]ti Angeli de Lombardis
Ex p[ro]p[i]o originali existenti in Archivio Mon:[aste]rii S.[anc]te Marie de Collemadio
de Aquila[…]” p. 110
APPENDICE II
Muzio FEBONIO
(1593-1663)
STORIA DEI MARSI
Libro Secondo
Catalogo dei Vescovi dei Marsi
Testo latino e traduzione di Manfredo Santucci
Premessa e note di Angelo Melchiorre
De Cristofaro Editore – Roma, 1998, p. 187:
“[…] XXXVI
GENTILE DI AIELLI, della Diocesi dei Marsi, fu eletto Vescovo dei Marsi/da Urbano VI, nel settimo anno del suo Pontificato, il 29 luglio 1385. Insie-/me con Enrico de Enricis da Trasacco, donò alla chiesa di S. Cesidio la chie-/sa rurale nella Fossa di Villa, in base al diritto di padronato derivante gli dalla/fondazione e dotazione fatte dalla famiglia de Enricis in onore del predetto/S. Cesidio Martire. Nella medesima chiesa di S. Cesidio lo stesso Enrico ave-/va due artistiche Cappelle erette dai suoi progenitori in onore, rispettivamen-/te, di S. Caterina Martire e di S. Tommaso Apostolo, adorne degli stemmi/di famiglia, con i sepolcri dei genitori, con tutti i diritti e le pertinenze loro./Enrico le donò, con la sola riserva della celebrazione di cinque messe all’an-/no, in qualsiasi settimana, riconoscendo al Vescovo ed ai suoi successori il/diritto di ricevere ogni anno, nel mese di agosto, cinque coppe d’orzo e 15/carlini per i diritti di amministrazione e d’insediamento. Ancora oggi questi/tributi vengono solennemente versati. Nell’Archivio di detta chiesa si trova/l’atto di donazione, completo di ogni formalità e convalidato dalla firma del/predetto Vescovo, steso/per mani di Andrea Luca da Casalvieri. Il vescovo Gentile fu poi trasferito/alla Chiesa Neocastrense da Bonifacio IX nel 1399, nono anno del suo/Pontificato[…]”
Pag. 191:
“[…] XLIII
ANGELO,figlio del Notaio Antonio Maccafani, di nobile famiglia di Pe-/reto, primo di questa famiglia è annoverato fra i Vescovi dei Marsi, mentre/è stato il terzo di quelli che tennero la Sede. Siamo, infatti, persuasi che Gen-/tile e Salvato da Pereto appartennero pure a questa famiglia, se è vero che/in quel tempo, secondo una costumanza dei Longobardi, il nome alla fami-/glia veniva dato dalla giurisdizione e dal dominio dei luoghi; e il borgo pre-/detto era sotto il loro dominio dal 1310 (Dagli “ Annali” di M. S. Monaldeschi )./Questi, comunque, Uditore del Cardinale Capuano col titolo di S. Mar-/cello, viene eletto Vescovo dei Marsi da Eugenio IV, il 19 agosto del 1466./Fu anche Tesoriere Generale del Piceno; resse anche la città di fano e di Ma-/cerata, ove morì l’anno 1470. E’ sepolto nella Cattedrale, davanti all’Altare/Maggiore, in un sepolcro marmoreo che riporta il suo profilo e lo stemma,/con il segunete elogio:/”Sepolcro del Reverendo Padre Signor Angelo, Vescovo/Marsicano, della Marca Anconitana/Generale, Tesoriere generale e Legato/e Governatore della città di Fano./Morì il 14 settembre 1474[…]”
LIBRO TERZO
Cap. VII
Traduzione Manfredo Santucci, Ugo Planza (note di M. Santucci )
Pag.265-267:
“[…] E, prima di tutto, sulla cima di un colle ci si presenta Aielli,/centro piccolo, ma noto per la fama di personaggi che generò. Vi nac-/quero, infatti, Gentile, Vescovo dei Marsi, ed il Signore Pietro Iannetella, Ve-/scovo di S. Angelo dei Lombardi, che fu uno di quei Vescovi che conferirono/ad Amico Agnifili, nella sua sede propria, la dignità episcopale.Degnissi-/mo prelato, cui si accompagnano altri due che raggiunsero la suprema carica/nell’Ordine dei Celestini, pari alui, se non per dignità, almeno per fama. Il/primo di questi è il Signor Pietro di Aielli, nipote, per parte di madre, di un/altro Pietro : Capoccitti. Ma egli fu nobilitato più dal suo proprio valore che/dai meriti di questo zio. Ai monaci francesi, infatti che lamentavano che i/monaci cacciati dall’abate generale francese venissero accolti dall’abate ro-/mano e, per questo motivo, chiedevano alla Santa Sede che la loro provincia/non obbedisse ad abate italiano, egli si oppose in modo tale, con ogni sua/energia, da ottnere dal Sacro Supremo Senato dei porporati questa delibe-/razione: c he gli Italiani e Francesi ubbidissero ugualmente all’abate italiano e/ne eseguissero gli ordini. In seguito amministrò l’una e l’altra provincia e,/carico di anni, dopo aver espletato il suo mandato di Generale dell’Ordine,/passò a miglior vita ed ebbe sepontura nella Chiesa di Santa Maria di Colle-/maggio, all’Aquila, dove era spirato il 13 novembre 1606./L’altro non secondo al primo per bontà di costumi, per esemplare discipli-/na e dinamicità di azione, è Francesco di Aielli, della famiglia Macerola, la/più eminente del posto. Egli, dopo che nell’anno 1614 aveva esercitato l’uffi-/cio pastorale con tale energia e diligenza che le doti dell’animo suo erano or-/mai ben conosciute da tutto l’Ordine, nel 1636, a Roma, con favorevole una-/nime consenso di tutti i Padri, meritò di essere chiamato a far parte del Con-/siglio Generale dell’ordine e depose, in pari tempo, la carica e la vita. Atten-/de all’Aquila, nella medesima chiesa, il giorno della Risurrezione./Il colle su cui il paese è posto, gode della brezza meridionale del lago, onde/è tutto rivestito di alberi di olivo w di frutta varia. Frutta e vino hanno sapore/assai squisito. E’ poco noto ai Geografi( come del resto lo sono quasi/tutte le località circostanti), perché non è degno di nota né per antichità né/per altre particolarità. E’ sorto, come si ritiene, con i resti di Valeria: tanto/inducono a credere le parole incise sulla campana della Chiesa della Santissi-/ma Trinità( che per Aielli è la Chiesa Madre ed è retta da un Preposto/cui obbediscono sei Canonici ). Di tale campana così si è detto nell’iscrizione:/”Questa Campana fece fare il popolo della città dei Marsi nell’anno 1301”./Possiede le chiese rurali di S. Maria, S. Pancrazio, S. Nicola e S. Cristina./Procedendo di altre due miglia, quando il colle degrada in pianura,/si incontra Cerchio, anch’esso non grande centro, i cui abitanti/per rendersi di antica origine, si vantano di avere una favolosa discendenza/da Circe, mentre sono derivati dalle rovine di Cerfennia o da quelle di/Valeria. Le circa cento famiglie (1), che sostenta, si adunano nella Chiesa di S./Maria, sotto la cura di un Arciprete, che è assistito da quattro Canonici. Da/pochissimo tempo, in una località meta di frequenti gite, non lontano dall’a-/bitato, è stato eretto, sotto il patrocinio della SS. Vergine Maria, un elegante/convento di frati, detti Scalzi, che osservano la Regola, richiamata alla sua/primitiva severità, dopo che era andata scadendo, del santissimo Agostino,/Vescovo e Dottore della Chiesa./Non poco decoro conferiscono a questo centro due personaggi che porta-/no entrambi, il nome di Pietro Capoccitti, pervenuti alla suprema carica di/Generale dei Celestini. Il primo di essi era Abate a Siponto , nel tempo/in cui il cardinale De Monte teneva la sede arcivescovile. Questi, allorchè/salì al trono pontificio, non permise che rimanessero ignote la stima che ave-/va concepita per l’Abate durante i continui contatti avuti con lui e la di lui/rigida osservanza della disciplina dell’Ordine e le altre belle doti dell’animo:/ma, con proprio ordine, affidò subito ai Padri, nell’anno 1602, (sic! è da intendersi 1552 n.d.r. ), l’incarico di assumerlo alla loro suprema direzione. Dopo aver felicemente condotto/a termine tale incarico, ormai vecchio di 80 anni, morì il 5 novembre 1556 (errore di traduzione è il 1566 come chiaramente si evince dal testo in latino n.d.r. )/ed è sepolto nella Chiesa di S. Spirito al Morrone./L’altro che ne fu nipote, emulando le virtù dello zio, rifulse talmente da-/vanti a tutto l’Ordine, per splendore di virtù, prudenza, accortezza e padro-/nanza di quasi tutte le discipline, che, dopo, una lunga serie di inacrichi di/vario genere. Meritò, con straordinario dono, di essere chiamato, non una,/ma quattro volte, a ricoprire quello di supremo reggitore. In tale carica, con/lo zelo ardente del pastore, esplicò tutta la sua attività nel correggere, con/nuove costituzioni, e nel restaurare, con estrema decisione, le regole depra-/vate o, comunque, distorte dell’Ordine./Per questa sua azione si acquistò il nome di riformatore dei Celestini e,/non solo liberò da tutti i debiti l’Ordine, che ne era oberato, ma seppe accu-/mulare gran quantità di denaro per i futuri usi. Rinnovò dalle fondamenta/il Monastero, ormai fatiscente per l’usura del tempo, di S. Eusebio in Roma/e, dopo aver toccato gli 85 anni ( errore di traduzione sono 58 anni come chiaramente si evince nel testo in latino n.d.a.), illustre per fama e per virtù, morì a Barletta,/in Puglia, nel 1586.( Come abbiamo accennato il Nostro morì il 9 febbraio 1587 n.d.r. ) Il 18 gennaio ( è il 16 Febbraio n.d.r. ) 1596 la sua salma, a cura del Signor/Donato Lantona di Taranto che gli era succeduto, in ottavo luogo, nell’uffi-/cio pastorale, fu trasportata nella predetta Chiesa di S. Spirito al Morrone,/ove riposa in una cappella da lui stesso fatta erigere.[…]”
NOTE
- Nel 1625 Cerchio, secondo quando è riportato salla carta topografica: ABRUZZO ULTRA”, conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 4415, f. 10 che Paolo Cartario formò nel sopramenzionato anno 1625, contava 192 fuochi e le città di Celano, Pescina e Avezzano ne contavano 391, 256 e 399. Durante la peste avvenuta dal 14 Ottobre 1656 al 17 Agosto 1657 purtroppo perirono a Cerchio 254 persone pari a circa un terzo dell’intera popolazione infatti, nel 1669 Cerchio contava 58 fuochi . Celano, Pescina ed Avezzano ne contavano 264, 312 e 211. Barbagallo De Vittiis M.R.: “ Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: La munerazione dei fuochi del 1732, Roma 1977, Archivio di Stato di Napoli.
APPENDICE III
LELIO MARINI
“ VITA ET MIRACOLI
DI SAN PIETRO DEL MORRONE
GIA
CELESTINO PAPA
Autore della Congre.[atione] de Monaci
Celestini dell’Ordine de Monaci
Celestini dell’Ordine di San
Benedetto
Raccolta
Dal P.[adre] Don Lelio Marino Ledeggia/no
Abbate Generale della medesima
Congregatione
DEDICATA
AL SERENISSIMO SIG.[NO]RE PRINCIPE
MAURICIO
CARDINALE DI SAVOIA
DEL TITOLO DI S.[ANTA] M.[ARIA] IN VIA LATA
PROTETTORE DE CELESTINI “
IN MILANO
Pr Gio.[van]Battista Malatesta Stampatore regio
Camerale
1630
Ristampa anastatica, Torre dei Nolfi: Qualevita, 2007.
p. 456
“[…] Della morte del Santo, della Croce apparsa et
essequie, et dei miracoli occorsi
Cap. VII.
p. 462
“[…]Perche ancor’hoggidì nella testa del Santo Padre; la quale col resto del Corpo si conserva onorevolmente nella Chiesa di Santa Maria di Collemaggio de i Celestini presso l’Aquila, & si mostra due volte ogn’anno al devotissimo popolo Aquilano; nella parte destra sopra l’orecchio, si vede manifestatamente un buco di forma quadrangolare, che chiaramente appare non naturale, ma fatto con un chiodo conficcatovi, & è di larghezza quanto potrebbe fare un chodo ordinario di quegli che in Abruzzo si chiamano bresciani, & in quete parti di Lombardia si dicono di quaranta, & è tradizione commune sì nella Religione (al margine sinistro si legge: “ Traditione/circa la mor-/te del Santo.” n.d.r.) nostra, come nell’Aquila, che da i soldati della guarnigione gli fosse conficcato il chiodo nella testa, e che per quella ferita finalmente il Santo morisse; & altri anco dicono, che per ordine di Bonifacio ( VIII n.d.r. ) per la temenza e gelosia del Papato, al quale si vide che in breve doveva esser reassunto Pietro per la devotione universale de i popoli, come afferma il Biondo (al margine sinistro si legge: “ Biond. Decad./a lib. 9” n.d.r. ). Vi è anco fama e tradizione, che il medesimo chiodo fù da i Monaci compagni messo da parte e conservato, e si conserva hoggidì ritrovato non molti anni sono in questa maniera. Il M.[olto] R.[everendo] Padre Abbate Don Francesco d’Aielli, più volte da noi nominato e diligentissimo investigatore, & osservatore delle nostre cose antiche, tra le altre cose songolari avisatemi circa la vita di questo nostro Santo, mi ha informato & scritto ancora, che nell’anno 1597, egli stesso mosso da curiosità di vedere che Reliquie fossero in una cassetta posta nel muro della Cappella intitolata alla Beatissima Vergine Madre, che è alla parte sinistra dell’Altare Maggiore della Chiesa della Badia di San Spirito presso Sulmona, fece rompere il muro nella parte di dentro sotto il sepolcro della famiglia de Canibus di Sulmona, e cavata fuora la Cassetta, dove si conserva il Corpo del Beato Padre Roberto di Salle, del quale habbiamo puoco prima fatta mentione, trà queste tante Ossa, Vi trovò anco una scatola roto[n]da alta mezo palmo in circa tutta dipinta col coperchio:L’aprì
p. 463
L’aprì egli e trovolla piena di reliquie minute diverse, Tra le quali un chiodo longo mezo palmo e più, ligato conncerti pezi di sangue congelato di color pardiglio, involto in taffetà drappo di seta scolorita: Dice che era con esso lui il Padre Don Girolamo di Nicotera huomo di molta sperienza e curiosità in simili cose, il quale come più prattico (scrve il medesimo Padre Abbate) giudicò egli ancora, che fosse sangue, & il medesimo giudicorno & affermorno Tiberio Monti Medico Fisico di Sulmona eccellentissimo & di gran molto sperimentato & altri: Et aggionge, che da tutti loro fù giudicato che fosse quello il chiodo, col quale appare esser fatta la ferita, & il buco nella testa del Santo. E perciò spggoinge ancora, che spinto da maggiori curiosità, andando all’indulgenza e perdono di Collemaggio all’Aquila nel fine del mese d’Agosto nel medesimo anno vi portò il medesimo chiodo, per vedere, e far prova, se era verisimile e conforme al buco & alla ferita; & in presenza di Bartolomeo Crispo & altri nobili e Cittadini Aquilanio, mentre sì riponevano le reliquie del Santo già mostrate al popolo, pose il chiodo nel buco, e trovorno, che vi entrava giusto fino vicino alla testa & il grosso, dove appariva e si vedeva ancro come rugine, il quale alcuni giudicorno fosse sangue restatovi attaccato. Questo chiodo riportato al suo luogo, in memoria si conserva ancor’hoggidì & l’hò visto tra le altre reliquie nella Chiesa della Badia di santo Spirito presso Sulmona, colligato con gli stessi pezzi di sangue come habbiamo detto. Questa congettura p questo fatto pare certo di grandissimo momento, & io stesso oltre infiniti altri hò visto il buco & il chiodo, e consideratolo diligentemente[…]”.
Chissà se nell’archivio aquilano esiste questo documento od altri riguardanti Pietro d’Aielli?
APPENDICE IV
f. 1r
“ ESSEQUIE FUNERALI
Fatte nella regia Chiesa di Colle-
maggio.
In morte del ReverendissimoPadre
DON
FRANCESCO
D’AIELLI.
Vicario Generale de Celestini, e co-
Abbate nel detto Monasterio.
Nel di 17. d’Aprile. 1640.
Nell’Aquila, Per Francesco Marino. 1640
Con licenza de’ Superiori.
f. 1v
Oratione funerale fatta, e recitata
Dal Dig. Dot. Equitio Mauso
nio, nella detta Chiesa
di Collemaggio.
Non è peregrino il costume, mà communale appo l’antiche nationi di lodare coloro in morte, che gloriosamente operarono in vita. Acciò, che fra l’oscurità de tempi, andata l’alata fama, dal chiarore delle loro heroiche virtù fregiata, con più vivo lustrore di gloria all’immortalità risplendesse. Ricevè tal’usanza i natali in quella famosa Metropoli dell’Universo Roma, quando Valerio Publicola (come Dioniso Halicarnaseo riferisce nel 5. libro) Encomiò i magnanimi gesti di Bruto; stimando quella sagacissima Republica convenevole, che nel suo seno, glorioso Campidoglio del mondo, ove si vidde ingrandita la virtù, ivi similmente trionfasse su ‘l carro della lode la fama. Altri il ritrovamento di tal costume ascrissero a Pericle, di
f. 2r
di cui fù detto, che orando fulminava, e tonava, come vole Thucydide. Altri al facondissimo Greco Solone a sentimento d’Anaximene. Altri finamente stimarono a nostri tempi rinovellar inventione sì pia, per adattare a canchi dell’addormentata Posterità il pungente, & acuto sprone dell’altrui gloriose attioni, per farla riscuotere dal profondo letargo de vitii. Et eccomi (Reverendi Padri) la cagione mi sospinge quà sù in giorno di publico pianto a sciorre la lingua in non più da me usata favella; per rapportarvi succintamente nella perdita del Reverendissimo Padre D.[on] Francesco d’Aielli un’abozzo di quelle virtù, ch’in esso perfettamente campeggiarono. E solo bramerei, come scelto fra molti per più dolente, che eloquente, ch’altresì i sospiri del petto si convertissero in faco[n]dia della lingua. Mà che debbo far io, se la mia disaventura a passi stretti di trè soli giorni m’ha colto? Parli, e celebri pur altri con i dovuti insegnamenti dell’arte, che io nulla curando de Rettorici adornamenti, posto in non cale ogni limato artificio di tropi, e di figurem solo compassionante le vostre calamita, accomulando una mal digesta mole di virtù procurarò alla sfugita effigiarne un’ombra, non già figurarne il vero. E contentendo alla mia lingua senza ritegno il freno [ ò Antica Religiosa, che da quei
f. 2v
Quindj nell’imprese del Bargaglia l’accennata dottrina, nella bussola d’un saggio pilota, con vaga allegoria ci viene simboleggiata, nel cui corpo risplendendo una stella, con il motto (Aspicit, & dirigit, ne dà a divedere, che mediante la cognizione delle cose superiori, ritroviamo spedito il sentiero nell’operationi della vita Attiva. Et ecco, come di proposito rimiriamo nell’impresa del prudentissimo Aielli quella stella, che due volte dovea al suo pilota servir di Tramontana nel governo della Nave della vostra Religione. Se pur dir no[n] vogliamo con Firmico, che Atlante sotto la gravosa carica dei Cieli, tiene sù la testa due stelle, & altresì l’Atlante, che due volte sostenne il Serenissimo Cielo della Celestina Religione, dovea portar quella stella, che per fatal destino nel vostro Cielo collocata, fra mille folgoreggianti lumi, hauta pomposamente a lampeggiare. Né a caso dissi, per destino fatale, già che s’à Pietio Valeriano vogliam credere, fù appresso gl’antichi Romani per Hieroglifico dinotante la Prudenza, una stella posata su la robustezza d’una ferrata è nodosa mazza. Di che non mi lascia mentire Atento, che introducendo Troclo sagacissimo Rè, ò ne congressi de Cittadini, ò ne ragunanze de letterati, ò nelle zuffe de combattenti, non fa, che mai abbandoni il suo scudo, dove, una stella si rimirava con un motto, Hinc
f. 3r
Hinc omne boni. Et appresso li Romani le stelle, che comparivano su gl’altari de sagrificij Erano foriere de fortunati successi Raccontando Polibio, che presagirono nel governo di Galba felicissimo Impero, quando nell’uscir la prima volta di Senato, se li posò un raggio stellato su ‘l diadema reale; Se pur noi con sacra autorità d’Imeneo, che favellando della stella de Magi, proruppe, (Quid non debemus stellae, quae inter alias maior splendescens, via Regibus aperuit, praeco fuit Salvatoris;] Non vogliam dire, quind non debamus huic stellae, quae viam aperuit Religionis? Et a chi sorsi, sono incogniti il lampi della sua fugacità, i lustrori della sua prudenza, i scintillanti chiarori del suo governo, i benigni influssi del suo maneggio, & i favorevoli aspetti delle sue operationi? Sallo, sallo la sua Religione, che vistolo ancora giovanetto seguitare le gloriose orme del Reverendissimo Don Pietro d’Aielli suo gran Zio, di cui questo sacro, e Regio Tempio, con la memoria la fama s’honora, non mancò, chi da all’hora pronosticasse da un lucido Oriente un’occaso sì luminoso. La Republica di Sparta tanto famosa, come Giusto Lipsio nel quarto libro de militia Romana riferisce, dava a gli giovani gl’archi, e le frombe de loro genitori, co’ quali chi al delicato bersaglio colpiva, s’acquistava, fatto here:
f. 3v
herede del paterno valore la gloria di prode guerriero, & il vanto di generoso combattente: Onde Celio Lactantio nel 3. Libro de Pitagoricorum & storicorum disciplina, & morte volontaria dice, che qui maiorum vestigia insequendo, in prima ioventute Anzi che Argesilao fù da Numidi acclamato, ancorche imberbe per Ré, né per altro, che per haver dimostrato in una ambasciata grande prudenza, e sagacità. E del Rè Deioco non dicono le storie, ch’ancor fanciullo fatto herede del paterno valore: Attonito il Senato dalli primi saggi della sua prudenza: decretò che li fusse eretta una statua solim Deiocume un aetate quanti mesu imbecilli Rempublicam bene posse gubernare. Che infatti, Signori gl’albori di ua Serena Aurora presagiscono il giorno assai luminoso. Voi ( Voi Reverendi Padri) io chiamo in testimonio Voi costituisco Giudici, Voi bramo mi siate arbitri di quanto dirò. Qual saggio il vostro D. Francesco non diede di se stess0o9 ne primi, e novelli carichi dati dalla vostra Religione? Qual prudenza non dimostrò anco ne gl’anni più giovanili? Qual maturità non diede a dividere anco se più ferventi bollori del sangue? Ei co[n] il senno precorrendo l’età, impresa non tentava che a perfetto fine non conducesse, non in-
f. 4r
viti trasferito l’haveano: Che a raggione dunque con la dottrina d’Aristotile asseritia dobbiamo, che nel Reverendissimo Padre D.[on] Francesco havea di già la raggione sbandeggiato dall’animo suo quelle stemperate passioni, seguaci di coloro, che vengono sollevati nell’altezze de gl’honori. Né qui si ferma il suo valore, mentre con la molteplicità degl’anni accresce meriti alle di lui lodevoli operationi. Et eccolo a viva voce fatto Visitator Generale, termina differenze, sopisce litigi, riconcilia gl’animi, ismorza gli rancori, rasserena i turbamenti, indifferente con tutti, partiale con nessuno. Né qui devo passar sotto silentio un’attione, tanto più heroica, quanto che affatto si scoste dall’humano. Nacquegli nella sua visita occasione di aggiustare un gravissimo negotio, che ridottolo con la sua singolar destrezza a perfettione, gli fu per dovuto premio bona massa de Argento offerto. Ma l’integerrimo Don Francesco, imitatore del suo Santissimo Hierarcha, sprezzò ( non che accolse) con risentite parole quel dono. Oh attione certamente da consegnarsi all’immortalità, E pure vj è argano più potente, non vi è ferro, tanto fatale, non vi è baloardo si efficace per abbattere, e diroccare un cuore, ne lume più eccessivo per abbagliare la fiaccola di chi che sia, quanto va barlume
f. 4v
intraprendeva negotio, che non aggiustasse, affari non maneggiava, che non terminasse. Onde con la maestà della presenza, con la gravità d’una perfetta dispositione, con la maniera del trattare, con l’efficacia del parlare, nella dignità Abbatiale, che non fece, che non oprò? Qual Monasterio non ingrandì, qual’intrata non accrebbe? Quale raccolta non conservò? Quale provisione non moltiplicò? Qual peso non levò? Mà quelche più d’altra cosa recò meraviglia, mai cangiò per eminenza di grado l’affabilità de suoi costumi, mai per superiorità d’honori, conculcò chi che fusse, mai per grandezza di dignità offese né l’orecchie, né l’animo di ciasch’uno. E pure ad Alessandro il Macedone questo neo s’attribuisce. Anzi all’hora fu stimato, Seano dover di breve haver il crollo della fortuna, col provar nell’altezza del suo volo, un memorabile precipitio, ( & è osservatione di Pietro Mattheu ) Quando nella grandezza de gl’honori se gl’offuscò di maniera la veduta, che cangiava la naturalezza dei suoi costumi, non più su raccordava d’esser quel Seano, ingrandito dalla magnificenza di Cesare, & il contrario di Lucio Metello, che arrivato alla dignità del consolato (come Tacito afferma) Quamvis dignitate exaltatus imotum suavitatem numquam amisit; e fè, che quelle consolati securi, l’assicurassero in qugl’honori, dove i suoi meriti
f. 5r
me di biondeggiamte metallo. Quid non mortali pectora cogis Auri facta fames? Che meraviglia perciò, s’egli nai hebbe cosa di proprio? Anzi vò dirlo con chiedervi straordinaria attentione. Insegna l’Angelico d’Aquino, ch’il fondamento delle virtù Religiose sia la profondità dell’humiltà. In conformità di che hebbe a dire san Bernardo, Virtutum omnium stabile, & firmum fundamentum est humilitas. Non essendo vento più contrario, fulmine più impetuoso, crollo più violento per atterrare la bella machina dela perfettione, né foco più divorante, per consumarla, quanto un soffio di benche tenue ambitione. Sentite il nostro santissimo Protettore Celestino nel capo undecimo de suoi opuscoli. Sicut cera solvitur igne, ità, & anima inani gloria virtutum vigorem amittit. Et oh Reverendissimo Padre vigoroso nelle perfettioni, colmo di virtù ti vegg’Io; mentre in te gittasti i fondamenti di Religiosa humiltà: No[n] lo vedeste humile ritirato, moderatissimo nel habito, parco nel cibo, temperato nel senno, desto nell’osservanza, vigilante ne gl’oblighi, sollecito nelle funtioni, rigoroso di se medesimo, esemplare nell’esattezza, zelante ne chiostri, e d’un perfetto Religioso, perfettissima Idea? Ma sento, chi rimproverando mi dice, che mal habbia impiegato l’ingegno nella rammemoranza di virtù quasi abiette, & allo
f. 5v
& allo stato di povere, e Religiose persone dicevole; col tralasciar quelle lodi, che in lui più singolari, & eminenti pompeggiano: Ma contro ogni dovere, vengo io ripreso (Signori) poiche favellando d’un, ch’arrivò all’altezza della perfettione, Doveo col eruditissimo Chrisologo, Humilitatis bene iacto fundamento, omnium virtutem metam attingere. Oltre, che a parere di Bernardo, da essa quasi da amorosa nutrice vengono allattate l’altre perfettioni. Ne sò perciò, se in esso osservaste giamai una continua tranquillita di conscienza ben regolata, che gemella appunto dell’humiltà (così chiamata da Turtulliano) lo rese ad ogni qualunque sinistro avvenimento? imperturbabile, forte ne pericoli, sicuro nell’incontri, intrepido nelle minaccie, nell’avversità costante, nelle difficoltà risoluto, lieto ne travagli, animoso ne gli stenti, ardito nelle perversità, e coragioso nelle dubbiezze Coraggio nel’imprese spettanti alla sua Religione, ardimento nelli più alti negotij, animo nelle ambigue difficoltà, allegrezza nelli sudori, risolutezza in tutte l’attioni, costanza in tutti gli affari, intrepidezza in ogni loco, sicurezza con tutte le persone, e fortezza in tutte le cose. E che non può in un’animo ben composto serenità di coscienza? tù per sentenza di Agostino spaventi l’Inferno, Tù paga di te medesima, ti beffi di chi che sia, Tù co[n]- fidato
f. 6r
fidata nelle tue forse non hai nemico, che no[n] atterri, non odi maledicenza, che non confondi, non riguardi armatura che non disprezzi; non provi colpo, che non ributti, non senti puntura, che non rintuzzi, non porti giogo, che non iscuoti, non hai laccio, che non spezzi, non miri catena che non rompi. Tù generosa le doppiezze de più cupi cuori abborrisci. Tù leale le finte, e mascherate hippocrisie, svelando rimproveri. Tù li mendicati contenti dal tuo tranquillo seno discacci. E tù finalmente le superbe minaccie ad onta altrui con libero piè generosamente calpesti E ch’io non menta (Signori) soffrite vi prego (Reverendi Padri) che col ferro della mia voce pietosamente acerbo, vada di novo Riaprendo le latebre della vostra pur troppo fresca ferita, col raccordarvi quella serenità di volto, quella tranquillità di mente, quella intrepidezza di cuore, quella costanza d’animo, che nella sua ultima, ma tediosa infirmità il nostro Don Francesco dimostrò nelli cui disagi, non schifando il peso d’altri importanti affari, Divenuto novello Cinico, aceto addidit absyntium. Racconta Eliano nelle sue varie historie, che stando morendo Armatidio, mai si scordò de gl’affari del Regno, tù gl’ultimi respiri vitali, attendeva alle bisogne della Republica; mentre stava dando l’ultimo saluto alla vita mortale, non si dimenticava de
f. 6v
de gl’interessi Atheniesi, da quali fù poscia poco men, che adorato per Dio. Quanti sono qui presenti, ch’hanno visto, hanno sentito anche nell’angoscie dal male, come il Reverendissi.[imo] defonto, sempre vigilante al bene de Monasterij, racordevole dell’accrescimento della sua Religione, altra mira, né altro fine hebbero mai li suoi pensieri, che ingrandire quanto poteva quella, della quale n’era stato riparatore. Ma perche è tempo, che io restringhi per più non tediarvi il discorso, tanto più, che l’hò più tosto in fretta cucito, che ordinatamente tessuto. Contentatevi per breve altro spatio di tempo, che in un solo fiato dichi, quanto altro potrei con una ben lunga diceria. Se tutte le virtù, come dianzi v’accennai, consistono nella prudenza sola; e come proferì Thefrasto. Omnium virtuto qua est Prudentia, & il Vostro Reverendiss.[imo] Vicario generale fu più d’ogn’altro prudentissimo, non è questo di soverchio, non che abastanza? E che è d’huopo mendicare affrettate parole dova va numero di segnalare opere poco ben ch’infinite appariscono? Sanno gl’addotrinati da Platone, che Republica benè gerere, eximlum inter omnia opera est. Da che scorgo, ch’havere sorvolato con la vivezza de vostri ingegni, dov’io comincio a favellare. Oh Dio immortale
f. 7r
tale. Chi è di voi, che non sappia, che Don Francesco d’Aielli, due volte con il governo di una sola Republica, ma di una intiera Religione, Eminentissima nella Chiesa di Dio.Madre de fecondissimi heroi, fregio del Vaticano, fortissimo remo nella Nave di Pietro, Genitrice de letterati, fra le Monastiche, tanto osservante: habbi con quel maneggio governato, e con quel goveno maneggiato, che per i futuri secoli l’andra pubblicando la fama. Chi mai in carica di tant’importanza si portò con più costante fermezza, ò con più ferma costanza? Chi mostrò mai maggior animo, miglior mente, più intrepido cuore. Qual sede in lui non vidde, Qual sagacita in ogni occasione non palesò, Qual schiettezza nelle sue visite, non diede sempre a divedere, Qual’accortezza potè mai uguagliarsi, non che preporsi alla sua? Mai fu prelato, più riverente à maggiori, più benigno agl’eguali, più humano a minori. Egli nella sommita del grado era piccolo verso gl’afflitti, compassionevole verso gl’oppressi, rigoroso verso li rei, severo verso i colpevoli, accorto, discreto, amorevole, in tutti i lochi, con tutte le persone, per tutti li tempi. Il suo giuditio, la maturita della sua discrettione non hebbero pari mai, né haveranno (che io mi creda) per lunga pezza. Lo testifichino pure gl’annuali, ò Generali con
f. 7v
congressi della sua Religione, dove il parlare di Don Francesco erano sentenze intefragabili. Rifersice Aulo Gellio, che entrato Caio Gracchio in Senato omne ob magni sapientia, & prudentis viri reverentiam respondere non audebant; E Macrobio nel sesto de saturnali osserva, che nel famoso Colleggio d’Athene, Ubi solus Nevius loquebatur, reliqui tacebant. Mercè, che l’esperienza a sentimento di grand’huomo è quel foco, che raffina l’oro della prudenza; Quindi Plutarco c’avertì nella vita di quel Sertorio, che co’ proprij sudori secondo le gloriose palme nell’inclita natione Spagnola, ijs futura previdere minus est, difficile, qui plurima experit, &c. E che meraviglia se Cesare (come vole Theodoro) Inimicorum stratagemmata previdebat. Se cinquant’anni sotto il peso del elmo gustò, con più lodevole sapore un sorso di gloria, stemperata co’ suoi sudori, che non l’infame Eliogabalo gl’effeminati, riposi di soavissime piume? Qual maggior prova dunque si potrà recare della consumata prudenza del Reverendissimo Aielli, che in cinquant’anni di Religione, si sia esercitato la maggior parte nel governo di essa? che perciò arrivò con quella facilità a penetrare gl’altrui disegni, a prevedere l’altrui traccie, col mostrar animo risoluto in distornargli, segretezza in celare i suoi
f. 8r
i suoi fini, velocità in conseguirli, lentezza nel divisare, prontezza in mandarli in escecutione. Chi non scorse in esso l’esperienza de i Cesari, la fede de i Patrizij, la prudenza de Policaridi, la destrezza de gl’ Anassimeni? Ben lo conobbe il Serenissimo Principe Mauritio Cardinal di Savoia, di così heroica Religione vigilantissimo Protettore; Da chi hora chiamato in Torino, hora in Roma, & ultimamente nella seconda elettione al suo Generalato, Authenticò quell’altezza l’integrità con il valore del Reverendissimo Don Francesco. Il cui solo trattare, non ch’altro ha chiaramente fatto conoscere, che tante doti in un solo Aielli, nel corso del presente secolo annoverate si rimirano Ma per non esservi col mio dire tanto noioso, passo con silentio Le continue fatighe, in diverse altre occorrenze, da esso volontariamente abbracciate. Non faccio mentione, quanto fusse nemico de gl’honori, mentre fatto la prima volta Generale s’era ritirato in solitatio sì, ma devoto loco. Tralascio il ridirvi li longhi viaggi, che s’io volessi raccontarli tutti, bisognerebbe con più forte lena cominciar di novo a favellare. Ma che pretende con la rammemoranza delle su attioni di fare? Tardi, ahj tardi (mio mal grado) n’accorgo, ch’hò piu tosto riaperta la fresca piaga della tua morte, che sada
f. 8v
saldatale, e raddolcite. Goditi pur tù (Anima benedetta) i gloriosi premij delle tue fatighe, e lascia, che noi travagliamo nelle nostre disaventure. Riposati pur tù ne gl’ameni prati del Cielo, che noi sudaremo nel camimo della valle mortale. Cingiti pur tù dell’honorata palma del paradiso, che noi frà gli sterpi del mondo sentiremo le nostre reità. Arricchisci pur tù ne thesori inhesausti della Beatitudine, mentre noi per la perdita delle tue virtù mendichi, andaremo la nostra povertà con le lagrime consolando. Solleva pur l’afflettione de tanti tuoi vedovi figli, & a questa pregiatissima corona impetra dalli Divini Erarij il colmo della Christiana perfettione, acciò possiamo con l’opere gloriosamente imitarti, come io con la parole t’hò rozzamente lodato.
LAUS DEO “
APPENDICE V
PETRI ANTONII
CORSIGNANI J. C.
DE
VIRIS ILLUSTRIBUS
MARSORUM
LIBER SINGULARIS
Cui etiam Sanctorum, ac Ve-
nerabilium Vitae,
NECNON
Marsicane Inscriptiones accesserunt.
ROMAE MDCCXII. Typis, & sunptibus Antonii de Rubeis
In Platea Cerensi.
SUPERIORUM PERMISSU.
Pag. 412, 413:
“[…] Gentilis de Agello. Agellum sanè oppidulum Cliteniae obnoxium, clarum inter Marsos, ob infraponendos viros insignes ibidem ortos, habetur. Pronunc verò Gentile de Ajel-//Ajello, sive Agello, adnotamus, qui ab Urbano VI. Anno sui Pontificatus seprimo, IV. Kaled. Augusti Marsorum Episcopus Anno M CCC LXXXV. Adlectus est. Exinde translatus ad Ecclesiam Neocastrensem, mox ad Suessanensem. Interfui Concilio Pisano Anni M CD X. Ughellus Ital.[ia] Sac.[ra] tom.[o] IX. Col.563. In Ecclesia verò Marsicanu cum Henrico de Henricis donavit S. Caesidio Ruralem Ecclesiam S. Thomae in Fossa de Villa, de Jure Patronatus Familiae de Henricis, quae in eodem Templo sepulturam Parentum habet, Ughellius, & Phaebon.[ius] In cit. Cathalog. Pag. 33.
Philippus, & Petrus Jannetella
De Agello.
Ex his primus, Episcopus fuit Marsorum, qua dignitate micavit etiam Petrus ex Congregatione Caelestinorum Monachus, ac Prior S.[anti] Eusebii de Urbem ut scripsit Ughellus Ita.[ia] Sacr.[a] tom.[o] VI. Col. 1016., & Phebonius hist.[oria] Mars.[orum] lib. I. pag. 57. Anno M CCC III. Episcopus fuit Civitatis S.[ancti] Angeli Lombardorum[…]”
Pag. 225,226,227,228:
“[…] D.D.[omini] D.[on] Petrus de Ajello, & Franciscus
Maceronus.
Ultra supradictos in pag. 141., & 143. Ajelli Oppido ortos, hi quoque Viri micarunt eximiii, Don Petrus videlicet de Ajello, qui Francorum Monachis disceptantibus, ejectos Monachos a Gallo Generali Abbate, a Romano recipi per Apostolicae
Sedis ordinem curavit, ut Galli praesertim Itali Abbati obendientiam praestarent, unde Generalatus praeeminentiam, quum meret, ita se gessit, ut nullos prò viribus labores aufugiens, nec molestias excutiens, rabidos sui gregis lupos quosdam averterit, & paratus proprium adhuc ponere spiritum, errantium agnita piacula, vel abolere, autr operire sedulus laboravit; sic cruentus Pellicanus plurimos emortuos peccatores, & fratres redivivos erexit, D.[ominus] Coelestino direxit, Vulpemque, jam//jam Christi vineam demolientem, aut exterminare curantem, jubente Domino in Canticis, amicabiliter caepit, demunque non quae sua, sed quae Domini sut, vigil continuò exquisivit: unde etsi sanguine, ignotus, vel, ut reor, haud nimis clarus, propria tamen virtute, semetipsum reddidit illustrem. E’ carnis ergastulo anno Chrsiti M DC VI. die XIII. Novembris spiritum dimettendo, Aquilae in S. Maria Collimadii sepelitur. D.[ominus] Franciscus ex nobili Macerola, sivè Macerona familia ( ex dicto Oppido Agelli oriunda) nuper verò, ex principalibus, Patritiisque Martis, cura Abbatos Julii probatissimi Viri, Celanensis facta; Aliquorum operum ineditorum Auctor, Ordini Coelestinorum operum ineditorum Auctor, Ordini Coelestinorum adscriptus, atque Abbas cum mitra, & baculo pro doctrina, & animi candore creatus M DC XXXVI. Aquilae in d.[etto] Templo novissimum expectat diem, testis M.[utius] Phoeb.[onius] histor.[ia] Marsor.[um] libr.[i] III. cap. VII. pag. 239. quum verò ibidem absque inscriptione tumulo datus fuerit, nos amoris gratia, tantum Praesulem, virtute praestantissimum, hic sequenti elogio justè dignum, decoravimus. D. FRANCISCO MACERONO PATRIT.[IO] MARSO GENERIS CLARITATE, VIRTUTE, MORUMQ.[UE] PROBITATE EXCULTISS.[IMA] CONGREG.[ATIONE] COELEST.[INORUM] S.[ANCTI] BENED.[ICTI] ABBATI DOCTISS.[IMI] HIC M.P. EST ANNO S. CI ). I)CC.XII.( M DC XII n.d.a.) D.//D. Petrus Capocittus, & ejusdem Nepos. Propè verò dictum Oppidum, alterum CC, P. a Fucino distantem Circulum, vulgo (Cerchio) nuncupatum extat, quod fabulosè a Circe genus, & prosapiam jactare volunt, cui nuper Conventum, Eremitarum Discalceatorem S. Augustini accessit. In praedicto Oppido ortus fuit Petrus Capocittus, qui etiam inter Coelestinos adlectus, ad Generalatus apicem inter Coelestinos adlectud, ad Generalatus apicem nemine penitus discrepant, evectus est, unde suo dignè peracto munere, & quibusdam Religionis Regulis, fanctè congestis, octogenarius ab hac vita migravit die V. Novembris anno M D LXVI., & in Templo S.[anctus] Spiritus ad Murronem, sepultus est. Alter quippe ejusdem nominis, & supradicti Nepos, Patrui virtutes emulatus, eidem Ordini splendore, & decore fuit, ut variis dignè prudenter, atque vigilanter expletis Officiis, ad supremum Regimen, non semel, sed quartò ascendere mereret; quinimo ita Relligioni consulti, quod depravatas Constitutiones, atque Relligiosorum aliquot mores corruptos, restaurare attentè curaverit, & ob id nomen Coelestinorum Reformatoris, adeptus est. Non parum Monasteriis auxilium dedit, inter quae illud S.[ancti] Eusebii de Urbe, jam vetustate collapsum, in ampliorem formam redegit; Cujus quidem notitiam illius//illius fundationem continentem, Romae typis evulgavit. Quum autem quinquagenarius scientia, & nomina clarus anno M D LXXXVI. ( Come gioà abbiamo accennato il Nostro morì il 9 febbraio 1587 n.d.r. ) Barlettae in Apulia decessisset, ad Ecclesiam S.[anctus] Spiritus in Murrone, & ad aram paullò ante ab ipso constructam, a D. Donato de Lathona celebri Viro Tarentino, qui in Pastorali Officio eidem successerat, XVI. Kal. Febr. Anno M D XCVI. teste citato Authore hist.[oria] Mars.[orum] pag. 240, translatus est[…]”
PIETRO ANTONIO CORSIGNANI
REGGIA MARSICANA
Parte I
IN NAPOLI M. DCC. XXXVIII
Presso il Parrino
p. 645:
“[…]E quivi anche vedemmo attaccato un’antico cap-/pello verde Prelatizio in memoria di Monsignore,/Giannetelli dell’istessa Terra nativo, il quale fu Ve-/scovo di Santa’Angelo de’ Lombardi […]”
Pag. 647:
“[…] Una delle sue Porte di dice Janatella, dalla vicina/casa del soprallodato Monsignore Jannatelli[…]”
Parte II
p. 387-388:
“[…]AMICO AGNIFILI
Sebben nativo della Terra di Rocca di mezzo, po-/sta ne’ confini de’ Marsi per gire all’Aquila, può/senza dubbio però dirsi Marsicano, non solamente per/la riferita ragione, ma anco perché la detta Terra,/ne’ Marsi un tempo si contenne, o pure per quello/che innanzi nel Terzo Libro di ciò detto abbiamo;/cioè, che quantunque fosse Egli nato nella riferita,/Rocca di mezzo, possiamo ben conghietturare, che/avesse origine da Celano, o almeno dal suo Stato, dove/i suoi Maggiori in alcun tempo v’avessero fatto dimora./La sua origine vien rapportata dal Garimberti nella/Storia de’ Pontefici e Cardinali. Fu Egli da Eu-/genio IV: fatto Cardinale, e poi Vescovo dell’Aquila,/appellato per tanto il Cardinale Aquilano: e tal crea-/zione accadde nll’A. 1431, e nella Consecrazione in/Vescovo Aquilano uno de’ Prealti assistenti fu Pie-/tro Jannetella, della nostra Terra di Aiello, Vescovo/di S. Angelo de’ Lombardi./
Compilò questo Cardinale, come Vescovo dell’/Aquila, il Processo delle Virtù delle gloriose Azioni,/e de’ Miracoli di S. Bernardino da Siena , che/in essa Città tramutò la Vita mortale coll’immortale/gloriosa del Cielo. Perché fu Egli Uomo di gran sa-/pere, gli sortì di avere l’efficace Protezione del car-/dinal Capranica Nobile Romano, di cui fu Segreta-/rio, e Famigliare, e così gli fu aperta la strada alle/Dignità, che con difficoltà si sotengono da coloro i/cui meriti sen giaciono nascosi sotto del Moggio./Favellano di questo gran Porporato l’Ughelli, il/Ciacconio, ed altri, e tutti con degna stima. Ma per-/chè la Famiglia Agnifili si ritirò dappoi nell’Aquila,/aggregata tra’ Nobili di quella Città, perciò gli al-/tri Vescovi ed Uomini illustri, de’ quali da tempo in/tempo è stata feconda, noi qui tralasciamo, essendo/cura di colui, che di quella illustre Città tiene ragio-/namento. E facendo ad Amico ritorno, Egli nell’A-/quila lasciò di vivere, e fu seppellito nella Cattedra-/le, che ha il titolo di S. Massimo, come riferiscono/molti Autori delle sue Geste famose, descritte anche/da Giuseppe Alfieri Patrizio Aquilano ne’ suoi/dotti MSS. ( fin’ora non pubblicati ) che contengono/la Storia della medesima sua celebratissima Patria, e/degli Abruzzi […]”
p. 410:
“[…]PIETRO IANNETELLA, o Giannetelli della/Terra di Aiello fu Vescovo di San Angiolo de’/Lombardi, già Monaco Celestino, e Priore di S. Eu-/sebio di Roma […]”
p.463:
“[…] FRANCESCO MACERONI (o Macerola) di Aiello fu Monaco Celestino, e Abate Mitrato della sua Religione; e del medesimo si legge un Elogio nel nostro Libro degli Uomini Illustri Marsi[…]”
p. 468,469 :
“[…] PIETRO DI AIELLO Terra altre volte nomi-/nata, fu Generale del chiarissimo Ordine de’ Celesti-
ni: Morì nell’A. 1606./PIETRO CAPOCITTO di Cerchio visse Gene-/rale dell’Ordine de’ Celestini nell’A. 1552. Come nel-/le Costituzioni del suo Ordine si legge./PIETRO CAPOCITTO della stessa Terra di Cer-/chio, fu anche Generale de’ Celestini, e morì nell’A./1564. /PIETRO un altro anche CAPOCITTO dell’i-/stesso Paese, Nipote del riferito, fu Abate Mitrato/del medesimo Ordine, e quattro volte Generale. Mo-/rì nell’A. 1587., e di Lui si parla con grande laude,/nelle Costituzioni (3) dell’Ordine suo./PIETRO un altro di Cerchio, senza Cognome, e quarto di tal nome, fu anche Generale de’ Celesti-/ni nell’A. 1582. (4).[…]” ( sono senza dubbio due , come ampiamente detto sopra, i Pietro Capocitto elevati alla carica di Abate Generale dell’Ordine dei Celestini e non 4 come cita il Corsignani. Sicuramente il Nostro autore ha fatto un po’ di confusione con le notizie raccolte. N.d.a.)
p. 557:
“[…] A. 1385
Gentile della terra di Aiello ne’ Marsi del-/lo Stato celanese. E fu Egli, che donò alla Chie-/sa di San Cesidio di Trasacco il Tempio di San/Tommaso in fossa di Villa, di Padronato della Fa-/miglia Errici di Aiello . Fu poi trasferito alla Chiesa di Nicastro in Calabria da Bonifa-/zio IX[…]”
APPENDICE VI
ANDREA DI PIETRO
( Aielli 10.12.1806- Cappelle dei Marsi 26.3.1874 )
“ AGGLOMERAZIONI/DELLE POPOLAZIONI ATTUALI/DELLA/ DIOCESI DEI MARSI/SCRITTE DA D. ANDREA DI PIETRO CANONICO TEOLOGO/DELLA CATTEDRALE DEI MARSI RESIDENTE/IN PESCINA “/AVEZZANO/TIPOGRAFIA MARSICANA/di Vincenzo Magagnini/1869,
Pag. 61:
“[…] 8.° Il medesimo paese di Cerchio, o per dir meglio,/gli abitanti del villaggio di Patiano riunito a Cerchio hanno/dato la culla a due Generali Celestini. Il primo di essi chiamato/D. Pietro Capoccetti, per opera del Cardinale del Monte Arcive-/scovo di Siponto, assunto poi al trono Pontificio che ne/avea conosciuti i sommi meriti assai da vicino, da Abate/Celestino domiciliato in Siponto, fù elevato alla carica su-/blime di Generale di quell’Ordine tanto distinto. Quindi ai/6 di Novembre 1566 dopa aver compita l’età/di anni 80, morì, e fù sepolto nella Chiesa di Santo-Spirito/al Morrone./Il secondo nominato pure D. Pietro Capoccetti, nipote/del primo di cui aveva ereditate ed anche superate le belle/virtù, meritò per quattro volte essere precelto a Generale/di quell’Ordine cospicuo, di cui, per le diverse Costituzioni/emanate all’oggetto, fù detto il riformatore. Liberò l’Ordine/intiero dai diversi ordini che ave contratti; rinnovò in Roma/dei fondamenti il Monastero di S. Eusebio; ed infine nel-/l’anno 1586 morì in Barletta di Puglia nell’età di 58/anni e per cura del suo successore fù sepolto nella medesima/Chiesa di S. Spirito, nella Cappella che poco prima di/morire aveva eretta a sue spese.(1)[…]”
pp.153-154:
“[…] 8°.Dice il Febonio che il paese di Ajelli, sebbene/sia piccolo, è noto per fama avendo dati alla luce molti/uomini illustri. Fra questi riporta I°. Monsignore Gentile creato/Vescovo dei Marsi nel tempo del grande scisma di Occi-/dente da Urbano VI°. Traslocato nella Chiesa di Nicastro/ai 12 Novembre dell’anno 1399. II°. Monsignor D. Pietro/Jannetella, creato Vescovo di S. Angelo dei Lombardi./III°. D. Pietro di Ajelli Abate dei Celestini il quale sedò le/scissure fra i Monaci Celestini Francesi e gl’Italiani, ed ot-/tenne la sentenza finale che decise dovessero gli uni e gli/altri obbedire all’Abate Italiano. Morì in Aquila, e fu sepolto nella Chiesa di Collemaggio. IV°. D.Francesco Mace-/rola che nell’anno 1614 fu venerato Abate Celestino della Pro-/vincia Aquilana; quindi fu Abate della Provincia Romana,/ed in Ultimo nell’anno 1636 morì in Aquila, e fu sepolto/nella medesima Chiesa di Colle-maggio[…]” (2)
Andrea Di Pietro
(1806-1874)
“ CATALOGO/DEI/VESCOVI DELLA DIOCESI DEI MARSI/SCRITTO/DA D. ANDREA DI PIETRO CANONICO TEOLOGO/DELLA CATTEDRALE DI PESCINA “/AVEZZANO/Tip. Marsicana di V. Magagnini/1872, pp.122-125:
“(…)1°.Nel giorno 29 del mese di Luglio dell’anno 1385/quando ricorreva l’anno settimo del Pontificato di Urba-/no VI., Gentile nativo di Aielli in Diocesi dei Marsi che/era Canonico di S. Sebastiano paese della stessa Diocesi/fu creato Vescovo dei Marsi./2°. Da un legale istrumento esistente nell’Archivio/Capitolare di Trasacco stipulato dal Notaio Andrea/di Luca di Casalvieri ai 5 Novembre dell’anno 1387/costa che lo stesso Vescovo Gentile il quale era suben-/trato nei dritti della famiglia de Henricis di Aielli sua/patria, unito ad Errico de Henricis di Trasacco, ma/discendente della stessa famiglia di Aielli, donasse libe-/ramente alla Chiesa di S. Cesidio di quel Comune di Tra-/sacco la Chiesa rurale di S. Tommaso della villa, edifi-/cata e dotata dai suoi antecessori nel medesimo Comune/di Trasacco coi pesi che vi erano annessi, cioè di cin-/que messe da celebrarsi in ogni settimana, e di annue/coppe sei di orzo con carlini quindici da pagarsi al Ve/scovo per i dritti di Procure e Cattedratico./3°. Dippiù, giusta l’atto legale che esiste nell’Ar-/chivio Vescovile dei Marsi, il medesimo Vescovo Gen-/tile col suo Capitolo Marsicano, ebbero in considerazione/i meriti personali di Antonio, Giovanni e Guglielmo figli/del nobil uomo Cola di Giovanni della Rocca di Pescina,/ed accettarono, e confermarono la compra che il nomi-/nato Cola avea fatta ai 25 Agosto dell’anno 1397 pel/prezzo di docati 37 di una vigna nel locale detto S. Gior-/gio, e di una canapina nel locale detto la Pescara teni-/menti della città Marsia, vigna e canapina che erano/di proprietà della Chiesa dei Marsi alla quale si obbliga-/rono pagare in perpetuo annui ducati sette nella festa di/S.a Sabina./4°. Molte Bolle di questo Vescovo si conservano nel-/L’Archivio dei Marsi, fatte fino al giorno 12/di Novembre dell’anno 1399 quando Bonifacio IX lo tra-/slocò nella Chiesa di Nicastro in Calabria, dove morì./5°. A premura di questo Vescovo, il Pontefice Bo-/nifacio IX. Ai 11 di Luglio dell’anno 1399 concesse in/perpetuo le stesse indulgenze che ai 2. di Agosto si lucra-/no da quei che visitano la Chiesa della Madonna degli/Angeli detta della Porziuncola in Assisi, a chiunque ai/15 di Agosto di ogni anno, incominciando dai primi/vesperi fino a tutto il giorno della festa, confessato e/comunicato visita la Cattedrale dei Marsi (…)”
Note
- La chiesa fu distrutta nel terremto del 1703.
- Il Di Pietro riporta le notizie del Febonio circa la morte di D. Pietro di Aielli il quale ”[…]Morì in Aquila, e fu sepolto nella chiesa di Collemaggio. Ad un primo esame non sembra esser sepolto in tale menzionata chiesa, per quanto, invece, riguarda D. Francesco Macerola è più esatto questi, infatti, è attualmente ancora sepolto all’Aquila, nella chiesa di Collemaggio erra però la data di morte. Il nostro infatti morì nel 1640 come chiaramente si evince nelle “ ESSEQUIE FUNERALI Fatte nella Regia Chiesa di Collemaggio. In morte del Reverendissimo Padre DON FRANCESCO D’AIELLI. Vicario Generale de Celestini, e Co-Abbate nel detto Monasterio, Nel dì 17 d’Aprile 1640. Nell’Aquila, per Francesco Marino, 1640 Con licenza de’ Superiori.”.
APPENDICE VII
Fiorenzo AMICONI
“ Storia della Madonna delle Grazie/in Cerchio (Aq)/(documenti) ”
s.c.e.(ma De Crisofaro Editore, Roma ) s. d. ( ma 1996 )
pp. 58-63:
“(…)Inventario della Libreria
Opere di S. Agostino in foglietto Tom: 12
Opera omnia di S. Girolamo in foglio Tom: 7
Opera di S. Gregorio Magno in foglio Tom: 3
S. Gio: Crisostomo opera in quarto Tom: 5
S. Anselmo opera in quarto Tom: 1
Esposizione di S. Tommaso in Apocalipsi in quarto Tom: 1
S. Tommaso d’Aquino Catena aurea Tom: 1
Sermoni di S. Vincenzo in ottavo Tom: 1
Opera di S. Bernardo in quarto Tom: 2
Omilia di S. Pier Crisologo in ottavo Tom: 1
S. Francesco Liber Confirmitatum in foglio Tom: 1
Origene opera omnia in foglio Tom: 1
Sagro Teatro della Bilia, ed altro del Padre Lorenzo
da S. Francesco in foglio Tom: 3
Matteo Cantacurzeni in canticum Canticorum in foglio Tom: 1
Diego Stella Opera in Lucem in quarto Tom: 2
Ettore Pinto opera in Danielem in ottavo Tom: 1
Padre Diego da Baerza commentario morale opera in quarto Tom: 2
Padre Gio:Ferdinando commentario in Ecclesiastes in foglio Tom: 1
Opera del Pas Sopra l’Evangelico in foglio Tom: 3
Fra Antonio de Gislandis opus aureum in quarto Tom: 1
Poliantea Mariana di Mastacci in foglio Tom: 1
Gabriello da S. Vincenzo in Summam Angelicam in foglio Tom: 2
Opera di Carlo Tomassio in foglio Tom: 1
Medicina in tertiam partem Divi Thome in foglio Tom: 1
S. Bonaventura opera Sententiarum Tom: 3
Padre Blasio della Purificazione trattato de adoratione in fog. Tom: 1
Padre Andrea della Croce disputazione nella prima parte
di S. Tommaso in foglio Tom: 1
Beccani Summa Teologie Scolastiche in ottavo Tom: 4
Compendio Manuale di detto Autore de fide, et Religione libercolo Tom: 1
Aristotile Stagirita Topicorum libri otto in foglio Tom: 1
Lo Stesso Autore Phisicorum otto in quarto Tom: 1
Opere di Gio:Duns Scoti in foglio Tom: 2
Commentario di S. Tommaso d’Aquino in Libros Aristotilis in foglio Tom: 1
Commentario di Paolo Veneto de Anima in foglio Tom: 1
Commentario del Padre Grammatico in
libros posteriorum Aristotilis in foglio Tom: 1
Commentario di Vicomercati in Aristotilem in foglio Tom: 1
Opere di Armonio Ermeso, ossiano Commenatarj
sù i libri di Aristotile, o di Porfirio in foglio Tom: 2
Difese Teologiche di Capriolo in foglio Tom: 3
Commentari del Collegio comibricense in foglio Tom: 3
Suessa Super libros de Anime in foglio Tom: 1
Ruvio de Anima, Celo, et Mundo, Logica, et Phisica in foglietto Tom: 4
Logica detto Colleggio Conibricense in foglietto Tom: 1
Dialettica Aristotelica di Francesco Toleto in foglietto Tom: 1
Commentarj di Francesco Toleto ne’ libri
di Aristotile de Anima in foglietto Tom: 2
Dialettica di Francesco Titelman in quarto Tom: 1
Opere di Crisostomo Javelli in ottavo Tom: 11
Modi di Argomentare di Nicola Evatardo in ottavo Tom: 1
Opere di Paolo Veneto in foglio Tom: 2
Hores Philosophie in quarto Tom: 1
Clavis Regia Sacerdotum in foglio Tom: 1
Opera di Bonacina in foglio Tom: 6
Summa Diana Ausonis in quarto Tom: 1
Summa Rodriques in quarto Tom: 1
Somma Pisanelli in quarto Tom: 1
Giulio Claro Sententiarum in Sudicio Criminali in quarto Tom: 1
Candelabrum Aureum Ecclesie Sancte Dei in quarto Tom: 1
Questiones Diane in foglio Tom: 2
Padre Ottavio Worst in quarto Tom: 1
Questiones Regulares, et Canonice Pry Roderci in foglio Tom: 2
Manuale Confessariorum Navam in quarto Tom: 1
Fasciculus Forum Moralium P. Bontempij in foglio Tom: 1
Controversiam Alberto Compensis in quarto Tom: 1
Adriano Quod libetarum questionum in ottavo Tom: 1
Methodus Confessionis opusculum, sive liberculus Tom: 1
Fioreto di S. Bernardo di Chiaravalle col Commento
di Gio:Gessoni in quarto Tom: 1
Da Sacramento Penitentie opera del Padre Serafini in foglio Tom: 1
Faccendez trattato su i precetti della Chiesa in foglio Tom: 1
Lyman Teologia Morale in foglio Tom: 1
Giardino de’ Sommisti in quarto Tom: 3
Formulario de’ Strumenti per i Procuratori, ed Avvocati in quarto Tom: 1
Giustiniano Institutiones Juris Civilis in quarto Tom: 1
Timoteo de Timotheis responsa in quarto Tom: 1
Formulario Adovcatorum, et Procuratorum in ottavo Tom: 1
Trattato de Jure Prothomiseos di Afflitto in ottavo Tom: 1
Tranquillo Ambrosino Processus informativus in ottavo Tom: 1
Sebastiano Branti titulorum Juris Civilis, et Canonici in ottavo Tom: 1
Flores Legum in ottavo Tom: 1
Summa Azonis Juris Consulti in quarto Tom: 1
Marco Paulo de authoritate pallii Pontifici in quarto Tom: 1
Ricciullo de Jure Personarum in foglio Tom: 1
Montecatino in libros Ploiticorum Aristotilis in foglio Tom: 1
Serto de’ decreti di Bonifacio Ottavo Tom: 3
Item Decretali di S. Gregorio nono Tom: 3
Item Decretali di Graziano in quarto Tom: 3
Padre Maurizio della Madre di Dio= opera
con cui si dimostra la Riforma degli Austiniani Scalzi in quarto Tom: 1
De Doctrina Christiana S. Augustini Episcopi in ottavo Tom: 1
Ragguaglio di Parnaso di Trajano Boccalini in ottavo Tom: 1
Manoscritto de Censuris in ottavo Tom: 1
Il Concilio di Trento libercolo Tom: 1
La vita, e lodi di S. Agosetino (sic) libercolo Tom: 1
Domenico Marco Hyerolexicon in foglio Tom: 1
La Vita del Cardinal Bellarmini in quarto Tom: 1
Gaimbattista Hodeirna Mediceorum Ephemerides in quarto Tom: 1
Svetonio Vita deli Imperatori Romani in foglio Tom: 1
Vita de’ Santi incognito Autore in foglio Tom: 1
Commentario su i quattro Libri de’ Re d’Israello, Lacero in foglio Tom: 1
Stori generale di S. Domenico del Padre Ferdinando
del Castiglio in foglio Tom: 1
Il Padre Platina in foglio Tom: 1
Ruberto d’Alezze specchio della Fede in foglio Tom: 1
Montecatino Antonio Tom: 1
Fra Felice Potestà esame Ecclesiastico in quarto Tom: 1
Filosofia del Padre Raffaelle Aversa in quarto Tom: 1
Nicola Aussini de eloquentia Sacra, et humana in quarto Tom: 1
Padre Davide da S. Maria Bulle, et decreta
ad escalceatos spectantia in quarto Tom: 1
Raccolta di tutti i Poeti Latini in quarto Tom: 1
Teologia mistica di Enrico Harfio in quarto Tom: 1
De voragine Sanctuarii in quarto Tom: 1
Giannantonio Pantusa Commentarium
in Epistolam ad Romanos in quarto Tom: 1
Lezioni sopra il Passio di S. Giovanni in quarto Tom: 1
Logica del Padre Raffaelle Aversa in quarto Tom: 1
Toleto Instructio Sacerdotum in quarto Tom: 1
Martirologio di S. Gregorio XIII in quarto Tom: 1
Sylve morales in quarto Tom: 1
Il Serraglio delli Stupori del mondo in quarto Tom: 1
Epistole familiari di Cicerone colle note in foglio Tom: 1
Un Calepino vecchio in foglio Tom: 1
Il Petrarca in ottavo Tom: 1
Il Compendio degli Annali Ecclesiastici del Baronio in ottavo Tom: 1
Opuscolo di Plutarco on ottavo Tom: 1
Osservazioni politiche appartenenti a governi di Stato in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre reina in quarto Tom: 1
Quaresimale del padre Zamora in quarto Tom: 1
Discorsi, seu quaresimale del Padre Nisseno in quarto Tom: 2
Quaresimale del Padre Avendagno in quarto Tom: 1
Discorsi del Padre Diego Lopez in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Paletti in quarto Tom: 1
Prediche, e quaresimale del padre Albrizio in quarto Tom: 2
Quaresimale del Padre Valda……in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Gubernatis in quarto Tom: 1
Prediche del Padre Gori in quarto Tom: 1
Discorsi del Gallo in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Pepe in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Fedele in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Giuliani in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Antero Maria in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Calamti in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Sommi in quarto Tom: 1
Prediche del Crule in quarto Tom: 1
Annale del Nisseno in quarto Tom: 1
Pensieri predicabili del Padre Paolacci in quarto Tom: 1
Prediche del Mendacia in quarto Tom: 1
L’Orario del Padre Ambroggio in quarto Tom: 2
Discorsi del Paoletti in quarto Tom: 2
Discorsi del Padre Fonzeca in quarto Tom: 3
Discorsi del Padre Bezzi in quarto Tom: 1
Ragionamenti di Giuseppe Silos in quarto Tom: 1
Le Cifre del Roccamorra in quarto Tom: 3
Avvento Laureano del Maccaria in foglio Tom: 1
L’Ave Maria del Padre Andrea in quarto Tom: 1
Mariale del Padre Maurilio in quarto Tom: 1
Mariale dell’Avvendagno in quarto Tom: 2
Panegirici del Fedele in quarto Tom: 1
Paradossi dello Sperelli in quarto Tom: 2
Sermoni del Purgatorio del Pistacchi in quarto Tom: 1
Purgatorio del Lugulani in quarto Tom: 1
Li riflessi della Santissima Trinità in quarto Tom: 2
Prediche del Calamati in quarto Tom: 2
Discorsi del Mastrilli Sulla Passione di Cristo in quarto Tom: 1
Lezioni del Padre Giangregorio in quarto Tom: 7
Maeza prodigi del fuoco in quarto Tom: 1
Discorsi dell’Averoni in quarto Tom: 1
Discorsi del Padre Eustachio in quarto Tom: 1
Glorie di Maria del Gilberti in quarto Tom: 3
Opere del Nisseno in quarto Tom: 2
Sermoni del Padre Filucci in ottavo Tom: 1
Prediche della Cattedra di S. Pietro in quarto Tom: 1
Opere del Padre Oponio in ottavo Tom: 3
Lazzaretto del Padre Antero in quarto Tom: 1
Sermoni del santuario dell’Oponio in quarto Tom: 1
Sermoni del Barrete in ottavo Tom: 1
Concioni del Padre Granata in ottavo Tom: 1
Opere del Vega in ottavo Tom: 1
Sermoni del Padre Guglielmo Pepin in ottavo Tom: 1
Sermones Discipuli in quarto Tom: 1
Sermones Tauleri in ottavo Tom: 1
Concetti Teologici in ottavo Tom: 1
Thesauri Concionatem in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Gregorio da Montecorvino in quarto Tom: 1
Prontuario morale in ottavo Tom: 1
Lopez Epitome Sanctorum in foglio Tom: 3
Discorsi del Lopez in quarto Tom: 1
Quaresimale del Padre Savina in quarto Tom: 1
La Somma di S. Tommaso in foglio Tom: 4
Problemi di Aristotile in foglio Tom: 1
Caroli Tomasci Arbor uberrima Sacre Doctrine in foglio Tom: 1
Morali del Padre Batoli in foglio Tom: 1
Biblia Sagra in foglio Tom: 1
Conciliazioni della Chiesa Armena colla Romania in foglio Tom: 1
Opera di Gio:Duns Scoto in foglio Tom: 1
Liranj Sopra li Evangely in foglio Tom: 1
Ricciullo Trattato de Personis in foglio Tom: 2
Padre Ignazio da S. Maria in quarto Tom: 3
Padre Ottavio Maria Opera omnia in quarto Tom: 2
Vita di S. Tommaso da Villanova in quarto Tom: 1
Opere del padre Calino Lezioni Sagre, e discorsi Spirituali
coll’opuscolo del Giovinetto Giuseppe in ottavo Tom:13
Quaresimale del Padre Ambrosio Eremita in ottavo Tom: 1
Pane quotidiano, e diario Sagro del Padre Marquio in ottavo Tom: 6
Guida del Peccatore del Gisolfo in ottavo Tom: 6
Logica del Javelli in ottavo Tom: 1
Orazioni Sagre dell’Azzolini in quarto Tom: 1
Metafisica del Javelli in ottavo Tom: 1
S. Agostino ad Valentinum de gratia, et de libero arbitrio in ottavo Tom: 1
Homilia dell’Aimone in Evangelia Dominicalia in ottavo Tom: 1
Summa decreti in quarto Tom: 1
Organum Aristotilis in ottavo Tom: 1
Marci Tullii Ciceronis philosophia in quarto Tom: 1
Iter Celi del Puerono in quarto Tom: 1
Cerimoniale Ecclesiastico in quarto Tom: 1
Prediche di Monsignore Cornelio Musso in quarto Tom: 1
Panegirici del Pauluccio in ottavo Tom: 1
Indie nuove delle virtù della Vergine Santissima in quarto Tom: 1
De Conservatorum Authoritate Regularibus del Secinara, liberculus Tom: 1
Lelio Pellegrino de affectionibus animi in quarto Tom: 1
Il Pergamini da Fossambrone trattato della Lingua in ottavo Tom: 1
Il Bajardi omilia in ottavo Tom: 2
Flores totius Sacre Teologie in quarto Tom: 1
Il Marinarj opera in materia di grazia in quarto Tom: 1
Il Brandolini de Ratione Scribendi in quarto Tom: 1
Prediche del Padre Sommi in quarto Tom: 1
Dante Aligeri (sic) coll’esposizione di Alessandro Vellutelli in quarto Tom: 1
L’Erbario del Durante in foglio Tom: 1
Opere di Terenzio colle note in foglio Tom: 1
Cento cinquantaquattro libri varj di diverse materie di poca
considerazione riposti nella Scanzia Superiore a mano
destra nell’entrarsi alla Libreria (…)”.
APPENDICE VII
Maria Rita BERARDI
UNA DIOCESI DI CONFINE TRA REGNO DI NAPOLI E STATO PONTIFICIO
Documenti e regesti del fondo pergamenaceo
della Curia Vescovile dei Marsi
(secc. XIII-XVI )
Deputazione Abruzzese di Storia Patria- Edizioni Libreria Colacchi L’Aquila
Tipografia G.T.E. s.r.l. L’Aquila, 2005
pp. 80-82:
“[…] XXII
1471 dicembre 2, pont. Sisto IV a. 1
Roma
Papa Sisto IV, poiché per la morte del prevosto Felice Teo si è resa/vacante la prepositura della chiesa di S. Felicita di Collarmele/riservata all’autorità apostolica e ne ha conferito il beneficio a Nicola Ruggeri di Collarmele, dà mandato al vescovo dell’Aquila (Amico Agnifili) e al prevosto della chiesa di S. Giovanni/di Pentima, vicario generale del vescovo dei Marsi, di immette-/re il predetto prevosto Nicola nel possesso materiale della chiesa/di S. Felicita, agendo in comune o separatamente, non appena/avrà presentata ad essi l’epistola di nomina.[…]”